Luigi Anepeta
LA POLITICA DEL SUPER-IO
Fondamenti di psicopatologia strutturale e dialettica
Introduzione alla lettura
Questo è il testo integrale de La politica del Super-Io, pubblicato da Armando nel 1992 e ormai irreperibile, in quanto le copie residue della prima edizione (circa 600, che io sappia, su 1000) sono state inviate al macero. E’ un libro che mi è caro, nonostante i suoi limiti, perché in esso risuona lo sforzo di ricerca durato 5 anni - dal 1982 al 1987 - documentato dai Seminari.
L'ipotesi di fondo della ricerca di un nuovo modello psicopatologico avviata, per l’appunto, nel 1982 verteva sulla possibilità di dimostrare, partendo dai dati clinici, l'importanza dei fattori storico-sociali e culturali nella struttura profonda della personalità. Si trattava di un'ipotesi azzardata perché la tradizione psicoanalitica, recependo peraltro un pregiudizio proprio della mentalità corrente, dava per scontato che, allontanandosi dalla sfera della coscienza, l'esperienza psichica dovesse essere caratterizzata e determinata da aspetti ancestrali, filogenetici, poco o punto permeabili ai fattori storico-sociali. L'ES freudiano ha ufficializzato questo pregiudizio. Jung, pur contrario all'ipotesi pulsionale, ha dovuto cedere alla presunta evidenza dell'irrazionalità dell'inconscio introducendo il concetto di Ombra.
Per quanto azzardata, l'ipotesi di fondo della ricerca non era ideologica, vale a dire non si riconduceva ad un principio sociologista, bensì ad una lunga riflessione su Darwin e su Marx. Gli esiti di questa riflessione erano sostanzialmente due. Primo: come essere naturale, vale a dire dotato di un cervello evoluto, l'uomo deve avere una maggiore affinità con le specie animali sociali, in primis le scimmie, che non con le specie governate dagli istinti. Secondo: come animale culturale, l'uomo non nasce dal ventre della natura, bensì dal ventre della società: come ente sociale, dunque, prima che come individuo.
Per dare corpo all'ipotesi, occorreva solo identificare la funzione psichica che attestasse la presenza del sociale nella struttura psichica profonda della soggettività umana. L'identificazione era già avvenuta con la scoperta del Super-io da parte di Freud, ma questi, fermo ad una teoria pulsionale della natura umana, aveva adattato quella scoperta a tale teoria, di fatto ideologica, giungendo a sostenere che il sociale viene interiorizzato contro la resistenza della natura umana, votata in sé e per sé all'anarchia, unicamente per effetto dell'angoscia di un'esclusione o di una rappresaglia.
La teoria di Freud ha una comprensibilità storica. Se si parte dal presupposto che l'individuo, col suo innato egoismo, preesiste alla società, la vita associativa non può nascere che in virtù di una frustrazione e di una repressione dei desideri individuali. Il problema è che la preesistenza dell'individuo rispetto al sociale è una proiezione del presente nel passato. L'uomo non nasce come individuo, bensì come ente sociale. La definizione dell'individualità, vale a dire l'acquisizione della consapevolezza di un'identità distinta da tutte le altre, è un fatto storico che sopravviene dopo un lunghissimo periodo caratterizzato dal primato pressoché assoluto del sociale. Alla luce di questa evidenza, comprovata da tutti gli studi antropologici sulle comunità primitive, la teoria del super-io postulava di essere riformulata dalle fondamenta.
La riformulazione, che rappresenta l'asse portante de La politica del Super-io, non può prescindere dall'attribuire all'uomo un bisogno innato di socialità, che promuove l'organizzazione sociale e l'interiorizzazione della cultura prodotta collettivamente. Dato che la socializzazione e l'interiorizzazione dei valori culturali propri di un determinato contesto storico è il presupposto dell'affiorare della coscienza individuale, il primato del sociale nell'organizzazione psichica umana riesce evidente. Tale primato pone però un problema di ordine teorico. Se esso infatti è profondamente radicato nell'inconscio, comportando il riferimento all'individualità solo come parte di un tutto, da dove proviene la coscienza dell'individualità come entità distinta, dotata di suoi bisogni, di suoi diritti e di una volontà propria?
L'ipotesi più semplice porterebbe a pensare che l'individualità sia un prodotto storico, vale a dire il prodotto di una società - quella borghese - che ha giuridicamente definito i diritti dell'individuo. Si tratta però di un'ipotesi insostenibile. Primo, perché essa misconosce un'evoluzione storica sotterranea che risale almeno alla civiltà greca. Secondo, perché la storia è una levatrice che non può fare venire nulla alla luce che non sia rappresentato nel corredo genetico umano sotto forma di potenzialità. Tenendo conto di questo, riesce evidente che la natura umana, oltre al bisogno di socialità, deve contenere un altro bisogno che promuove la definizione e la differenziazione dell'identità individuale. Tale bisogno era già stato scoperto da Jung sotto forma di principio d'individuazione. Si trattava dunque di darne solo una più precisa definizione teorica, di illustrarne le modalità con cui si realizza nel corso dell'evoluzione della personalità e di sottolineare il ruolo dinamico che svolge nella personalità adulta.
Queste riflessioni, corroborate dalla pratica clinica, portarono, a dire il vero lentamente, ad attribuire alla natura umana due bisogni intrinseci, cioè geneticamente determinati: il bisogno d'appartenenza/integrazione sociale e il bisogno d'opposizione/individuazione.
La teoria dei bisogni, formulata autonomamente a partire da frammenti di verità già presenti nella tradizione analitica, rappresenta la chiave del nuovo modello psicopatologico messo a fuoco ne La politica del Super-io. Il modello comporta una tensione dialettica tra il bisogno di socialità e il bisogno d'individuazione, che sottende l'evoluzione della personalità e la struttura della soggettività adulta. Tale tensione, in conseguenza delle interazioni con l'ambiente, può dare luogo ad una scissione e ad un'opposizione irriducibile tra i bisogni, vale a dire ad un conflitto strutturale che, contrapponendo la volontà altrui a quella propria, i doveri sociali ai diritti individuali sul registro dell'incompatibilità, produce a livello fenomenico la sintomatologia psicopatologica.
Tale sintomatologia, data la struttura del conflitto che la sottende, si riconduce a due configurazioni elementari: l'una caratterizzata dalla prevalenza dinamica del Super-io, l'altra dalla prevalenza dinamica dell’Io antitetico.
All'epoca in cui è stato redatto il saggio, mentre la teoria dei bisogni era sufficientemente chiara, il problema delle funzioni psichiche che si edificano sulla base di essi giungendo a strutturare l'inconscio non lo era che parzialmente. In particolare non riuscivo a trovare una denominazione adeguata per la funzione psichica edificata sulla base del bisogno d'individuazione. Solo dopo qualche anno sono giunto a denominare e a concettualizzare adeguatamente questa funzione - l’Io antitetico. Ciò spiega una certa confusione del saggio laddove si affronta questo problema, che viene ricondotto agli ideali dell'Io o al bisogno d'individuazione frustrato.
Per rimediare a questa confusione, consiglierei il lettore di consultare anticipatamente il capitolo de La miseria della neopsichiatria che espone in forma compiuta la teoria struttural-dialettica della personalità.
Pur con questo limite, linguistico più che concettuale, La politica del super-io rimane, a mio giudizio, un saggio di grande suggestione. In particolare l'analisi dei codici mentali neoliberali, per quanto sintetica, risulta, a distanza di anni, sorprendentemente pregnante e attuale. La previsione che la diffusione sociologica del codice anestetico avrebbe prodotto un cambiamento piuttosto rilevante della psicopatologia, soprattutto a livello giovanile, è stata ed è confermata, in maniera inquietante, dalla clinica e si riflette in un progressivo degrado delle relazioni sociali e interpersonali all'interno della nostra società. In conseguenza di questo codice culturale, funzionale a a mantenere un equilibrio sociale fondato sulla legge del più forte, i valori superegoici, di origine religiosa e laica, risultano sempre più astratti in rapporto al modo concreto in cui le persone si rapportano reciprocamente, contrassegnato dall'oggettivazione dell'altro e dalla tendenza a considerarlo un rivale piuttosto che un sodale.
Nonostante la suggestione, La politica del Super-io è un saggio di ardua lettura in conseguenza di una forma stilistica troppo densa e di un linguaggio "specialistico". Questo limite non va ricondotto ad un'esplicita volontà di misurarmi su di un registro accademico, bensì alla necessità di sintetizzare in poche pagine una ricerca teorica di parecchi anni. Il lettore che, prima di consultare il saggio, avrà la pazienza di leggere, nella sezione Archivio, i seminari che, dal 1982 al 1986, ne hanno preceduto la stesura, se ne renderà conto.
Tre anni fa (nel 2005) ho scritto una nuova versione de La politica del Super-Io il cui titolo è Appartenenza e Individuazione, di cui ho pubblicato sul sito l'Introduzione, nell'attesa (remota) di una pubblicazione.
Sommario
Introduzione
Capitolo primo: La scoperta del Super-lo e il problema della doppia identità
Capitolo secondo: Il mito gerarchico
Capitolo terzo: Integrazione sociale e opposizione
Capitolo quarto: Dialettica dei bisogni
1. Teoria dei bisogni e antropologia filosofica
2. Teoria dei bisogni e neurobiologia
3. Teoria dei bisogni e psicologia evolutiva
Capitolo quinto: Eteronomia, antinomia, autonomia
Capitolo sesto: Strutture psicopatologiche
1. La struttura ossessiva
2. La struttura isterica
3. Gradienti strutturali
4. La struttura depressiva e maniacale
5. La struttura delirante
Capitolo settimo: Ideologie sociali, codici di normalizzazione e psicopatologia
1. Il codice adultomorfo.
2. Il codice rupofobico.
3. codice claustrofobico.
4. Il codice anestetico
Capitolo ottavo: Sistemi interattivi ed esperienze psicopatologiche
Capitolo nono: La politica del Super-lo
Glossario
Bibliografia
Ringraziamenti
Ringrazio il prof. Alberto Caracciolo, il prof. Luigi CancriniI, il prof. Giovanni Jervis, il prof. Cristiano Castelfranchi e il prof. Renzo Canestrari che hanno letto attentamente il manoscritto e sono stati prodighi di apprezzamenti, critiche e suggerimenti utili.
Al prof. Leonardo Ancona che, all’epoca in cui ero studente, mi schiuse gli orizzonti della psichiatria dinamica, devo, a distanza di anni, una prova indimenticabile di apertura critica nei confronti di un’elaborazione teorica autonoma.
Senza il sostegno affettuoso e il contributo dialettico di un gruppo di operatori con i quali ho lavorato in ospedale psichiatrico e con i quali ho discusso punto per punto gli sviluppi della ricerca, il saggio non avrebbe visto la luce. Il debito nei loro confronti sarebbe modestamente ripagato dal nominarli.
Ad uno di essi, Fiore Bruno, che si è assunto negli anni l’onere dell’organizzazione della ricerca, va riconosciuto il merito di aver corroborato, con la sua fiducia, un lavoro teorico non immune da dubbi.
Ancor più devo a coloro che, rendendomi partecipe della loro sofferenza, mi hanno permesso di intravedere, al di là dei drammi personali e familiari, la matrice che li genera.
Eleggendo una di loro al ruolo di protagonista, spero di estinguere il debito al quale essa, cristallizzata nel suo nobile delirio di colpa e di rivendicazione di giustizia, periodicamente mi richiama: non già di aiutarla a dispiegare la sua opposizione, ineluttabilmente colpevolizzata, bensì di informare la “gente” di essere pronta a riparare. So che i suoi persecutori, quelli interni - vivi e implacabili - e quelli reali - i morti e le loro tradizioni -, non possono recepire il messaggio. Ma Paola, rappresentante dei tanti testimoni che condividono il suo stesso dramma, ha ben diritto che la sua voce, se non un’impossibile risposta, riceva almeno ascolto.
Introduzione
1. Primo momento di sintesi di una ricerca sui fenomeni psicopatologici, orientata a delineare un sistema teorico incentrato sulla dialettica dei bisogni umani in rapporto agli ambienti socioculturali, questo saggio richiede alcune notizie introduttive atte ad illustrare i postulati della ricerca, a definirne la collocazione nel quadro dell’attuale pensiero psichiatrico, e a rimarcare i nessi e le soluzioni di continuità rispetto al movimento antistituzionale italiano.
Quanto a quest’ultimo, il debito è fuor di dubbio. La ricerca si è originata dal prendere atto dell’irrimediabilità della rottura epistemologica del paradigma psichiatrico tradizionale che quel movimento ha prodotto, e dal recepire, con la necessità di una nuova pratica assistenziale, l’urgenza di un nuovo paradigma. La messa tra parentesi dello “specifico” psicopatologico, promossa tatticamente da Basaglia ma trasformatasi nel corso degli anni in una ideologica proscrizione di ogni tentativo di teorizzazione, ha finito con il vincolare le energie del movimento ad un progetto, chiaro solo nella sua antitesi che, a livello territoriale, ha incontrato e incontra non poche difficoltà di realizzazione. Se è pretestuoso sottovalutare le resistenze oggettive contro cui quel progetto è venuto ad urtare dagli interessi politico-amministrativi e corporativi che gravano sulla sanità ai pregiudizi tuttora diffusi a livello di corpo sociale - occorre riconoscere che, nell’intento di superarle,il movimento alternativo, laddove sopravvive, ha assunto un carattere volontaristico, che lo ha distolto dal compito, apparso urgente già a metà degli anni ‘70, di produrre, attraverso la pratica, un nuovo paradigma psichiatrico. Ciò non significa che questa pratica procede senza riferimenti teorici: essa, di fatto, si fonda sull’ideologia antistituzionale, che, confrontandosi a livello territoriale con disagi che affiorano negli interstizi di istituzioni - la famiglia, la scuola, l’ambiente di lavoro, ecc. - apparentemente normofunzionanti, non può impedire il proliferare, nei servizi, delle “tecniche” terapeutiche le più diverse e il sovrapporsi di linee di intervento spesso poco compatibili. Non v’è, pertanto, da sorprendersi che questo disordine, recepito dall’opinione pubblica nonostante gli indubbi progressi dell’assistenza rispetto al modello manicomiale, abbia contribuito ad una riorganizzazione ideologica della psichiatria che, in nome di una non sopita medicalizzazione dei fenomeni psicopatologici, ha riproposto, con enfasi crescente nel corso degli anni ‘80, il problema dello “specifico”psicopatologico. Tale riproposizione postula che il problema sia delegato ai “tecnici” e sia affrontato in sedi opportune (riviste, libri specialistici, congressi, scuole di specializzazione, ecc.) con metodi, linguaggi e procedure atti a porre fuori gioco la coscienza sociale e a passivizzarla. Complementari a tal fine sono le ricorrenti anticipazioni, affidate ai mass-media, di scoperte eziologiche e terapeutiche clamorose e risolutive.
La riorganizzazione ideologica della psichiatria procede, dunque, di pari passo con l’esclusione della coscienza sociale. L’intento primario del presente saggio, avverso a quella riorganizzazione e a questa esclusione, è di delineare una teoria psicopatologica che, nella sua stessa struttura, senza alcun cedimento alla divulgazione, implichi la necessità, ai fini di un superamento del problema psichiatrico, di un coinvolgimento, a livello di riflessione critica, della coscienza sociale.
Ad un primo approccio, il sistema teorico che viene proposto, può indurre a giudicare contraddittorio tale intento per due motivi. Il primo è la complessità del sistema stesso, che si riflette in una trama discorsiva di non agevole lettura. Queste note introduttive mirano, per quanto è possibile, a diminuire tale difficoltà.
Il secondo motivo è che il sistema appare integrato rispetto al paradigma psichiatrico attualmente dominante che, in seguito alla tardivamente riconosciuta multidimensionalità dell’esperienza umana, propone un modello esplicativo psico-socio-somatico aperto alla valutazione empirica, caso per caso, del ruolo eziopatogenetico dei fattori biologici,psicologici e socioculturali. Si tratta di una concordanza formale, non sostanziale. Il modello multidimensionale neopsichiatrico è uno scheletro teorico che, nonché animarsi di vita a contatto con la realtà clinica, serve solo a ribadire il ruolo della predisposizione genetica come causa prima, benché mai unica, dei fenomeni psicopatologici.
Se, sul piano dei principi, esso propugna il superamento delle ideologie - il biologismo, lo psicologismo, il sociologismo - che, con alterne fortune, hanno segnato la storia della psichiatria, nella pratica tale superamento viene smentito dal ricorso a categorie nosografiche la cui organizzazione, per esempio negli alberi decisionali del DSM (1), sotto forma di diagrammi di flusso, lascia pochi dubbi riguardo ad un futuro affidamento dei dati clinici al computer.
Gli schemi eziopatogenetici elaborati alla luce del modello multidimensionale sono, rispetto alla tradizione, estremamente articolati ed eclettici. Cionondimeno, essi appaiono carenti di criteri oggettivi che permettano di valutare l’incidenza dei diversi fattori nella genesi e nell’evoluzione dei fenomeni psicopatologici. Questa carenza è giustificata dal rispetto dell’unicità irripetibile di ogni esperienza umana, la cui “cifra” psicopatologica andrebbe, pertanto, ricostruita dal vivo. Ma la nozione patogenetica di stress che viene proposta come via finale del disagio psichico, e su cui si fonda la pretesa di trasformare la psichiatria in scienza psico-socio-somatica, non significa altro che disadattamento e il disadattamento implica, sempre e comunque, una presunta vulnerabilità costituzionale, un’incapacità strettamente individuale di rispondere alle “leggi” della vita.
Nonostante un indubbio sforzo di aggiornamento, promosso dalla contestazione antipsichiatrica avviatasi negli anni ‘60, il paradigma multidimensionale rimane pertanto pervicamente ancorato ad un pregiudizio genetico, del quale non è stata offerta sinora alcuna verifica. Ma occorrerà attenderla, come sostengono i fautori di quel paradigma, ignorando che quel pregiudizio è fin troppo agevolmente falsificabile?
Ammettere, con Rose e coll. (2) che, date le stesse circostanze ambientali, un soggetto dotato di un genotipo diverso rispetto a colui che manifesta un disagio psichico, interagirebbe adattivamente, non esclude affatto che questi, date altre circostanze, potrebbe organizzare la propria esperienza di vita in forma adattiva. Questa argomentazione, non verificabile per ovvi motivi, che gli autori citati espongono dopo aver invalidato criticamente i risultati delle ricerche sui disturbi psichici di gemelli omozigoti allevati in ambienti diversi, denuncia l’ottica ideologica del paradigma multidimensionale. Tale ottica, privilegiando il livello empirico della valutazione eziopatogenetica caso per caso, pone tra parentesi i probemi di ordine generale, la cui soluzione, sia pure sotto forma di ipotesi, non può non presiedere la costruzione di una teoria psicopatologica.
Nonché le interazioni tra corredi genetici individuali e ambienti socioculturali che esitano inesperienze di disagio psichico, occorre, infatti, affrontare il nodo delle potenzialità intrinseche alla natura umana, la cui plasticità deve pur riconoscere dei limiti; e dei modi in cui il mondo come prodotto storico, e cioè oggettivazione di quelle potenzialità, risponde ad esse, offrendo a ogni essere che intraprende la sua personale avventura, determinate opportunità di sviluppo ed esigendo da ciascuno, in nome dell’appartenenza, sacrifici i cui benefici, per l’individuo e la comunità, non possono non essere valutati in rapporto ai costi -in termini di alienazione - che comportano.
Affrontare questo nodo, significa valutare l’incidenza del caso e della necessità nelle esperienze umane e constatare che, agli estremi della realtà sociale, a livello micro- e macrosociologico, quell’incidenza è suprema, e mortifica il bisogno umano di pari opportunità di sviluppo, il quale postula la distribuzione la più equa possibile delle risorse materiali, culturali e emozionali prodotte dalla storia. Gettato a caso nel mondo con il suo patrimonio genetico, l’individuo deve attecchire e svilupparsi su di un terreno estremamente disomogeneo (nonostante le apparenze di superficie) e, nel contempo, dar frutto in nome di un’economia del bene comune spesso indifferente ai suoi bisogni e, il più spesso, ai bisogni del gruppo microsistemico cui appartiene. La psichiatria diventa inesorabilmente ancella dell’ordine di cose esistente se si limita a prendere atto di ciò che accade senza spiegare e denunciare, attraverso una pratica teorica, l’inadeguatezza di quell’ordine ai fini di una compiuta espressione delle potenzialità intrinseche alla natura umana. Ridurre l’incidenza del caso e della necessità sui destini umani si pone, dunque, come un obiettivo primario della prassi terapeutica: perseguire il quale a livello locale - laddove,in un soggetto e nel microsistema cui appartiene, si manifesta il disagio psichico – se prescinde da un più ampio progetto culturale e politico, si riduce a vuotare l’acqua del mare con un bicchiere.
I due livelli - locale e globale - non vanno però confusi. Una teoria psicopatologica deve spiegare - e cioè «rendere conto dei fenomeni a partire da qualcosa di diverso da essi, qualcosa a cui essi vengono associati secondo relazioni considerate necessarie o per lo meno altamente verosimili» - quell’incidenza a livello locale, a livello di esperienze psicopatologiche concrete.(?
2. In ciò che ha di ovvio - l’essere l’uomo un animale sociale dotato di soggettività, che vive e soffre sul registro psicosociosomatico - il modello multidimensionale non può essere rifiutato. Ma, prescindendo dal pregiudizio genetico che è ad esso intrinseco, rappresentando un inquinamento ideologico, si tratta di un modello povero, che non può pretendere di trasformarsi in teoria, poiché fallisce nel rappresentare la realtà clinica in ciò che essa ha di più sorprendente e “anomalo”: l’invarianza delle forme di esperienze psicopatologiche.
Gli schemi eziopatogenetici elaborati all’interno del modello multidimensionale esitano nella categoria generica di sindrome e affidano al momento empirico della diagnosi di definire di quale sindrome si tratti. Ma tale definizione avviene attraverso il ricorso a categorie nosografiche che non sono in alcun modo deducibili dagli schemi eziopatogenetici. Non si tratta di una lacuna di poco conto. Spiegare il paradosso per cui i tragitti esperienziali più vari,ciascuno dei quali definisce una vicenda umana in sé e per sé unica e irripetibile, finiscono con il fenomenizzarsi entro forme psicopatologiche invarianti è un nodo teorico essenziale. Muto a questo riguardo, il modello multidimensionale assiste, per dir così, al prodursi del semplice - le forme psicopatologiche - dal complesso - la varietà indefinita dei tragitti di esperienza del mondo -, e cristallizza tale produzione entro quadri nosografici organizzati sotto forma di “alberi decisionali”, la cui astrattezza è restituita dal fatto, di quotidiana osservazione, che quelle forme, benché invarianti, non sono chiuse.
Spesso, anche se non sempre, le esperienze psicopatologiche passano dall’una all’altra,riorganizzandosi. La realtà clinica appare dunque fenomenicamente caratterizzata da forme invarianti dinamicamente correlate. Essa ritaglia, nell’universo dei fatti umani, un ambito di esperienza le cui manifestazioni dal livello dei vissuti a quello dei comportamenti, sembrano,per la loro intrinseca coerenza, organizzate da leggi di struttura e, per le possibili trasformazioni cui possono andare incontro, sottese da una matrice dinamica.
In quanto strutturate, non sorprende che le forme di esperienza psicopatologica siano poche (come vedremo), e possano essere descritte oggettivamente, senza alcun riferimento adesperienze individuali concrete. Dal punto di vista strutturale, l’universo psicopatologicoappare, né più né meno, come un labirinto i cui tragitti sono obbligati e i cui vicoli ciechi non possono indurre che o la resa o unafebbricitante esplorazione orientata a trovare una via di scampo. Il problema dellatrasformazione del complesso nel semplice può essere, dunque, risolta a patto che sidefiniscano le condizioni per cui le più varie esperienze personali accedono o sono spinte inquel labirinto. A riguardo, si dirà l’essenziale successivamente.
Per ora, importante è soffermarsi sull’aspetto più propriamente strutturale dell’universopsicopatologico, rappresentato dalle coercizioni, più o meno rilevanti, della libertàpersonale che esso comporta.
Nessuna teoria psicopatologica ignora quest’aspetto, sia esso ricondotto a moduli di reazione psicobiologica, a situazioni di stress, al conflitto psicoanalitico tra esigenze pulsionali e codici morali, o a situazioni interpersonali che irretiscono il soggetto in giochi comunicativi a vicolo cieco.
Non si tratta di ipotesi insignificanti: ciascuna di esse coglie un aspetto della realtà clinica, e lo restituisce da punti di vista e con griglie interpretative diverse. Ma noi riteniamo che la struttura coercitiva dell’universo psicopatologico significhi molto di più e porti al cuore di una problematica di ordine generale, che concerne la natura umana in ciò che ha d’intrinseco - un ricco corredo di bisogni, che può, in rapporto alle interazioni socioculturali, trasformarsi in miseria: in alienazione sociale per un verso, in disagio psichico per un altro.
3. La descrizione oggettiva delle forme di esperienza psicopatologica pone di fronte, univocamente, a codici che autorizzano, proscrivono, prescrivono il modo di essere e di porsi nel mondo del soggetto, dal livello della vita interiore - ove il flusso delle memorie, delle emozioni, dei pensieri scorre rispettando divieti ben definiti - al livello comportamentale - che è governato da regole che limitano, nei modi più vari, l’esercizio della libertà personale.Nonostante la loro complessità, che riconosce valenze emozionali, cognitive e ideologiche, quei codici si configurano come sistemi di valori il cui comune denominatore è il primato della totalità sociale che essi rappresentano sulla parte, l’individuo, e la subordinazione, non importa se consentita o coercitiva, di questi a quella. Ciò, a tutta prima, non sorprende: ogni esperienza umana, poiché individuale e sociale, deve mediare in qualche modo i bisogni della persona e le esigenze collettive. In tanto l’uomo è un animale culturale, in quanto egli, partecipando ad un’esperienza che lo trascende, quella comunitaria, sacrifica a essa una quota dei suoi bisogni.Ma i codici psicopatologici attestano, con evidenza drammatica, che tale sacrificio, nonché frutto di una costrizione culturale, affonda le sue radici in una predisposizione intrinseca alla natura umana. Non si capirà mai il peso che esercita nelle esperienze psicopatologiche la paura dell’esclusione sociale, se si prescinde dall’attribuire alla natura umana un bisogno primario d’integrazione sociale. Ma donde trae origine questo bisogno?
Di solito, esso viene ricondotto alla condizione di radicale dipendenza, insufficienza ed impotenza propria dell’infante.Ma bastano queste condizioni a spiegare l’angoscia sociale o non devono esse stesse essere ricondotte ad una strategia evolutiva che non ha trovato altre vie per produrre un animale altamente culturalizzato e integrato socialmente?
Se si riconosce nella natura umana l’espressione di quella strategia, occorre chiedersi quale ne sia il fondamento psicobiologico.Si assumano quelle condizioni, anziché in negativo, in positivo: come condizioni cioè che, vincolando l’infante al gruppo e il gruppo all’infante, promuovono una relazione di lunga durata che, per effetto della plasticità della struttura e delle funzioni cerebrali che caratterizzano le fasi evolutive, consente la riproduzione culturale, e cioè, in un contesto contrassegnato da vincoli affettivi, la trasmissione, l’introiezione e la pratica dei valori su cui si fonda, prima ancora che quella dell’individuo, l’identità del gruppo.
La predisposizione sociale della natura umana, pur prescindendo da considerazioni di filosofia evoluzionistica, si ricava dal fatto che, sino a epoche recenti, essa ha consentito un modellamento da parte dell’ambiente il cui fine era, piuttosto che la differenziazione dell’individuo (concetto, di cui, com’è noto, difetta addirittura il significante presso molte culture primitive), l’acquisizione del ruolo di membro di un gruppo.
Quella predisposizione è di ordine filogenetico: a partire da condizioni già presenti nei primati è maturata nel corso del processo di ominazione e si è arricchita lungo tutta la preistoria in conseguenza di esperienze comunitarie “faccia a faccia”. E’ chiaro, dunque, che essa è riconducibile a un bisogno “viscerale”: quello di condividere l’esperienza culturale del gruppo di appartenenza e di rimanere fedele ai valori che, definendone l’identità, ne assicurano la riproduzione.Bisogno viscerale e, nello stesso tempo, vincolante, che fa capo a un’emozione che non è illecito assumere come una forma a priori intrinseca alla natura umana: l’indebitamento. Tale forma a priori, che è stata riempita di contenuti diversi nel corso della preistoria e della storia, riconosce aspetti diversi. Nella sua matrice viscerale, l’indebitamento è anzitutto biologico, coincidendo con l’intuizione di aver ricevuto la vita da qualcuno, Solo di recente, con l’avvento della genetica, questa intuizione è stata convalidata scientificamente al di là del mero fatto procreativo: ogni uomo veicola e utilizza un corredo genetico che appartiene a un patrimonio comune, il pool genetico.
Si dà poi l’indebitamento materiale che coincide, al minimo grado, con la consapevolezza chela sopravvivenza, sino a una certa età (variabile secondo le culture), è dovuto ad un investimento di risorse prodotte dal lavoro altrui, e, al massimo grado, con i diritti ereditari di partecipazione patrimoniale.
Complementare a quello materiale, benché distinto da esso, è l’indebitamento affettivo, e cioè il vissuto per cui l’identità personale, il riconoscersi e l’essere riconosciuti, è l’espressione della quota di cura e protezione ricevute.Indebitamento, a sua volta, correlato alla trasmissione, che non potrebbe avvenire in difetto di rapporti significativi di lunga durata, di valori culturali - dalla madre-lingua ai codici morali - il rispetto dei quali definisce il debito ideologico, e cioè il prezzo da pagare, in termini di fedeltà ad essi, all’appartenenza. In tutti i suoi aspetti, dunque, l’indebitamento sancisce ciò che l’individuo deve alla comunità. Le sue matrici viscerali, riconducibili a una forma a priori emozionale, si arricchiscono di contenuti culturali nel corso delle fasi evolutive della personalità. La forma postula la fedeltà al gruppo di appartenenza, i contenuti definiscono quali valori vanno condivisi e praticati.Forma e contenuti dell’indebitamento strutturano l’identità sociale dell’individuo, il suo essere in quanto membro di una comunità e il suo dover essere - nel senso di dover qualcosa a qualcuno - in quanto debitore.II riferimento al bisogno d’integrazione sociale e all’indebitamento nei suoi vari aspetti permette di rifondare la concezione freudiana della funzione superegoica, riconoscendo in essa una parte della mente che si struttura a partire da una forma a priori emozionale e, in virtù dei contenuti che veicola, svolge una funzione di rappresentanza sociale, e cioè obbliga l’individuo, in nome del debito di appartenenza, a condividere l’esperienza culturale del gruppo e a rimanere fedele a esso.
4. Non si stenta a comprendere quale importanza ha avuto la funzione supergoica nel corso del lungo processo che ha prodotto l’avvento della storia umana, contrassegnato dalla differenziazione e dalla stratificazione sociale, e dalla produzione, ad opera dei ceti dominanti, di una tradizione affidata alla scrittura. In comunità di poche decine di membri, caratterizzate dunque da un’esperienza sociale “faccia a faccia”, la funzione superegoica ha permesso la coesione del gruppo sia longitudinalmente che trasversalmente, affermando il primato della comunità con le sue tradizioni e i suoi equilibri sistemici sugli individui e promuovendo, in nome di una gerarchia fondata sulle classi di età e su una distribuzione di ruoli legata al riconoscimento sociale delle competenze individuali, una condivisione comunitaria dei beni e dei valori. Espressione diretta, visceralmente connotata, del bisogno di integrazione sociale e, quindi, di cultura, essa ha sancito il bene comune il rispetto delle tradizioni e dei valori atti ad assicurare la riproduzione sociale come bene supremo, patrimonio condivisibile ma non appropriabile da parte di qualcuno. E’ evidente che la funzione superegoica, pur alienando l’individuo, lo integra socialmente finché il gruppo di appartenenza è realmente rappresentativo della comunità perché o si identifica con essa o la media fedelmente e finché i valori culturali che essa impone di condividere sono espressione di un bene comune reale, e cioè di un’equa distribuzione delle risorse materiali e “spirituali” di cui la comunità dispone, e che vengono prodotte attraverso la cooperazione.
Date queste circostanze che persistono, per un’oscura necessità, presso le società fredde indagate da LeviStrauss, dove il tradizionalismo mantiene un ordine superegoico il cui prezzo è il mancato accesso alla ribalta della storia , il sacrificio dell’individuo, che accetta, per molti aspetti, di annullarsi nel gruppo e per il gruppo, ha un costo inferiore in termini di alienazione al beneficio personale e sociale che ne deriva. Con l’avvento della storia, e lo strutturarsi di società calde, che ricavano la loro dinamica evolutiva dall’antagonismo fuori e dentro i confini dell’etnia, entrambe quelle circostanze vengono a mancare: il gruppo di appartenenza, con cui l’individuo originariamente si identifica e da cui introietta la cultura, rappresenta comunque una minuscola frazione di una società più o meno altamente stratificata, le cui gerarchie non si definiscono attraverso rapporti interpersonali “ faccia a faccia”; i valori trasmessi che pure fanno capo ad un patrimonio comune, impongono un’alienazione il cui costo può tornare a vantaggio, nonché dell’individuo, dei ceti dominanti che quei valori sanciscono attraverso l’espropriazione e l’uso dei mezzi di produzione economica e culturale.
Queste nuove circostanze non modificano però il patrimonio psicobiologico della natura umana per quanto riguarda la sua predisposizione sociale: in quanto espressione di un bisogno visceralmente connotato, la funzione superegoica si struttura imponendo di condividere un’esperienza di gruppo che, per essere parziale, può promuovere la condivisione e l’obbligo di fedeltà a valori alienati il cui vantaggio non è comune, anche se l’ideologia lo significa come tale.
La funzione superegoica diventa pertanto, in nome di un automatismo intrinseco al corredo della natura umana, promotrice di sacrifici inutili per chi li esegue. Il debito di appartenenza, da leva psicobiologica dell’integrazione sociale, si trasforma in strumento di un’alienazione che coincide con una condizione di schiavitù mortificante. Ma non è proprio ciò che si realizza, ancora oggi, nelle esperienze psicopatologiche, e che si esprime dell’invarianza delle forme di esperienza?
Alla luce di quest’ipotesi, l’universo psicopatologico si configurerebbe come un universo strutturato da una “patologia” dell’indebitamento, come universo di solvenza radicale e di insolvenza ribelle, rappresentato ai due estremi dalle figure dell’agnello sacrificale e del traditore mai in pace con se stesso. Tale ipotesi non rende ancora conto, peraltro, delle matrici strutturali psicopatologiche.
In quanto radicata in una predisposizione sociale intrinseca alla natura umana, e quindi presente in ogni corredo individuale, la funzione superegoica non può non strutturarsi all’interno di ogni esperienza soggettiva. In rapporto a quali circostanze, essa, dunque, dà luogo, attraverso l’indebitamento e i sensi di colpa, ad un disagio psichico?
L’attribuzione alla natura umana di una predisposizione sociale, nonostante una lunga tradizione che associa alla socialità la virtù, non comporta affatto un’ideologia ingenuamente ottimistica dell’essere e del porsi dell’uomo nel mondo. Come è quella predisposizione una ricchezza potenziale, sulla quale si può fondare l’utopia (nell’accezione di Mannheim) di un universo di liberi ed eguali accomunati dalla coscienza di specie e cooperanti al fine di condividere un patrimonio comune di beni materiali e “spirituali” prodotti dall’impegno di miti, così essa è anche un autentico pericolo e una potenziale miseria nella misura in cui postula l’alienazione sociale come costitutiva della struttura della personalità umana.
La totalità sociale che la funzione superegoica rappresenta, e della quale afferma il primato, è infatti riferita ad un gruppo di appartenenza caratterizzato dalla differenziazione, spesso antagonistica, rispetto ad altri gruppi e dall’essere collocato, a partire dall’epoca storica, in una struttura sociale stratificata e gerarchizzata. In conseguenza di ciò, l’individuo è costretto ad essere fedele a valori che sono comunque sociali, e cioè riconosciuti e convalidati da un gruppo, ma, per le matrici storiche che li determinano, possono prescrivere comportamenti intraspecifici alienati. Nonché la solidarietà, la cooperazione, la condivisione delle risorse o, se si vuole, delle gioie e dei dolori valori realizzatisi, a livello reale, nelle società fredde, in alcune subculture, in comunità religiose, in determinati gruppi di parentela , la funzione superegoica può imporre anche, in conseguenza dell’alienazione, all’interno della struttura sociale, l’accettazione delle gerarchie e di disuguaglianze ingiuste, e, all’esterno, l’odio dell’estraneo e la tendenza a sopraffarlo. Essa, dunque, che, nella sua forma a priori, comporta l’identificazione con il simile, per i contenuti culturali che la strutturano, può promuovere all’interno della comunità una coesione alienata e all’esterno una differenziazione antagonistica. Lo stratagemma evoluzionistico della predisposizione sociale e dell’indebitamento, inducendo l’accettazione della stratificazione sociale e promuovendo l’estraneazione, avrebbe inevitabilmente finito con il produrre, anche a livello di società storiche, un congelamento delle strutture sociali e degli scambi interculturali se non fosse stato compensato da un qualche altro stratagemma. E’ evidente che, a questo livello, le ipotesi di Levi-Strauss, incentrate sull’esogamia, non hanno alcun rilievo. Non v’è motivo di negare il ruolo svolto dall’imparentamento in rapporto ai problemi prodotti dalla differenziazione tra i gruppi tribali ed etnici e la loro diffusione su scala planetaria. Ma tale ruolo, se vale per la preistoria, non può valere per la storia, caratterizzata dall’aggregarsi in organizzazioni statali di enormi masse, etnicamente differenziate e rigidamente gerarchizzate al loro interno.
C’è poi da considerare un altro fatto. Oltre a compensare il pericolo dell’estraneazione e dell’ostilità intraspecifica tra gruppi coesi da diverse culture, e la minaccia del congelamento delle strutture sociali stratificate, lo stratagemma in questione deve permettere di spiegare un fenomeno storico di immensa portata: la nascita dell’individuo dotato di una coscienza morale atta a permettergli di contrapporsi, in nome delle ragioni di quella, al gruppo di appartenenza comunitaria, e quindi di affrancarsi dalle tradizioni. Il riferimento a Socrate e al suo daimon privato è storicamente obbligatorio.
Ma è evidente che, pur considerando le qualità straordinarie del personaggio, la nascita dell’individuo dotato di coscienza morale critica va considerata, al di là dell’evento, un fenomeno destinato ad incidere sulla storia umana, che ha introdotto in essa la tensione dialettica tra debito di appartenenza e individuazione, intesa, quest’ultima, come fedeltà a valori non coincidenti con i valori trasmessi e condivisi dal gruppo.
Fenomeno, peraltro, che non può essere ricondotto solo a circostanze storiche. Senza una predisposizione intrinseca alla natura umana, complementare e in tensione dialettica con il bisogno di integrazione sociale, esso non si sarebbe prodotto.
La storia ha funzionato, insomma, sia pure dopo una lunghissima incubazione, come levatrice. Ma a cosa ricondurre questo bisogno che promuove, nonostante l’indebitamento, la capacità dell’individuo di entrare in conflitto con il gruppo di appartenenza?
Non si dà che una risposta: esso va ricondotto ad una forma a priori emozionale la cui espressione primaria è un sentimento innato di giustizia. Emozione anteriore alla ragione, che può essere da questa corroborata, distorta, soffocata, che comporta una tendenza ad interagire, sul registro dell’opposizione, con tutte le circostanze sociali, anche riferite al gruppo di appartenenza, vissute come oppressive, lesive della libertà e della dignità umana, o, comunque, tali da sancire, in nome di qualsivoglia valore, il dominio dell’uomo sull’uomo, anche se convalidato e naturalizzato, dall’ideologia.
Dal momento in cui appare storicamente, tale bisogno, che si può definire di opposizione/individuazione, si pone come un bisogno radicale, non antitetico ma in tensione dialettica rispetto al bisogno di integrazione sociale, le cui possibili e temibili conseguenze alienanti, in nome dell’appartenenza, vengono così ad essere compensate. Ma quella tensione dialettica, che fa capo alla natura umana, si dispiega e non può dispiegarsi che nell’ordine della cultura. Essa, come vedremo, rappresenta un vincolo inesorabile, che la realtà sociale, a tutti i suoi livelli, può tentare di violare.
5. Costitutiva di ogni esperienza umana nel mondo; massima, perché fluida e fasica nel corso dell’evoluzione della personalità; aperta alle interazioni con l’ambiente che, attraverso i legami affettivi e la trasmissione dei valori, offrono ad essa determinate opportunità di organizzazione fenotipica; eminentemente plastica ma, nel contempo, vincolata da una rigidità che definisce, in rapporto ad ogni corredo individuale, dei limiti, la dialettica dei bisogni può andare incontro, date le più varie circostanze ambientali alienanti, a catastrofi che determinano un conflitto irriducibile, e non più mediabile tra i bisogni stessi, e di conseguenza una scissione nel cuore stesso della personalità psicobiologica. Questo conflitto si traduce in una matrice strutturale che, opponendo il debito di appartenenza all’individuazione, impone, per effetto della funzione superegoica, limitazioni della libertà personale sia a livello vissuto che comportamentale tali che il soggetto è costretto a vivere entro confini e secondo modalità dettati dal debito, e dai valori culturali cui esso fa riferimento. Uscire da tali confini è possibile essendo la libertà personale di fatto incoercibile ma al prezzo dei sensi di colpa che, associando al tradimento l’indegnità, promuovono l’angoscia sociale e morale e, in conseguenza di essa, tendenze alla regressione. La matrice strutturale conflittuale, che si ricava dalla teoria dei bisogni e dal primato, mantenuto dalla funzione superegoica, della totalità sociale sulla parte l’individuo rappresenta dunque la chiave che consente di spiegare la traduzione della complessità delle esperienze soggettive, uniche e irripetibili, nella semplicità delle forme psicopatologiche.
In conseguenza di questa impostazione teorica, la psicopatologia si configura come una scienza il cui oggetto specifico le esperienze psicopatologiche va esplorata, con metodologie particolari, come sintomatico di un problema di ordine affatto generale: il rapporto tra natura umana e cultura. Tra una natura umana, invariante per quanto concerne i bisogni fondamentali di integrazione sociale e di individuazione, e variante nelle combinazioni di tali bisogni a livello di corredi genetici individuali; e la cultura, considerata nei suoi aspetti invarianti, che comportano una organizzazione sociale strutturata da valori che sanciscono i diritti e i doveri dell’appartenenza in nome del primato della totalità sociale sugli individui, e nei suoi aspetti varianti, che definiscono, per ogni società storicamente determinata e per ogni sottosistema, le regole di conservazione, di condivisione e di sviluppo di un patrimonio materiale e “spirituale” identificato con il bene comune.
La dialettica del rapporto tra una natura umana predisposta ad esprimersi compiutamente secondo le linee di tendenza rappresentate dai bisogni, e un mondo prodotto dalla storia e organizzato a tutti i suoi livelli economico, sociale, mentale per fornire opportunità, più o meno adeguate, alla realizzazione di quei bisogni, è dunque il paradigma che sottende ogni esperienza umana. Paradigma dialettico da cui si può ricavare la spiegazione delle esperienze psicopatologiche se si ammette che quella tensione, data una serie di circostanze ambientali, si traduce in una matrice conflittuale che impone, in nome dell’appartenenza e dell’integrazione sociale, un sacrificio inutile di bisogni, subito e talora consentito ma, nel contempo, per effetto dell’opposizione, visceralmente rifiutato.
Tale sacrificio si configura, costantemente, come conseguenza di un’alienazione dei bisogni, che determina l’investimento (e lo spreco) di potenzialità personali nel rispetto di valori i quali, benché trasmessi dal gruppo di appartenenza, non rappresentano che ideologicarnente, e cioè per effetto di un cieco rispetto delle tradizioni o di un passivo conformismo, il bene comune. Tant’è che la pratica di quei valori come danneggia il soggetto disagiato così non avvantaggia alcuno dei membri che li trasmette. Muovendo da questi presupposti, la psicopatologia si definisce come scienza il cui oggetto sono, in ultima analisi, i meccanismi intrinseci ed estrinseci alla natura umana dell’alienazione sociale, indagata ad un livello locale quello delle esperienze soggettive e dei microsistemi interattivi laddove essa, per effetto dell’indebitamento, si traduce in alienazione psicopatologica.
6. Pur essendo rivolto a delineare un sistema teorico psicopatologico, incentrato sulla dialettica dei bisogni, questo saggio affronta, in maniera forse, eccessivamente sintetica, una serie di problemi che attraversano tutto il campo delle scienze neurobiologiche, umane e sociali. Nonché implicito nel progetto originario della ricerca, l’allargamento degli orizzonti problematici si è imposto via via che la stessa è venuta procedendo ed è stato accettato nella piena consapevolezza di competenze limitate. L’augurio dell’autore è che alcuni suggerimenti possano essere approfonditi e vagliati criticamente a livello interdisciplinare. La ricerca, intanto, prosegue sul suo terreno. Un secondo e un terzo saggio, in via di avanzata stesura, mireranno rispettivamente ad approfondire il discorso sulla psicopatologia strutturale e dialettica, radicandolo ulteriorimente sul piano “clinico”, e ad illustrare la metodologia in virtù della quale la teoria elaborata può tradursi in prassi terapeutica.
Capitolo primo
La scoperta del Super-Io e il problema della doppia identità
II termine Super-Io è introdotto da Freud nel 1923. L’intuizione dell’esistenza di questa istanza risale però al 1914. Nell'Introduzione al narcisismo, Freud scrive:
«I moti pulsionali libidici incorrono nel destino di una rimozione patogena quando vengono in conflitto con le rappresentazioni della civiltà e dell’etica proprie del soggetto. Con ciò non abbiamo mai inteso che l’individuo abbia una nozione meramente intellettuale di queste rappresentazioni, ma sempre piuttosto che egli le riconosca come normative e si sottometta alle sollecitazioni che da esse gli pervengono. Abbiamo detto che la rimozione procede dall’Io. Potremmo essere più precisi e sostenere che procede dalla considerazione che l’lo ha di sé... Possiamo dire che un individuo ha costruito in sé un ideale rispetto al quale misura il proprio lo attuale... La formazione di un ideale sarebbe da parte dell’Io la condizione della rimozione» (1)
Poco più oltre nel testo Freud aggiunge:
«Non ci sarebbe niente di strano se riuscissimo ad identificare una speciale istanza psichica che assolva il compito di vigilare affinché a mezzo dell’ideale dell’Io sia assicurato il soddisfacimento narcisistico, e a tal fine osserva costantemente l’Io attuale commisurandolo a questo ideale. Se tale istanza esiste, non è possibile che ci accada di scoprirla: possiamo solo riconoscerla come tale e ci è lecito dichiarare che ciò che chiamiamo la nostra “coscienza morale” ha questa prerogativa. Riconoscere l’esistenza ditale istanza ci rende intellegibile il cosidetto “delirio di essere notati” o. più precisamente, di essere “osservati”, delirio che si manifesta con tanta evidenza nella sintomatologia delle affezioni paranoidi... I malati di questo tipo si lamentano del fatto che tutti i loro pensieri sono conosciuti, e le loro azioni sono osservate e inquisite... Tale lamentela è giustificata poiché corrisponde al vero. Una forza di questo genere che osserva, scopre e critica tutte le nostre intenzioni esiste davvero, e precisamente nella vita normale di ciascuno di noi».
La genesi di questa istanza che, nei deliri di osservazione, sembra parlare in nome del mondo, appare ovvia:
«...L’esigenza di formare un ideale dell’lo, su cui la coscienza morale è incaricata di vigilare, è scaturita nell’individuo per opera delle critiche che i suoi genitori hanno rivolto a voce, alle quali, nel corso del tempo, si sono associati gli eduI maestri e l’incalcolabile e indefinita schiera di tutte le altre persone del suo ambiente (il suo prossimo e la pubblica opinione).»
Ovvia è anche l’interpretazione del carattere persecutorio che quell’istanza assume in quanto rappresentante della norma sociale:
«Sia le voci sia la moltitudine di persone la cui identità è lasciata nel vago sono… riportate in primo piano dalla malattia; e con ciò viene riprodotta regressivaterne la storia evolutiva della coscienza morale. Ma la ribellione contro questa “istanza censoria” dipende dall’intenzione del soggetto… di liberarsi da tutti gli influssi che sono seguiti a quelli dei genitori…
…La sua coscienza morale gli si fa dunque contro in forma repressiva, assumendo le sembianze di qualcosa di ostile che agisce all’esterno».
Già in questa fase, la linearità dell’ipotesi occulta un nodo di problemi su cui Freud non riuscirà mai a far luce. Nel Compendio di psicoanalisi, redatto nel 1938, egli ribadisce che la genesi del Super-Io concerne «effettivamente non solo la personalità degli stessi genitori ma anche le tradizioni razziali, nazionali familiari trasmesse ai figli per loro tramite come pure le esperienze dell’ambiente sociale immediatamente circostante che essi rappresentano», e che , essa «raccoglie ogni sorta di contributo da parte di eventuali successori o sostituti dei genitori come i maestri, personaggi di primo piano nella vita pubblica e certi nobili ideali sociali».
Nonostante questa funzione di rappresentanza sociale del Super-Io rimanga sempre evidente nel suo pensiero, Freud non ne ricava mai l’ovvia ipotesi che essa attesti la predisposizione sociale della natura umana.
In nome della moltitudine che rappresenta sterminata, in quanto comprende i vivi e i morti quella funzione, introiettata in virtù di identificazioni, è deputata a piegare la natura umana, in sé e per sé ribelle alle norme e ai valori sociali, alle esigenze della vita collettiva in virtù non degli affetti che legano il soggetto al gruppo di appartenenza bensì del principio del più forte: i molti contrapposti all’uno. Il superamento del pensiero kantiano sulla coscienza morale, assunta come forma innata della psiche umana, rivendicato esplicitamente da Freud in nome della possibilità di spiegare la filogenesi e l’ontogenesi della funzione superegoica in termini di una socializzazione forzata, atta a promuovere il primato della cultura sulla natura umana, avviene pertanto a partire dall’ipotesi ideologica di un conflitto irriducibile tra di esse. Avallata, secondo Freud, dai dati tratti dalla pratica psicoanalitica, quest’ipotesi, che rappresenta un basso continuo del pensiero freudiano, incorre in una crisi. Ma a produrla non sono i dubbi epistemologici bensì le circostanze storiche. Pochi mesi dopo l’introduzione al narcisismo, la Grande Guerra avvia, nel cuore dell’Europa civilizzata, un massacro al quale i popoli non possono sottrarsi, ciascuno in nome di valori sacri che sembrano coincidere con le radici stesse della civiltà.
Dopo un iniziale e fervido entusiasmo patriottico, Freud cade in una lunga crisi. Ciò che gli appare è che il potere costituito, che dovrebbe garantire i valori della civiltà, può essere esercitato arbitrariamente, contro l’interesse dei popoli e degli individui.
Egli scrive, in Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte:
«Il privato cittadino ha modo durante questa guerra di persuadersi con terrore di un fatto che occasionalmente già in tempo di pace lo ha colpito: e cioè che lo Stato ha interdetto al singolo l’uso dell’ingiustizia, non perché intende sopprimerla, ma solo perché vuole monopolizzarla... Lo Stato in guerra ritiene per sé lecite ingiustizie e violenze che disonorerebbero l’individuo singolo... Lo Stato richiede ai suoi cittadini la massima obbedienza e il massimo sacrificio di sé, ma li tratta poi da minorenni... Lo Stato scioglie ogni convenzione e trattato stipulato con gli altri stati e non teme di confessare la propria rapacità e volontà di potenza».
Il mito di Totem e Tabù, nel quale Freud vedeva due anni prima il coronamento della teoria libidica atta a spiegare tutto della civiltà, della storia collettiva ed individuale, è dissacrato. Al posto del Padre primitivo, le cui ingiustizie e la cui prepotenza venivano assolte dal suo essere soggetto a leggi di natura, compare lo Stato che dovrebbe essere garante delle esigenze più elevate della civiltà. Ma lo Stato che, meno con la repressione che con l’ipnotica fascinazione dei valori di cui si ammanta la fedeltà alla Patria, la necessità di lottare per una Causa giusta , mantiene i cittadini in una condizione di totale assoggettamento, promuove un figlicidio e un fratricidio universale. Come il Padre primitivo, lo Stato, deputato, a differenza di quegli, a difendere il bene collettivo dalle pulsioni individuali, manifesta, in occasione della guerra, la sua “immoralità”, affrancandosi da ogni vincolo giuridico e manifestando senza alcun freno una distruttiva volontà di potenza.
La riflessione sulla guerra mette in crisi l’ingenuo positivismo di Freud, che opponeva alle cieche pulsioni naturali le esigenze collettive della civiltà, e assegnava all’Io la funzione di frustrare quelle in nome di queste.
Gli ideali dell’Io che veicolano, nel cuore della soggettività, spesso confondendosi con le aspirazioni dell’individuo, i codici normativi del gruppo familiare o etnico di appartenenza, assumono repentinamente un significato inquietante.
Se essi, infatti, come si desume dalla teoria edipica, si fondano filogeneticamente su di un patto sociale che, proscrivendo il parricidio e la legge del taglione, ha consentito alla società di istituirsi e perpetuarsi, tenendo a freno l’aggressività intraspecifica, come è possibile che, in nome loro, lo Stato, che dovrebbe esserne garante, imponga, come espressione di virtù civica, l’uccisione del simile? Nonché di nobili ideali, la funzione superegoica che promuove il senso del dovere, non potrebbe veicolare e rendere soggettivamente costrittivi, in nome dell’appartenenza sociale, anche valori oggettivamente immorali? Non potrebbe essa semplicemente piegare la coscienza individuale ad obbedire alla volontà del gruppo di appartenenza e di chi lo rappresenta soffocando, per effetto dell’angoscia sociale, ogni valutazione critica in merito al dovere cui si è chiamati? In concreto, un soggetto sollecitato a uccidere i simili per la patria che si ribella a tale dovere, è un traditore, un incivile, un asociale o non piuttosto il testimone di una moralità in conflitto con la volontà del gruppo o del potere che lo rappresenta identificata arbitrariamente con il bene comune? Posto, dunque, che il Super-Io veicola, all’interno della soggettività, i doveri legati all’appartenenza sociale, la sua funzione socializzante, intesa come costrizione a piegare la volontà individuale a quella collettiva, è indubbia, ma, se si prescinde dall’identificare questa con la moralità, potendo essa esprimere solo una tradizione, un costume, un’opinione, un’ideologia dominante, la sua funzione moralizzatrice riesce almeno incerta.
Ciò che Freud, dunque, ha scoperto nella struttura della soggettività è una istanza capace di indurre angoscia sociale laddove si instaura un conflitto tra volontà collettiva e volontà personale. Ma, identificando arbitrariamente i valori sociali con i valori morali, egli è sollecitato a leggere in quel conflitto sempre e solo l’anarchia della natura umana. Ciò, nonostante i dubbi indotti dagli eventi bellici.
Freud dà voce a questo dramma personale, non meno che culturale in Lutto e melanconia, scritto quasi contemporaneamente alle Considerazioni sulla guerra e sulla morte. L’accostamento tra lutto e melanconia è giustificato dalle cause occasionali ambientali, entrambe le condizioni rappresentando «la reazione alla perdita di una persona amata o di un’astrazione che ne ha preso il posto, la patria, ad esempio, o la libertà o un ideale e così via. A differenza del lutto, la melanconia è uno stato patologico caratterizzato da un avvilimento del sentimento di sé che si esprime in autorimproveri e autoingiurie, che culmina nell’attesa delirante di una punizione». L’analogia con il lutto porta a pensare che il malinconico ha subito una perdita che riguarda l’oggetto; ma, sul piano psicologico, egli attacca e denigra se stesso, giudicandosi indegno di vivere, fino al punto di essere spinto ad attentare alla propria vita. Ecco, dunque, ancora una volta prendere corpo l’istanza superegoica persecutoria:
«Nel malinconico vediamo che una parte dell’Io si contrappone all’altra parte, la valuta criticamente e la assume, per così dire, quale suo oggetto. Il nostro sospetto che l’istanza critica, prodottasi in questo caso per scissione dell’Io, possa dimostrare la sua autonomia anche in altre circostanze sarà confermato da tutte le osservazioni ulteriori. Troveremo davvero che esistono validi motivi per separare questa istanza dal resto dell’Io. Ciò che in questo caso impariamo a conoscere è l’istanza comunemente definita istanza morale».
Rimane da capire come possa la coscienza morale incrudelire a tal punto da indurre un’autocondanna a morte. La risposta di Freud è di una straordinaria pregnanza:
«Se si ascoltano con pazienza le molteplici e svariate autoaccuse del malinconico, alla fine non ci si può sottrarre all’impressione che spesso le più intense di esse si attagliano pochissimo alla persona del malato e che invece con qualche insignificante variazione si adattano perfettamente ad un’altra persona che il malato ama, ha amato o dovrebbe amare... Rendendoci conto che gli autorimproveri sono in realtà rimproveri rivolti ad un oggetto d’amore e da questo poi distolti o riversati sull’Io abbiamo dunque in mano la chiave del quadro patologico della melanconia».
A onor del vero, la chiave è più efficace. Se infatti al posto dell’oggetto d’amore poniamo non solo una persona ma un sistema di valori Dio, la patria, la famiglia, ecc. , e se ipotizziamo che la melanconia muove dall’essersi rivelato questo sistema indegno dell’amore che esso aveva promosso, la conclusione è che l’istanza superegoica ha la funzione di rivolgere contro l’Io una condanna che andrebbe rivolta contro l’oggetto, di trasformare una presa di coscienza critica in ciò che si cela dietro ingannevoli apparenze in una radicale autocondanna, di sanzionare come colpa imperdonabile ogni umana ribellione, sia pure essa giusta. Nonché di coscienza morale, sembrerebbe opportuno parlare di una perversione sociale della coscienza morale, nel senso che essa impone il sacrificio della coscienza personale critica in nome di valori che vanno comunque rispettati, anche se essi, spogliati delle apparenze, risultano alienati.
Freud ha, dunque, scoperto nella struttura della personalità, un’istanza che sembra funzionare come una seconda identità rispetto all’Io, essendo dotata di un codice di valori, che può risultare del tutto estraneo alla coscienza personale, e di un potere ipnotico che, nei casi in cui viene attaccato criticamente, si trasforma in potere repressivo e punitivo, terrificante addirittura poiché può indurre l’individuo a pagare con la morte la sua ribellione. Non è per caso che in questo periodo Freud abbandona ogni riserva e comincia ad utilizzare, per definire tale istanza, termini antropomorfici, parlando di Censore e di Giudice. L’antropomorfismo superegoico rappresenterà, per Freud stesso e per il movimento psicoanalitico, come vedremo, un nodo gordiano di insolubile difficoltà. Di fatto, l’ipotesi di una doppia identità psichica è perturbante, tanto più se si tiene conto che l’istanza superegoica, in quanto espressione della tradizione culturale, veicolata dai genitori, dagli educatori e dalla società nel suo complesso, dovrebbe avere l’effetto di integrare socialmente la personalità, di “familiarizzarla” con il mondo rendendo ad essa “familiare” il mondo.
Ciò che invece risulta chiaro a Freud è che quell’istanza rende familiare il mondo interno ed esterno solo se ad essa l’individuo si assoggetta, accettandone passivamente gli ideali che veicola; se l’individuo si ribella, l’istanza superegoica da protettiva diventa persecutoria e mortificante. L’antropomorfismo superegoico è confermato da Freud in un saggio, Il perturbante, del 1920, a torto ritenuto minore. Esso è percorso da un’inquietudine che sarebbe ingenuo attribuire all’argomento, che, in apparenza, concerne l’estetica. Freud intende dimostrare che una delle forme più inquietanti di angoscia, quella significata dal termine tedesco unheimlich è dovuta al riaffiorare, dopo una lunga rimozione, «di ciò che un giorno fu hiemlich (patrio), familiare», e che, in seguito alla rimozione, diventa perturbante, lugubre, sinistro. Uno dei temi sui quali Freud sofferma l’attenzione è «il motivo del sosia in tutte le sue gradazioni e configurazioni, ossia la comparsa di personaggi che, presentandosi con il medesimo aspetto, debbono venire considerati identici; l’accentuazione di questo rapporto mediante la trasmissione immediata di processi psichici dall’una all’altra di queste persone... così che l’una è compartecipe delle conoscenze, dei sentimenti e dell’esperienza dell’altra; l’identificazione del soggetto con un’altra persona sì che egli dubita del proprio Io e lo sostituisce con quello delle persone estranee; un raddoppiamento dell’lo, quindi una suddivisione dell’Io, una permuta dell’Io; un motivo del genere è infine il perpetuo ritorno dell’uguale, la ripetizione degli stessi tratti del volto, degli stessi caratteri, degli stessi destini, delle stesse imprese delittuose, e persino degli stessi nomi attraverso più generazioni che si susseguono».
Questo motivo suggerisce a Freud la definizione dell’istanza superegoica:
«La rappresentazione del sosia... può acquisire un nuovo contenuto traendolo dalle fasi di sviluppo successivo dell’Io. Nell’Io prende forma lentamente un’istanza particolare, capace di opporsi al resto dell’lo, un’istanza che serve all’autosservazione e all’autocritica, che effettua il lavoro della censura psichica e che ci diventa nota come coscienza morale. Nel caso patologico del delirio di essere osservati questa istanza si isola, si scinde dall’Io, diventa osservabile da parte del medico. Il fatto che esista un’istanza del genere, che può trattare il resto dell’Io come un oggetto, il fatto cioè che l’uomo sia capace di autosservazione, consente di conferire un nuovo contenuto alle vecchie rappresentazioni del sosia...».
In nota, Freud aggiunge: «Io credo che quando i poeti lamentano che il petto dell’uomo ospita due anime, e quando gli psicologi popolari parlano della scissione dell’Io nell’uomo, essi intravvedono questo dissidio che fa parte della psicologia dell’lo, tra l’istanza critica e il resto dell’Io».
Alla luce di questi testi è insensato sostenere che l’antropomorfismo superegoico rappresenti una svista freudiana o un cedimento della riflessione scientifica a residui animistici. Si tratta, invece, di un’intuizione prodigiosa: e non tanto perché omologa ogni struttura di personalità ad un sosia, attribuendo ad essa normalmente una doppia identità che la psicopatologia rivela, consentendone dunque l’oggettivazione. Portata alle estreme conseguenze, quell’intuizione promuove una teoria della mente bimodale, che postula un corredo binario di forme affettive innate.
Ma quell’intuizione è a tal punto perturbante che Freud tenta di scongiurarne l’impatto epistemologico sul modello pulsionale che va elaborando, con l’attribuire al Super-Io funzione di autosservazione e di autocritica, ponendo cioè i presupposti di una riduzione della scoperta entro i confini della psicologia dell’Io. Ma come si può parlare di autosservazione e di autocritica se il Super-Io, funzionando il più spesso inconsapevolmente, appare in grado di assumere l’Io come oggetto, di giudicarlo, dal livello delle fantasie a quello dei comportamenti, alla luce di sistemi di valore non di rado ad esso estranee, e, soprattutto, di indurre attraverso i sensi di colpa, un regime di vita orientato a mantenere un’omeostasi riparativa e/o punitiva dolorosa e frustrante che contraddice, nonché il principio del piacere, ogni umano bisogno di felicità?
Come tenteremo di dimostrare, il carattere perturbante della scoperta freudiana può risolversi solo ipotizzando che la funzione superegoica riconosca le sue matrici in una forma affettiva a priori sistemica, che sacralizza il legame sociale e, in conseguenza di ciò, assume l’individuo come funzione del gruppo cui appartiene.
Nel corso di ogni esperienza, quella forma integra e rinforza i valori culturali acquisti per mezzo delle interazioni interpersonali e elaborati cognitivamente. Il grado di compatibilità di tali valori con il corredo di bisogni individuali, del tutto indifferente dal punto di vista della forma affettiva superegoica, che ne impone la condivisione in nome del mito dell’armonia sistemica e del debito di appartenenza, è decisivo per il prodursi o meno di conflitti psicopatologici.
L’intento di questo saggio è di dimostrare che la scoperta del Super-Io, posto che si tenga ferma la distinzione tra forma a priori e contenuti determinati ontogeneticamente, può permettere un approccio radicalmente nuovo ai problemi psicopatologici e può indurre a formulare, in termini critici, una serie di questioni, inerenti il rapporto tra natura umana e cultura, che attraversano tutto l’ambito delle scienze umane e sociali, coinvolgendo anche le scienze neurobiologiche. Il paradigma psicopatologico che proponiamo, strutturale e dialettico, porta alle estreme conseguenze epistemologiche ciò che è implicito in quella scoperta: la struttura bimodale della personalità, che si fonda su un corredo naturale di bisogni binario il quale, in rapporto alle interazioni ambientali, può essere mortificato, scisso o integrato dialetticamente, ma mai estinto nelle sue potenzialità intrinsecamente conflittuali. Se tale paradigma dovesse risultare capace di spiegare i fenomeni psicopatologici, c’è da chiedersi perché esso non sia già stato formulato.
Quanto a Freud è agevole fornire una risposta.
Il turbamento prodotto dal progressivo rendersi conto, in rapporto all’esperienza clinica, della funzione meramente punitiva e mortificante dell’istanza superegoica segna tutta l’ulteriore evoluzione del suo pensiero. Non già la scoperta e la definizione strutturale, bensì la riflessione freudiana sul Super-Io pone in luce l’affiorare di un animismo che sarebbe più giusto definire teomorfico che antropomorfico. La severità crudele e sadica che Freud a più riprese stigmatizza sembra infatti rievocare il fantasma di un dio biblico votato a tormentare le creature che ha prodotto e delle cui imperfezioni si pente. Freud si rende conto che il modo di funzionare, a livello psicopatologico, del Super-Io rende insostenibile la teoria libidica. E impossibile, infatti, in base alla fissazione al principio del piacere, interpretare la vita infelice che i disagiati psichici conducono pur di non rinunciare alla soddisfazione di una pulsione libidica.
Ma la difficoltà insormontabile, praticamente e teoricamente, in cui Freud si imbatte, concerne la pratica psicoanalitica, nel corso della quale l’assoggettamento dell’Io al Super-Io punitivo appare frequentemente irreversibile. Nonché preda di un bisogno anarchico di piacere, le persone disagiate sembrano non di rado affette da un perverso bisogno di soffrire e di espiare, al punto tale che ogni tentativo di indurre un allentamento dei sensi di colpa dà luogo a dei peggioramenti. In termini dinamici, sembra che l’Io, benché acquisisca, in virtù dell’analisi, la capacità di connotare le sue colpe come meramente immaginarie, non possa sfuggire comunque alla necessità di scontarle, rimanendo in una condizione di patetica, e talora drammatica, subordinazione all’istanza superegoica. Messo di fronte all’evidenza dei dati clinici, Freud non ricusa di riconoscere che il disagio psicopatologico è sempre alimentato e mantenuto dagli eccessi superegoici. Tale riconoscimento, dovuto ad una radicata onestà intellettuale, avrebbe potuto produrre una teoria della natura umana incentrata su una drammatica predisposizione sociale che, per effetto di interazioni conflittuali con l’ambiente, si rivolge contro l’individuo stesso. Ma, a tal fine, sarebbe occorsa una capacità di critica storicosociale ben maggiore di quella di cui Freud disponeva. Non potendo dialettizzare le categorie di alto e basso, morale e politico, che gli stanno a cuore, Freud non può accettare che la civiltà in cui crede sia, nonostante i suoi indubbi valori, strutturata in forma alienata rispetto ai bisogni della natura umana.
Egli è convinto, come scriverà in L’avvenire di un’illusione, che la civiltà rappresenti «qualcosa che fu imposta ad una maggioranza recalcitrante da una minoranza che aveva capito come impossessarsi del potere e dei mezzi di comunicazione», e che tale condizione deve perpetuarsi, dato che «non è possibile evitare che la massa sia dominata da una minoranza, così come non si può fare a meno di imporre il lavoro nella vita civile; le masse sono infatti svogliate e prive di senno, non amano la rinuncia pulsionale, non possono con argomento alcuno essere convinte dell’inevitabilità di quest’ultima, e gli individui che le compongono si offrono vicendevolmente appoggio nel dare libero corso alla propria sfrenatezza. Soltanto l’influenza di individui esemplari, da esse riconosciuti come loro capi, può indurle alle fatiche e alle rinunce da cui dipende il permanere della civiltà».
Non ci soffermeremo, per ora, sul paradosso per cui, nell’opera rivolta a dissacrare la religione come mito infantilizzante, Freud ribadisca la necessità di una struttura sociale gerarchica atta a controllare le tendenze incivili proprie delle masse. L’ideologia freudiana rimane abbarbicata alla nostalgia dell’Impero e si rivela incapace di dare senso ai fermenti socialisti che seguono al suo crollo. Purtroppo, questa visione del mondo influenza potentemente il sistema teorico psicoanalitico, inducendo Freud ad ipotizzare che il Super-Io, rappresentante soggettivo della cultura, dell’autorità e della tradizione, per quanto crudele possa apparire, deve avere una sua ragione d’essere.
È dunque un’esigenza logica che fa capo ad un presupposto ideologico, che impone a Freud di rimestare in “basso”, nella natura umana e nella storia, alla ricerca del disordine pulsionale che giustifica la perversione superegoica. L’esito della “ricerca” è noto.
Paradossalmente, nel corso degli ultimi anni, più si accentua la consapevolezza clinica di Freud del carattere persecutorio dell’istanza superegoica, più egli vede in essa l’estremo rimedio contro una natura umana animata dall’istinto di morte, e cioè da una primaria e «cieca ostilità contro tutti e contro tutto», che, se non fosse duramente repressa, voterebbe la civiltà alla catastrofe.
Un rimedio meno drammatico potrebbe essere rappresentato dall’Eros, che tende a legare e a familiarizzare gli esseri umani. Ma, nonostante la tradizione psicoanalitica abbia voluto attribuire alla contrapposizione tra Eros e Thanatos un significato dialettico, tale significato è assente nel pensiero freudiano. Il conflitto irriducibile, che solo un’auspicata mutazione culturale potrà risolvere, si pone tra una natura umana in sé e per sé meramente distruttiva e un bisogno di conservazione della vita individuale e sociale che, nell’ultimo Freud, non si pone come pulsione bensì come derivato dell’istinto di morte e cioè come riparazione all’insorgere di un senso di colpa primario.
Se, dunque, la scoperta del Super-Io come istanza potenzialmente civilizzante, che fa capo alla predisposizione sociale della natura umana, e nel contempo alienante, poiché mantiene l’Io in una condizione di perenne minorità rispetto ai valori sociostoricamente determinati che essa veicola, si può ritenere scientifica e rivoluzionaria, l’interpretazione che Freud ne fornisce per giustificare la funzione persecutoria che essa assolve nelle esperienze psicopatologiche appare tributaria di un’ideologia radicalmente pregiudiziale nei confronti della natura umana. È ovvio, dunque, porsi il problema se quella scoperta non possa essere restaurata nella sua scientificità, e portare ad esiti diametralmente opposti a quelli cui è pervenuto Freud.
Il radicalismo dell’ipotesi dell’istinto di morte non poteva non produrre contraccolpi nel movimento psicoanalitico. Di fatto, come è stato dettagliatamente documentato da Greenberg e Mitchell, esso ha prodotto una scissione sia sul piano della teoria che sul piano della pratica terapeutica. Al modello pulsionale, che nega alla natura umana una qualunque predisposizione sociale, e insiste ad individuare nell’angoscia primaria prodotta dalla pulsione aggressiva la motivazione dinamica dello sviluppo sociale della personalità (cfr. J. Goldberg), si è contrapposto, per merito di Sullivan, Hartmann, Fairbain, Bolbwy, Winnicott, M. Mahler, Kohut, Stern, Emde, un modello che, pur nella sua eterogeneità, riconosce come denominatore comune l’attribuzione alla natura umana di una spiccata predisposizione alla relazione sociale sia sul registro affettivo che su quello cognitivo.
L’irriducibilità ideologica di questi due modelli, che fanno capo a concezioni antropologiche antitetiche, è stata lucidamente analizzata da Greenberg e Mitchell.
Ciò che a noi preme sottolineare è che il modello relazionale, affettivo, cognitivo, nonostante l’insistente riferimento al processo di socializzazione come processo di interiorizzazione e di elaborazione costruttiva di relazioni interpersonali e di valori culturali, ha sortito l’effetto paradossale di porre tra parentesi, con l’antropologia freudiana, tutta l’ampia problematica inerente il rapporto tra natura umana e cultura, e, per quanto riguarda questa, tra locale e globale che Freud è stato costretto ad affrontare da una personale vocazione filosofica non meno che dalla necessità di spiegare la funzione superegoica, in particolare per quanto concerne il ruolo che essa assolve nelle esperienze psicopatologiche. È difficile valutare in quale misura questa messa tra parentesi, una vera e propria rimozione, dipenda, per dirla con Rapaport, dagli sconcertanti problemi legati alla concezione del Super-Io, che impongono alla psicoanalisi un cambiamento paradigmatico radicale, e in quale misura essa sia la conseguenza di un progressivo restringimento delle ricerche e delle teorizzazioni nell’ambito della infant research. Appare chiaro, però, che la psicologia del Sé, nel suo sforzo di sormontare il punto di vista strutturale freudiano, nonostante i suggestivi richiami al processo di costruzione della personalità come processo che evolve attraverso fasi di integrazione e di conflitto con l’ambiente interpersonale, appare del tutto incapace, in conseguenza di una eccessiva valorizzazione dei momenti affettivi che ineriscono quel processo, di ricondurlo e spiegarlo, nei suoi successi e nei fallimenti, sul registro delle matrici entro cui esso si realizza: il rapporto dialettico tra natura umana e cultura, e tra locale e globale. Il rifiuto della metapsicologia, promosso dall’insofferenza per le pretese filosofiche del sistema freudiano, diventa, di conseguenza, una nuova ideologia che restringe l’ottica della ricerca e della teoria in un’attenzione un po’ miope per l’individuo, la cui irripetibile unicità viene ricondotta e resa complementare alla unicità dell’ambiente interpersonale entro il quale si costruisce il Sé.
Per questa via, pur fertile per alcuni aspetti, di cui si renderà conto successivamente, si accantona non solo la problematica freudiana, incentrata sulla ricerca di una legge universale atta a spiegare, filogeneticamente e ontogeneticaniente, il passaggio dalla natura alla cultura e, quindi, almeno in senso formale, la causa dei conflitti psicopatologici; si accantona anche in nome di una pretesa fedeltà alle persone e ai fatti clinici colti nella loro singolarità, la problematica specifica che autorizza la definizione della psicopatologia come disciplina autonoma nell’ambito delle scienze neurobiologiche, umane e sociali: l’invarianza delle strutture psicopatologiche, le cui forme elementari sembrano dotate della misteriosa tendenza a replicarsi a partire da insiemi di variabili — costituzionali, familiari, socioeconomiche e culturali — i più eterogenei.
L’intento di questo saggio consiste nel dimostrare che l’approccio multidimensionale, orientato a valutare quelle variabili con attenzione molto maggiore rispetto alla tradizione psichiatrica, per non rischiare di tradursi in una sterile collezione di singolarità, postula l’integrazione con un approccio strutturale; questo, a sua volta, richiede, per non esaurirsi sul piano della fenomenologia descrittiva e/o comprensiva, di rivalutare la scoperta freudiana del Super-Io e di iscriverla in una nuova cornice di riferimento. Portata alle estreme conseguenze epistemologiche, questa scoperta, che illumina il rapporto dialettico tra natura umana e cultura, trascende infatti il piano della psicopatologia e diventa una chiave dell’esperienza umana nel mondo.
Capitolo secondo
II mito gerarchico
L’identificazione freudiana del Super-Io con la coscienza morale e l’attribuzione ad esso di un ruolo produttivo e difensivo della socialità dalle pulsioni intrinseche alla natura umana, è un errore epistemologico e ideologico. Anzitutto, negando una predisposizione naturale alla socialità, la genesi della cultura diventa un problema insolubile. Darwin, ne L’origine dell’uomo (1871), rivendica la necessità logica di attribuire alla natura umana un corredo di emozioni sociali innate attive e oggettivabili già negli animali.
I legami interpersonali e comunitari che tali emozioni producono rappresentano la matrice della cultura. Scrive Darwin: «Qualsiasi animale, dotato di istinti sociali ben marcati... acquisterebbe inevitabilmente un senso morale e una coscienza, non appena i suoi poteri intellettuali fossero divenuti tanto sviluppati, o quasi altrettanto che nell’uomo». Ma Freud, individuando la chiave della psicopatologia nella opposizione irriducibile tra natura umana e cultura, è costretto ad ipotizzare invece un passaggio critico filogenetico, che si ripeterebbe nel corso dell’ontogenesi. Elaborata in Totem e tabù, tale ipotesi appare insostenibile. Se il parricidio va preso alla lettera, come evento drammatico avvenuto sul piano generazionale, nulla consente di comprendere l’affiorare del rimorso nei figli di una classe di padri privi di ogni sensibilità morale. Se, viceversa, l’evento viene ricondotto sul piano storico, esso allude ad un cambiamento politico e culturale promosso da un’esigenza di giustizia, e cioè da una istanza morale. Come spesso accade, in Totem e tabù Freud propone soluzioni inaccettabili di problemi colti, con grande onestà intellettuale, come non eludibili.
Il problema in questione non è la nascita della coscienza morale bensì della coscienza sociale cioè della coscienza — visceralmente connotata — di appartenere ad una comunità gerarchicamente organizzata, il cui equilibrio sistemico — che ne assicura la stabilità e la riproduzione sociale — postula la sottomissione dei singoli membri alle regole, alle norme e alle consuetudini il cui rispetto promuove e mantiene il bene comune, e cioè il patrimonio —materiale e spirituale — condiviso.
In quanto funzione dell’appartenenza, la coscienza sociale è partecipativa e replicativa: espressione della forma affettiva sistemica, essa promuove l’integrazione cognitiva dei valori culturali propri della comunità e l’assoggettamento individuale all’ordine sociale esistente, identificato come espressione del bene comune. In quanto espressione di una logica affettiva e di un meccanismo replicativo, la coscienza sociale si sviluppa a livello inconscio ed è, in una certa misura, rappresentata a livello cosciente sotto forma di dovere sociale. È ovvia la sua identificazione con il Super-Io. Assumendo la moralità come derivato dell’angoscia sociale, Freud eguaglia Super-Io e coscienza morale. Ma questa eguaglianza vale solo per il fatto che la replicazione dei valori culturali implica la replicazione delle norme, delle regole, delle consuetudini e dei costumi propri del gruppo di appartenenza, e cioè di un ordine gerarchico emozionalmente sacralizzato. In virtù della forma affettiva sistemica che lo sottende, il Super-Io replica la cultura propria della comunità di appartenenza come se si trattasse di un ordine “naturale” e funzionale all’armonia sistemica. È evidente che, per questo aspetto, ciecamente replicativo, esso rappresenta, nella struttura della soggettività, una mente sociale che integra nella misura in cui aliena, e la cui logica affettiva veicola un mito: il mito gerarchico, che assume l’ordine di cose esistente, fondato sulla disuguaglianza dei membri, e cioè sulla distribuzione gerarchica di ruoli, status e beni, come ordine sacro che assicura l’armonia del sistema, la sua stabilità e la riproduzione sociale.
Intrinseco alla natura umana, in quanto espressione della forma affettiva che sottende il bisogno di appartenenza/integrazione sociale, il mito gerarchico offre ad ogni sistema sociale la possibilità di naturalizzare ideologicamente se stesso e il suo ordinamento. Le sue matrici affettive e le indefinite possibilità di naturalizzazione ideologica spiegano la sua lunga durata nel corso della storia, il suo configurarsi come struttura culturale onnipresente. Di fatto, il mito gerarchico è una struttura culturale molto rigida per alcuni aspetti e straordinariamente plastica ed adattabile per altri.
La prima caratteristica ne assicura il primato, fino a che ad essa non si opponga una coscienza critica; la seconda caratteristica, che fuorvia la coscienza critica, ne permette la sopravvivenza anche quando i cambiamenti culturali sembrano incompatibili con esso.
Etimologicamente “gerarchia” significa potere sacro: adottato nel XIV secolo in riferimento all’ordinamento della Chiesa Cattolica, espressione diretta del volere divino, il termine, dal XVII secolo in poi, è stato laicizzato ed esteso all’ordinamento amministrativo e politico. La condensazione storica di questi diversi significati si è espressa nei regimi monarchici e assolutisti. Esauritisi questi regimi, il potere politico ha tentato di assimilare il carattere sacrale del mito gerarchico. Ciò fornisce la prova che questo mito può prescindere dal riferimento ad un potere assoluto, ma a patto di sostituire questo con un processo di razionalizzazione che assuma il posto occupato dai membri nella scala gerarchica come espressione diretta dei loro meriti o demeriti. Il criterio meritocratico, che è un elemento essenziale del mito gerarchico, poiché permette di giustificare la disuguaglianza dei membri, non è affatto in contrasto con la matrice originariamente religiosa del mito.
La Bibbia esordisce, ex abrupto, con la creazione del mondo e dell’uomo. Ma la presenza originaria del demonio implica una preistoria, atta a dar conto dell’origine del male che, da un punto di vista teologico, non può essere ricondotto alla creazione divina. Non a caso, di recente, la dottrina del demonio è stata riproposta dal Papa come verità di fede.
Essa, di fatto, nell’edificio teologico, serve a spiegare l’origine del male come causa della diseguaglianza tra gli esseri. L’elaborazione di questa dottrina, assunta quasi integralmente dalla Chiesa, si deve ad Origene (1) e risale al II secolo d.C.
Il problema di Origene è di accordare la diseguaglianza delle creature con la giustizia divina. A tal fine, occorre ammettere una primitiva uguaglianza delle creature: «Dio quando ha creato all’inizio quello che ha voluto creare, non ha avuto altro motivo di creare che se stesso, cioè la sua propria bontà. Dato che lui stesso è la causa di ciò che doveva ancora essere creato e che in lui non c’era vanità alcuna, né cambiamento, né impossibilità, ha creato quelli che ha creato tutti uguali e simili». Ma, le creature essendo dotate di libero arbitrio, «la libertà ha spinto ciascuno sia a progredire grazie all’imitazione di Dio, sia a decadere per negligenza».
L’ordinamento gerarchico delle creature dipende dunque dai meriti di ciascuna. Ma il movimento verso l’alto e verso il basso, che disporrebbe gli esseri in un continuum gerarchico, viene drammaticamente sconnesso da un evento molto più grave della negligenza: la ribellione. «All’origine tutti gli spiriti erano puri... servivano Dio e adempivano i suoi comandamenti. Il diavolo, che era uno di essi, avendo il libero arbitrio volle opporsi a Dio, e Dio lo rifiutò».
Nell’edificio teologico cattolico, la dottrina del diavolo, dunque, è funzionale alla conferma del mito gerarchico nei suoi momenti essenziali, correlati tra loro: l’attribuzione a Dio, che rappresenta il potere supremo, di una giustizia infinita, espressa dalla eguaglianza, dalla libertà e dall’armonia delle creature; la giustificazione della disuguaglianza in termini di meriti e di demeriti acquisiti attraverso l’esercizio, imitativo o negligente, della libertà personale; la proposizione della sottomissione della volontà personale alla volontà divina come merito sommo, riconoscimento libero della Super-Iorità naturale di Dio; la opposizione e la ribellione a Dio come causa di conflitto e di disarmonia che introduce il male nel sistema e postula un’irreversibile condanna.
Spogliata dei contenuti teologici, la struttura del mito gerarchico è costituita da tre elementi essenziali: la definizione di un potere oggettivo e supremo; una struttura sociale subordinata ad esso ma dinamica, tale cioè da riconoscere movimenti di ascesa e di discesa come espressioni rispettivamente dei meriti e dei demeriti personali; la stigmatizzazione della ribellione al potere come colpa che postula o l’espiazione o l’esclusione dal sistema.
Risulta evidente che questa struttura, essendo meramente formale, può essere adottata da qualunque potere riesca a legittimarsi come oggettivo, pretenda esso di rappresentare la sovranità divina, una legge di natura – per cui il più forte merita il primato –, o una legge di cultura – per cui il meritevole eccelle. Negli ultimi due casi, l’armonia del sistema postula una scala di valori che promuove la sottomissione e il consenso, nonché meccanismi di sanzione e di punizione degli oppositori e dei ribelli.
Identificata la struttura logica ed ideologica del mito gerarchico, ci si può chiedere quale sia il fattore ultimo che ne assicura la coerenza e la funzionalità indipendentemente dai contenuti – religiosi, naturali o culturali – con cui esso si camuffa. È fuor di dubbio che questo fattore sia identificabile con la condanna di chi si oppone al mito. Ma il passaggio da un sistema di valori religioso ad uno laico, comporta una configurazione assolutamente nuova della condanna. Nel mito religioso, il diavolo, ribelle per eccellenza, appare insensibile al pentimento: la sua volontà, fissata nel male, è immune dal senso di colpa. Nella progressiva laicizzazione del mito, è l’appartenenza sociale, e non la vita eterna, il bene supremo; di conseguenza, la condanna si configura come esclusione radicale dal contesto sociale, secondo due forme. Essa, infatti, può essere sanzionata oggettivamente con modalità varie che vanno dalla messa al bando alla reclusione istituzionale e alla emarginazione; oppure può essere indotta soggettivamente, in virtù dei sensi di colpa in conseguenza dei quali i soggetti colpevoli si condannano e si escludono. Sia l’esclusione oggettiva sia l’autoesclusione attestano il potere, sociale non meno che morale, del gruppo di appartenenza sull’individuo. Ma quanto più questo potere si esercita per mezzo di valori introiettati, tanto più esso pone in luce la predisposizione sociale della natura umana e il suo carattere di forma a priori dotata di una sorta di automatismo, tale cioè da produrre sensi di colpa quali che siano le ragioni per cui l’individuo entra in conflitto con il gruppo d’appartenenza.
La trasformazione più rilevante del mito gerarchico, avvenuta nel corso della storia, concerne la progressiva sostituzione dei meccanismi di condanna oggettiva con quelli di condanna soggettiva. In altri termini, i primi, un tempo assolutamente prevalenti, sono ormai meccanismi residui: essi tendono a scattare quando la condanna soggettiva non funziona.
La scoperta del Super-Io coglie, con assoluta evidenza, la laicizzazione e la interiorizzazione del mito gerarchico, in virtù della quale gli “angeli” ribelli si autocondannano e si autopuniscono.
Istallato nella struttura della personalità, il Giudice, il cui codice di leggi è rigorosamente fedele al mito gerarchico, funziona con un’efficacia che supera di gran lunga quella di qualunque apparato repressivo, giudiziario e poliziesco.
La laicizzazione del mito gerarchico ha comportato un mutamento critico del sistema di valori e una netta accentuazione della sua plasticità. Pur mantenute formalmente, le categorie religiose di alto e basso hanno assunto un significato radicalmente diverso, mondano e sociale: l’alto si è configurato come potere politico, cultura, prestigio, ricchezza, raffinatezza; il basso come impotenza, ignoranza, miseria, rozzezza, disordine. Questa scala di valori, esplicitamente sociale, si è posta anche come metro di misura morale. La moralità, dal punto di vista del mito gerarchico laicizzato, consiste, né più né meno, nel grado di adattamento alle regole del gioco del sistema sociale; e il grado di adattamento è espresso immediatamente dal posto occupato nella scala gerarchica. Data la mobilità del sistema sociale, coloro che stanno in basso non possono starci che per una colpa morale, il cui spettro va dall’inerte pigrizia ad una sterile invidia e a una rivendicazione distruttiva. Venendo meno i contenuti religiosi, dogmaticamente fissi, il mito gerarchico laicizzato tende a modellarsi plasticamente in rapporto all’evoluzione sociostorica. Finché appare necessario, esso veicola i valori conservatori della tradizione; ma, non appena si determinano nuove esigenze sistemiche, incompatibili con quei valori, il mito gerarchico, più o meno repentinamente, si aggiorna, e giunge a rinnegare la tradizione in nome di un rinnovamento di valori che, naturalmente, non investe la struttura del mito. Ricostruire le vicissitudini del mito gerarchico nel corso della storia esorbita ampiamente dall’ambito delle nostre competenze. In un capitolo ulteriore, quello sui codici di normalizzazione, si tenterà di definire la scala di valori di cui esso attualmente si camuffa. Un solo aspetto storico di quelle vicissitudini ci sembra di poter restituire con una qualche credibilità, poiché esso si riflette nel sistema di pensiero freudiano.
Il passaggio dalla prima alla seconda topica registra, infatti, inconfutabilmente, un cambiamento di valori che Freud individua, pur non essendo in grado di interpretarlo che sul piano psicologico. Alla fine del XIX secolo egli, infatti, si imbatte nel codice sessuofobico, estremo residuo del mito gerarchico religioso, utilizzato al fine di mantenere una struttura sociale patriarcale. Nel giro di alcuni decenni, questa struttura si evolve, eliminando ogni residuo religioso, poiché deve promuovere, sotto la bandiera dell’amor patrio, un’identificazione che induce gli uomini ad accettare la cultura della guerra e della morte.
Ai padri non basta più la soggezione dei figli; ad essi richiedono, in una misura mai sperimentata nel corso della storia, il sacrificio della vita.
Il mito gerarchico patriarcale, fondato su di un ordinamento morale sessuofobico, si trasforma, poiché esso deve promuovere una pulsione di morte, sia pure orientandola contro il nemico e rendendola funzionale all’idea della patria. Pochi anni dopo, questo mutamento diventa ancor più manifesto in virtù dell’ideologia nazista, che Freud, fino al momento in cui è costretto dalla sollecitudine degli amici a rifugiarsi in Inghilterra, tende ad ignorare, poiché essa gli avrebbe posto sotto gli occhi una verità dolorosa, atta a scompaginare l’edificio psicoanalitico. La verità è che, nonché difendersi dal parricidio, la civiltà deve difendersi dalla distruttività del potere, che promuove il figlicidio e il fratricidio, e ripropone, sotto le forme del razzismo, un mito gerarchico assolutamente laico, volto a difendere i valori più elevati della civiltà europea dalla barbarie comunista, e fondato sulla identificazione di un popolo tra i più civili con un capo che propone una scala di valori morali di assoluto rigore, il cui scopo ultimo è la purificazione della natura umana da tutti i germi di bassezza che in essa allignano.
Se Freud avesse rivolto attenzione all’ideologia nazista, gli sarebbe stata chiara la differenza radicale tra Super-Io, come istanza che assoggetta al mito gerarchico, e coscienza morale, che può ad esso opporsi. Ma è giusto chiedersi perché e in nome di che cosa.
Capitolo terzo
Integrazione sociale e opposizione
Il Super-Io è dunque un’istanza funzionale all’affermazione e alla persistenza del mito gerarchico, che, istallata nella struttura della personalità, mira a mantenere l’Io in una condizione di perenne minorità sociale e cioè a mortificare le sue capacità critiche in rapporto ai valori che quel mito veicola e all’ordinamento sociostorico lui deve appartenere.
Il potere del Super-Io si definisce, indubbiamente, nel corso della fase evolutiva della personalità, vuoi in rapporto all’idealizzazione di cui l’infante investe gli adulti – dovuta ad un difetto di strumenti critici –, vuoi in rapporto alla dipendenza da essi. Ma che cos’è che ne mantiene il dominio nella struttura adulta della personalità, anche quando questa dispone di un’attrezzatura critica adeguata a demistificarlo e, per di più, quando il quadro di valori veicolato dal Super-Io non è riconosciuto dalla coscienza nella sua validità oggettiva? La risposta di Freud è che, nel bambino come nell’adulto, il potere superegoico si mantiene in virtù dell’angoscia sociale, e cioè della paura di una rappresaglia da parte degli altri nel caso il soggetto si abbandoni ad esprimere senza controllo le pulsioni che lo animano. Non si può non essere d’accordo. In ogni esperienza di disagio psichico, la “frattura del cristallo” lascia trasparire fantasie pulsionali anarchiche tenute rigidamente sotto controllo dal Super-Io che fa incombere su di esse, e su di una loro possibile realizzazione, la minaccia di una radicale esclusione sociale, sotto forma di morte, di follia – cui si associa l’internamento manicomiale –, o criminalità – cui si associa la reclusione carceraria. Ma il potere repressivo e punitivo del Super-Io che, nella massima parte delle esperienze, comporta, con il sacrificio delle pulsioni, la rinuncia a vivere e talora alla vita stessa, induce a pensare che la paura dell’esclusione sociale attesti, nonché la percezione realistica del rapporto di potere tra soggetto e società, un bisogno “viscerale” e irrinunciabile, al quale tutto può essere sacrificato: il bisogno di integrazione sociale, inteso come bisogno di appartenere, sia pure formalmente, ad un gruppo umano e di essere confermato.
Paradossalmente, la scoperta del Super-Io e il modo in cui questa istanza funziona nelle esperienze fenomenologicamente più animate da pulsioni anarchiche impongono di contestare la pretesa originaria asocialità della natura umana. Ammettendo l’esistenza, nel corredo biologico della natura umana, di un bisogno di integrazione sociale che, nelle fasi evolutive dello sviluppo della personalità, si esprime sotto forma di dipendenza dagli adulti, l’astuzia del mito gerarchico, che utilizza la dipendenza per strutturarsi sotto forma di Super-Io, appare orientata a far pagare ogni tentativo critico della coscienza di attaccarlo al prezzo della minaccia di un’esclusione sociale.
Il mito gerarchico si afferma, dunque, facendo leva sul bisogno di integrazione sociale, in nome dell’armonia: e l’armonia implica che i rapporti di potere, la disuguaglianza sancita dal mito stesso siano riconosciuti come “naturali” e oggettivi soprattutto da parte di coloro che stanno in basso nella scala gerarchica. La persistenza del mito gerarchico nella storia induce a pensare che l’armonia, intesa come socialità immune da conflitti, eserciti un fascino persistente e quasi irresistibile sugli uomini. Di certo, se la storia, come accade anche a Freud ne Il disagio della civiltà, viene ricostruita da un punto di vista événementiel – attraverso la guerra e i conflitti fra tribù, razze, popoli e stati – il fascino dell’armonia viene brutalmente smentito.
Ma si tratta non già della storia, bensì di un punto di vista su di essa, che privilegia i fatti politici: una storia di “avvenimenti” – come scrive Le Goff (1) –, teatro di marionette che nasconde la vera storia, quella che si svolge tra le quinte e nelle strutture nascoste dove bisogna frugare per snidarla, analizzarla, spiegarla. Se la parzialità della storia politica viene superata in nome di una storia totale, storia di strutture economiche, sociali e mentali e, soprattutto, di masse, di uomini nel tempo, ciò che sorprende e turba, nonché i conflitti e le atrocità, è la straordinaria capacità degli uomini di subire i capricci del potere, tollerandoli, subordinandovisi, servendoli e, non di rado, dando ad essi credito. E’ solo l’irrazionalità del potere che, talora, spinge i suoi eccessi a livelli intollerabili, a determinare l’opposizione, la protesta, la ribellione.
E’ in nome del bisogno di integrazione sociale che i disagiati psichici tendono a subire la dittatura superegoica, cercando di adattarsi ad essa anche al prezzo di rinunciare a vivere. I raptus, nei quali l’opinione pubblica legge la prova dell’inadeguatezza dei disagiati ad adattarsi alle regole del buon vivere civile, sono nulla più che la minuscola punta di un iceberg di umiliazioni, di tormenti, di frustrazioni, di rappresaglie soggettive. Come per le repentine esplosioni di protesta delle masse nella storia, c’è da sorprendersi della loro rarità, piuttosto che della violenza che le caratterizza.
Il potere del Super-Io, rappresentante psicologico del mito gerarchico, si fonda, dunque, sulla capacità che esso ha di sfruttare il bisogno di integrazione sociale. Ciò posto, c’è un problema che balza agli occhi: un problema di grande portata scientifica e politica, che, a nostro avviso, può trovare una risposta laddove non si è mai cercata, nelle strutture di esperienza psicopatologica. L’assoggettamento dell’Io al Super-Io non può non essere giustificato, infatti, che in nome di un bisogno di integrazione sociale radicato nella natura umana. Ma è pur vero che l’assoggettamento, per quanto possa giungere ad impedire ogni manifestazione di vita, e comportare una frustrazione estrema, non riesce ad estinguere la pressione fenomenologica delle pulsioni. E’ vero, anzi, come Freud ha messo in luce, che la severità del Super-Io è un indice immediato di quella pressione.
L’ipotesi della pulsione di morte è un tentativo di spiegare questo sconcertante paradosso. Ma è un tentativo criticabile e in ultima analisi insostenibile, che esso postula, all’interno delle personalità psicopatologiche, una singolare scissione tra una parte totalmente assoggettata al Super-Io e, in virtù di ciò, alle esigenze più elevate della moralità e della civiltà, e una parte rimasta ancorata ciecamente ad una natura asociale e amorale.
Alla soluzione freudiana si può contrapporre, anzitutto, l’ipotesi del bisogno di integrazione sociale. Ma è proprio questa ipotesi, in sé e per sé insufficiente a spiegare il conflitto psicopatologico tra Super-Io e fenomenologia pulsionale, a postularne, per via logica, un’altra. Assumendo il bisogno di integrazione sociale come connaturato al corredo biologico umano, non è difficile vedere in esso il fondamento della plasticità educativa dell’infante, e, in senso lato, della plasticità culturale dell’adulto. Ma, tenendo conto della lunga dipendenza infantile dagli adulti e della tendenza all’idealizzazione di questi, e dei valori culturali che essi veicolano condizione che giustamente Laing ha omologato ad uno stato di ipnosi c’è da chiedersi come mai gli uomini non siano semplicemente “repliche” culturali. Di fatto, l’istanza superegoica tende a riprodursi lungo le catene generazionali con caratteristiche uguali e, se essa non incontrasse alcun ostacolo, non si produrrebbe alcun mutamento culturale, se non a livello di camuffamenti ideologici. Ma la struttura della personalità umana, per quanto possa essere assoggettata, non si riduce all’istanza superegoica. Trasparente nelle strutture psicopatologiche in virtù della pressione pulsionale anarchica, la resistenza opposta al mito gerarchico non può avere un significato più generale, che in esse risulta distorto?
E’ logicamente ipotizzabile che la plasticità educativa della natura umana, dovuta al bisogno di integrazione sociale, riconosca un limite intrinseco, biologicamente connotato esso stesso, atto a scongiurare che quel bisogno promuova una fenotipizzazione culturale, omogenea, totalmente tributaria del mito gerarchico. Tale limite, geneticamente intrinseco alla natura umana, può essere definito come un bisogno, il bisogno di opposizione, il cui fine è di promuovere una differenziazione dell’identità personale e l’acquisizione progressiva di un potere critico in rapporto alla realtà. Sarebbe questo bisogno, complementare rispetto a quello di integrazione sociale ma in tensione dialettica con esso, a rappresentare la matrice della coscienza morale, intesa come espressione critica, e dunque anche autocritica, di una coscienza affrancata dal mito gerarchico.
Consapevoli di introdurre, nell’ambito delle scienze dell’uomo, un concetto epistemologico nuovo, le cui conseguenze, posto che se ne verifichi la legittimità, sarebbero rilevanti, dobbiamo procedere con cautela, cercando di argomentare, anche a rischio di apparire accademici, le caratteristiche essenziali del concetto stesso.
Definire il bisogno di opposizione come un bisogno radicato nel corredo biologico della natura umana, significa anzitutto concepire l’evoluzione della personalità in termini dialettici. Favorita dalla plasticità delle strutture biologiche alle influenze ambientali, massima nel periodo di maggior dipendenza e permeabilità dell’essere umano, l’interazione natura/cultura riconoscerebbe come limite naturale, l’opposizione, e cioè la tendenza ad agire attivamente e selettivamente con l’ambiente. Presente fin dalla nascita, in quanto facente parte del corredo biologico della natura umana, il bisogno di opposizione si esprime secondo modalità correlate alla fase dello sviluppo, e, in particolare, al grado di strutturazione dell’Io. Prima che si delinei e prenda forma un abbozzo dell’Io, sostanzialmente nel corso del primo anno e mezzo, il bisogno di opposizione si manifesta sotto forma di interazioni meramente “viscerali”, legate al sentire, alle influenze esterne. Successivamente, esso tende a configurarsi sotto forma di affermazione della volontà individuale, dando luogo alle crisi di opposizione ben note agli psicologi dell’età evolutiva. In queste fasi, l’affermazione della volontà è fine a se stessa, poiché tende prevalentemente a sancire il potere dell’lo di opporre un rifiuto alle influenze ambientali. E per questo che le crisi di opposizione appaiono, il più spesso, irragionevoli e capricciose.
Solo un grado di integrazione dell’Io più elevato, consente al bisogno di opposizione di esprimersi in funzione dell’individuazione, e cioè di un’attività, più o meno equilibrata, volta a definire un rapporto selettivo con la realtà, tal che di questa alcuni aspetti vengano assimilati altri rifiutati. E’ straordinariamente importante tener conto del fatto che il passaggio dalla prima alla seconda infanzia è caratterizzato da un progressivo allentarsi dell’idealizzazione delle figure adulte: quasi sciogliendosi da un velo ipnotico, la coscienza, grazie all’attrezzatura di cui viene a disporre, comincia a cogliere la realtà umana nei suoi aspetti concreti, sempre più o meno contraddittori.
Da questo periodo si avvia un processo di differenziazione e di individuazione che culmina nella crisi adolescenziale, crisi di opposizione per eccellenza, nel corso della quale il Super-Io, erede dei valori veicolati dagli adulti, viene attaccato. E in questo periodo che l’Io può venire alla luce autonomamente, dotandosi di funzioni di autosservazione e di autocritica, procedendo cioè verso la definizione sia pure sommaria di una coscienza morale personale, o, altresì, rimanere soggetto al potere superegoico. E’ in questo periodo, che si esaurisce con la prima giovinezza, che si definisce l’orientamento ideologico di ogni individuo, come espressione della strutturazione della personalità, dominata più o meno dal Super-Io.
Ma il bisogno di opposizione non cessa, ovviamente, di funzionare al di là di questo periodo. Esso continua a premere per tutta la vita, mirando ad un equilibrio sempre più elevato tra integrazione sociale e individuazione. Questa pressione può provocare cambiamenti di sistemi di valore repentini anche nel corso dell’età adulta, così come e lo vedremo può dar luogo a crisi psicopatologiche.
Risulta chiaro che, dal nostro punto di vista, il Super-Io rappresenta una funzione complessa. In quanto forma, esso attesta la predisposizione della natura umana alla condivisione dell’esperienza del gruppo di appartenenza. Tale predisposizione, che occorre ammettere geneticamente determinata, è anzitutto emozionale e si esprime, nel corso del periodo evolutivo, sotto forma di attaccamento, identificazione e introiezione dei rappresentanti del gruppo di appartenenza e dei valori che essi trasmettono. Ma l’assimilazione del soggetto al gruppo, che investe la sfera emozionale, quella cognitiva e quella ideologica, non può andare al di là di una struttura di personalità che, con Riesman, si può definire autodiretta, governata cioè dall’interno da una potenza sociale che subordina l’Io.
La possibilità che l’Io divenga autonomo e dotato di un’identità propria passa necessariamente attraverso una crisi di opposizione. Tale crisi evolve in due fasi: la prima, che caratterizza tutti i periodi oppositivi della fase evolutiva, pone l’Io in grado di sperimentare che la sua volontà può esercitarsi sospendendo le influenze superegoiche, e cioè può porsi in antitesi rispetto ad esse; la seconda, dà luogo ad un’assimilazione selettiva dei contenuti superegoici, che integra una coscienza morale personale. La necessità di passare attraverso le crisi di opposizione è assoluta, indipendentemente dai contenuti superegoici in questione, i quali, teoricamente, possono essere anche globalmente restaurati e riconosciuti come validi. Il bisogno di opposizione funziona, dunque, come un meccanismo selettivo che promuove l’identità personale, attivandola in rapporto alle influenze ambientali e ponendola al riparo dal conformismo autodiretto, che sarebbe la conseguenza univoca del bisogno di integrazione e di condivisione sociale.
Molte difficoltà teoriche inerenti lo sviluppo della personalità e il rapporto tra mondo interno e mondo esterno verrebbero meno se si ammettesse che lo strutturarsi dell’identità personale avviene seguendo, mutatis mutandis, un modello codificato a livello biologico sotto forma di immunità.
Come l’organismo acquisisce la capacità di riconoscere se stesso la cosiddetta competenza immunitaria e di distinguere, in virtù di questa capacità, il sé dall’estraneo, mantenendo con l’ambiente un rapporto di scambio dinamico e selettivo che dà luogo alla ricezione di quanto, dall’esterno, può essere incorporato e assimilato, e cioè trasformato in sé, così la personalità, originariamente indistinta e confusa con l’ambiente sociale, si edifica in virtù della distinzione di sé e dell’altro e procede verso la sua identità “metabolizzando”, attraverso l’opposizione, le introiezioni dovute ai legami di identificazione.
Tale parallelismo ha, come limite, che l’estraneo in senso biologico è null’altro che estraneo, mentre, sotto il profilo psicologico, l’estraneo, benché riconosciuto come tale, è, inesorabilmente, anche un socius con cui occorre mantenere una relazione e condividere un’esperienza che ha sempre un qualche aspetto in comune.
Se si accetta l’ipotesi del bisogno di opposizione, la teoria freudiana della pulsione di morte può essere riformulata in termini dialettici. La distruttività fenomenologicamente presente nella struttura delle esperienze psicopatologiche potrebbe, infatti, essere interpretata come l’espressione di un bisogno di opposizione distorto dal non essersi mai espresso a livello di interazione reale. Questa ipotesi ha il pregio, a differenza di quella freudiana, di poter essere verificata: se essa è vera, infatti, i soggetti più inconsciamente distruttivi dovrebbero essere coloro che, in realtà, hanno il minimo potere di interagire attivamente con gli altri, di opporsi, non avendolo essi mai esercitato.
E il Super-Io, che si assume nei loro confronti il molo di difensore implacabile della civiltà, sarebbe la causa prima di una repressione del bisogno di opposizione, che, distorto, esso si affanna a controllare.
L’esperienza umana, sia nelle fasi evolutive che successivamente, si giocherebbe tutta sul registro della tensione, dialettica o adialettica, tra bisogno di integrazione sociale e bisogno di opposizione. Una integrazione sociale che si realizza senza opposizione avviene in virtù dell’identificazione dell’Io con il Super-Io, e cioè in nome di una rinuncia alla coscienza critica e all’autonomia. È proprio questo tipo di integrazione che viene promossa dal mito gerarchico, poiché essa lo preserva. Funzionale a tal fine, nell’ambito della storia della nostra civiltà, è la connotazione ideologicamente negativa del bisogno di opposizione identificato con una ribellione colpevole. Questo ricatto culturale è, paradossalmente, agevolato dalle matrici biologiche di quel bisogno, che affiora, nel corso dello sviluppo individuale, non meno che nella storia, prima della coscienza critica, secondo modalità “viscerali”, e dunque apparentemente irragionevoli, che lo espongono facilmente ad una razionalizzazione repressiva.
Il fondamento biologico del bisogno di opposizione, che lo espone alle rappresaglie superegoiche, dall’esterno prima e dall’interno della soggettività poi, è però una caratteristica straordinaria della natura e della specie umana, poiché la cultura può ostacolarlo, reprimerlo, distorcerlo, fino al punto di renderlo soggettivamente minaccioso, ma non eliminarlo.
Deve, in breve, perpetuamente fare i conti con esso: non solo sul piano, ormai ampiamente riconosciuto, della dialettica tra tradizione e cambiamento, bensì anche sul piano, più attuale, della dialettica tra ideologia dello sviluppo e bisogni umani. Su entrambi i versanti, rappresentati a pelle di leopardo nel tessuto sociale delle società avanzate, il Super-Io, in quanto agente del mito gerarchico, può essere, politicamente, socialmente e culturalmente, usato a fini di integrazione dell’individuo nel gruppo che, di fatto, coincidono con il suo asservimento.
Capitolo quarto
Dialettica dei bisogni
1.Teoria dei bisogni e antropologia filosofica
L’ipotesi che i bisogni di integrazione sociale e di opposizione facciano parte del corredo della natura umana implica il superamento, da parte di ogni scienza che abbia come “oggetto” l’uomo, del determinismo biologico e di quello culturale: dell’uno, poiché i bisogni sono un insieme finito di potenzialità che si esprimono solo in virtù della interazione con l’ambiente; dell’altro, perché essi, nella loro complementarietà e tensione reciproca, rappresentano i limiti della plasticità umana in rapporto all’ambiente.
Risulta immediatamente evidente che il concetto di bisogno rende insignificante quello psicoanalitico di pulsione, intesa come “spinta” che tende a scaricarsi, e, con esso, l’ipotesi che sia la frustrazione a civilizzare una natura che in sé e per sé non lo è.
Ammettendo, inoltre, che i bisogni rappresentano l’espressione di una programmazione genetica, mirante a integrare l’individuo nella società cui appartiene e, nel contempo, ad affrancarlo da una definizione meramente sociale della sua identità qualità, quest’ultima speciespecifica, che fa dell’uomo un animale potenzialmente critico nei confronti della struttura sociale e della cultura e, quindi, creativo, si può elaborare una teoria della personalità umana non meno rigorosamente psicobiologica rispetto a quella freudiana ma dotata di una dialetticità che a questa difetta.
Meno evidente è il contrasto tra la teoria dei bisogni e il cognitivismo. Ma tale contrasto si definisce e si chiarisce se si tiene conto che la teoria dei bisogni riabilita, nello sviluppo e nel funzionamento della personalità, il primato del sentire rispetto alla elaborazione cognitiva dei dati sensoriali. Nella loro più intima natura così come nelle manifestazioni più precoci, i bisogni sono, infatti, espressione immediata della sensibilità, e cioè di una modalità di rapporto con il mondo anteriore alla ragione.
E’ in virtù del “sentire” che si instaura l’identificazione con l’altro, originariamente fusionale; è in virtù del sentire che affiora, non appena si definisce un abbozzo dell’Io, l’opposizione della volontà propria alla volontà dell’altro, che inaugura la differenziazione. Solo successivamente i bisogni tendono ad organizzarsi cognitivamente, senza tuttavia perdere la loro peculiare connotazione affettiva. Come vedremo, l’organizzazione cognitiva può modellare i bisogni, rispettandoli, o entrare in conflitto con le loro radici affettive.
La comparsa dell’identificazione con l’altro come primus movens della socialità si deve a Rousseau (1), che la definisce come una capacità propria dell’anima umana anteriore alla ragione: capacità in virtù della quale l’uomo, essendo sensibile, tende ad identificarsi con l’altro in quanto essere sensibile, e dunque capace di soffrire.
Si è ironizzato a lungo sull’ottimismo della concezione rousseauniana della natura umana, senza riflettere sul fatto che Rousseau, postulando la sensibilità come capacità anteriore alla ragione, implica che essa possa essere arricchita non meno che mortificata e pervertita dalla ragione stessa.
Presumibilmente senza alcun riferimento a Rousseau, McLean (2), uno dei maggiori neurobiologi contemporanei, giunge alle stesse conclusioni. Benché la teoria dei tre cervelli possa essere criticata poiché essa misconosce che l’evoluzione non giustappone strutture ma le riorganizza a partire dai livelli funzionali più elevati è fuor di dubbio che l’ipotesi di McLean della necessità, strutturalmente da lui documentata, di un ancoraggio del cervello cognitivo al cervello emozionale ai fini di una definizione dell’identità personale che non prescinde dal riconoscimento empatico dell’altro, è una conferma dell’intuizione rousseauiana. E’ su questa potenzialità di integrazione tra l’identificazione con l’altro e il calcolo utilitaristico che può essere dialetticamente attivata dalla cultura o scissa e inibita che si declina, forse, la storia dell’umanità. Una drammatica verifica di questo assunto appartiene alla storia recente.
Il Super-Io nazista è un esemplare, e tragico, modello di “calcolatore” affrancato, culturalmente, dalla sensibilità: esso, dunque, può indurre l’uomo a trattare l’altro come un oggetto.
Il bisogno di integrazione sociale, laddove mantiene il suo legame con il sentire, e cioè quando non è pervertito razionalisticamente, rappresenta un vincolo di straordinaria importanza, poiché esso esclude che l’uomo tratti l’altro come un oggetto. Esso, dunque, appare orientato verso una socialità che, per quanto possa essere animata da conflitti, esclude la distruttività. Un’utopia, dunque, alla quale però la natura umana sembra predisposta. Nonché una pulsione, la distruttività, da questo punto di vista, si configura come l’espressione di un’anestesia della sensibilità, e cioè come una scissione del bisogno di integrazione sociale rispetto al sentire.
Il limite della concezione rousseauiana della natura umana non consiste dunque nell’ammettere una sensibilità della quale, talora, nei rapporti tra uomini e gruppi sembra mancare ogni indizio. Rousseau, nel parlare della natura umana, ha ignorato, semmai, il suo stesso dramma, forse perché non ancora giunto alla pienezza della testimonianza: il dramma di un uomo che, dopo aver contestato l’ordine sociale e la civiltà cui appartiene in quanto fondata sulla diseguaglianza e contraria alla natura umana, crolla, infine, sotto il peso del delirio persecutorio nel corso del quale il Super-Io, proiettato all’esterno, lo tormenta con le accuse più infamanti e rende la sua anima, tra le più sensibili, ostile ad un mondo ostile.
Alla sensibilità, che, in funzione del bisogno di integrazione sociale, promuove l’identificazione con l’altro, Rousseau, se fosse stato conscio della sua vicenda, avrebbe dovuto aggiungere il bisogno di opposizione, principio esso stesso anteriore alla ragione, e dunque legato al sentire, che si esprime nel rifiuto dell’assimilazione della propria volontà a quella altrui. Bisogno che promuove la differenziazione dell’identità personale, nonostante la disuguaglianza naturale tra infante e mondo adulto, e che gravita verso l’acquisizione di una pari dignità. Bisogno di identità non meno che di giustizia, genericamente parlando: dal che si può capire come mai quando venga per qualsivoglia motivo ostacolato, esso si converte in una ribellione “viscerale” contro la disuguaglianza arbitraria e la sopraffazione.
Bisogno prepotente, infine, poiché la sua intensità, originariamente minore rispetto a quella del bisogno di integrazione sociale, cresce nel tempo, fino a sormontare questa, sì che come vedremo nel caso in cui si istauri un conflitto tra i bisogni, è quello di opposizione a prevalere.
L’antropologia filosofica più recettiva dei bisogni fondamentali è, indubbiamente, quella di Marx. In essa, però, mentre la socialità dell’uomo è riconosciuta come un aspetto proprio della sua natura, l’opposizione viene ricavata dal processo storico le cui contraddizioni, giunte ad un certo grado di intensità, si riflettono nella coscienza umana, risvegliandola dalla sottomissione passiva in cui essa è mantenuta dall’oppio del mito gerarchico. Attribuire alla storia la produzione della coscienza critica oppositiva è un residuo idealistico nel pensiero di Marx. E A. Heller, nonostante il merito di aver riproposto la tematica dei bisogni umani come asse strutturale di quel pensiero, amplifica la contraddizione, ricavando i bisogni radicali dalla storia, come se fossero da essa prodotti.
Sotto questo profilo, la teorica marxista paga un tributo pesante ad una concezione ingenua della natura umana. Una citazione della Heller può bastare a conferma di ciò:
«L’uomo non viene al mondo con istinti immutabili, dal momento che non ha istinti innati. D’altra parte, non è una “tabula rasa”, non è condizionabile in tutto e per tutto. Né egli è l’incarnazione dell’essenza umana (innata), della sostanza umana. L’uomo ha una “seconda natura”. La quale ha origine storica, e si incarna nell’interazione tra le oggettivazioni e i singoli che vivono nel mondo attuale. A questa “natura” appartengono anche le possibilità concrete immanenti al presente, possibilità rivolte in egual misura ad alternative positive e negative.» (3)
Date le condizioni che presiedono alla produzione degli uomini in quanto enti culturali condizioni prolungate di totale dipendenza e impotenza rispetto agli adulti, che veicolano, nella stragrande maggioranza, il mito gerarchico - se la natura umana, nonché alla socialità, non fosse predisposta all’opposizione, e cioè ad interagire attivamente a tutte le situazioni, “naturali” (come il rapporto dell’infante con gli adulti) e storiche (come il rapporto dei subjecti con il potere) strutturate dalla categoria del Padrone e del Servo, nessuna oggettivazione storica sarebbe in grado di promuovere una ribellione viscerale prima e una presa di coscienza critica poi. Divinizzando se stesso, come è accaduto nel corso dei secoli, e, nonostante le apparenze formali, continua ad accadere, il potere avrebbe sempre buon gioco nel soffocare ogni presa di coscienza critica, vincolandola al registro del sentire e facendola vivere soggettivamente come una ribellione “demoniaca” mirante ad introdurre, in un mondo di armonia, la peste del conflitto, del disordine e della distruttività.
La storia non produce il bisogno di opposizione, che fa parte del corredo della natura umana: essa, piuttosto, produce le condizioni atte a far sì che quel bisogno, vincolato naturalmente al registro del sentire, al rifiuto viscerale della disuguaglianza e della sopraffazione, possa organizzarsi culturalmente sotto forma di presa di coscienza critica.
E non v’è dubbio che il bisogno di opposizione, in quanto dialetticamente antitetico rispetto al conformismo, sia la matrice non solo di conflitti interpersonali, micro e macrosociali, laddove una struttura e una cultura gerarchica impongono il rispetto di un ordine visceralmente percepito come ingiusto, bensì anche di conflitti creativi. La storia della cultura umana sia sotto il profilo filosofico che letterario, artistico e scientifico è densa di prove che attestano la tendenza “delle forme” a normalizzarsi e di un bisogno oppositivo che, affiorando con una certa regolarità, sia pure in singoli individui, le rivoluziona. E’ chiaro che la teoria dei bisogni, formulata nei termini che abbiamo proposto, come permette di superare il determinismo biologico e quello culturale, così consente di porre un parallelismo tra esperienza soggettiva e storia sociale. È la dialettica dei bisogni, infatti, che decide della forma in cui si strutturano le esperienze soggettive; ma essa, essenzialmente per quanto riguarda la configurazione più o meno distorta dei bisogni stessi e la percezione soggettiva, dipende dalle strutture sociali che, nella loro diversità, rappresentano i modi culturali economici, sociali, mentali secondo i quali quei bisogni vengono percepiti e le risposte che ad essi sono offerte.
Il fondamento biologico dei bisogni umani rappresenta, comunque, un vincolo ineliminabile per la cultura e definisce due limiti il cui misconoscimento sia per quanto riguarda gli equilibri individuali che quelli sociali produce serie conseguenze: l’uno concerne il sacrificio dell’individuazione in nome dell’appartenenza sociale; l’altro l’affermazione dell’individualità al prezzo della rinuncia ad ogni significativo legame sociale.
Nel primo caso, la socialità si pone come una maschera di normalità comportamentale atta a celare un bisogno di opposizione regredito, in conseguenza della frustrazione, ad un livello fenomenologicamente pulsionale; nel secondo, l’identità personale, costretta ad organizzarsi individualisticamente, è mantenuta rafforzata dall’anestesia della sensibilità, e cioè dalla rinuncia all’identificazione con l’altro, vissuta fobicamente.
Vedremo ulteriormente che queste due forme di esperienza soggettiva sono le matrici del disagio psichico. Ma è importante sottolineare che, in sé e per sé, esse non sono forme psicopatologiche, bensì forme di normalità rese costrittive dalla distorsione dei bisogni umani, che giungono ad opporsi irriducibilmente, tal che sopravvivere, psicologicamente e socialmente, postula la rimozione dell’uno o dell’altro, e dunque una mortificazione del potenziale evolutivo della natura umana.
La dialettica dei bisogni, iscritta nel corredo della natura umana, può, in virtù dell’interazione con l’ambiente, esitare in un conflitto adialettico, le cui espressioni elementari sono il conformismo sterile e un atteggiamento “asociale”.
Il nesso tra storia sociale e esperienza soggettiva è dato dall’istanza superegoica, il cui potere, all’interno della struttura della personalità, è devoluto totalmente a favore del mito gerarchico. Come si è detto, l’essenziale di questo mito consiste nel mantenere e nel razionalizzare la disuguaglianza tra gli esseri umani, sia entro una cornice di riferimento religiosa che laica.
La diversa cornice comporta però modifiche profonde nel modo in cui il mito si propone: nell’ambito della cornice religiosa, assunta il più spesso simbolicamente dalle ideologie totalitarie, esso fa riferimento ad un’autorità potente e temibile, atta a reprimere ogni dissidenza; nell’ambito della cornice laica liberale, il mito gerarchico funziona in virtù del miraggio di una potenza politica, economica e sociale cui tutti possono pervenire, tal che il successo o l’insuccesso individuale misurano rispettivamente il merito o il demerito. Nel passaggio dall’una all’altra cornice, il Super-Io deve modificare il suo modo di porsi soggettivamente. La cornice religiosa postula un Super-Io rigido, minaccioso e punitivo, atto a reprimere l’opposizione dando ad essa un significato demoniaco.
La cornice liberale postula altresì un Super-Io che funzioni soprattutto come ideale sociale dell’Io il più elevato possibile: ideale praticamente irraggiungibile, per perseguire il quale gli uomini devono accettare le regole di un gioco fondato su una competitività senza tregua, e, di conseguenza, devono mortificare il bisogno di integrazione in nome dell’ascesa sociale.
La distinzione tra le due versioni, l’una religiosa, l’altra politica, del mito gerarchico non va assolutizzata. Tra l’una e l’altra non mancano aspetti comuni: la condizione di santità, nella prima, assolve la stessa funzione di miraggio fascinosa che, nella seconda, è esercitata dall’appartenenza alla categoria dei V.I.P. ; e, d’altro canto, nessuna società laica potrebbe rinunciare alle sue istituzioni repressive come per esempio l’esercito, nel cui interno l’autorità postula un’obbedienza cieca ed è temibile nelle rappresaglie se ad essa ci si oppone o ai suoi “inferni” mondani (prigioni, manicomi, ecc.).
Le due versioni del mito gerarchico, inoltre, per quanto radicalmente diverse nei sistemi di valori cui si ispirano, possono convivere nella stessa società, accaparrandosi quote diverse di individui e, talora, addirittura condensandosi nelle istanze superegoiche soggettive.
Non si può non riconoscere che, nell’ambito della nostra civiltà, la teoria marxista, con la sua antropologia, la più ricettiva dei bisogni umani che si sia mai prodotta sul terreno filosofico, rappresenti una minaccia radicale per il mito gerarchico, del quale promuove un superamento. Purtroppo, i socialismi reali, nonostante la modificazione delle condizioni oggettive, non sono apparsi in grado di operare quel superamento. Le ragioni di questo paradosso sono molteplici e complesse, ed esorbitano dal progetto del nostro saggio. C’è solo da ribadire che l’ideologia laica liberale non può prescindere dal mito gerarchico, mentre quella marxista non può realizzarsi nella pienezza che attaccando quel mito.
La teoria dei bisogni di integrazione sociale e di opposizione appare in grado di fornire una chiave interpretativa che saldi la frattura permanente tra scienza della soggettività e scienza della storia. La mediazione tra esperienza soggettiva e storia sociale sembra fornita dal Super-Io e dal suo potere parassitario che, elevandosi sulla distorsione dei bisogni fondamentali e alimentandosi in virtù di essa, ostacola una presa di coscienza critica e la definizione di una coscienza morale personale.
2. Teoria dei bisogni e neurobiologia.
Definendo i bisogni di integrazione sociale e di individuazione come organizzatori dello sviluppo della personalità, abbiamo inteso sottolineare che se la loro fenomenologia dipende dalle interazioni con l’ambiente sociostorico (che, inevitabilmente, veicola, essendone strutturato, una qualche ideologia riguardo alla natura umana), la loro matrice è biologica. Le ipotesi che noi abbiamo avanzato rappresentano nulla più che un abbozzo di una teoria della natura umana e dei processi di socializzazione, la cui ulteriore elaborazione potrà avvenire col progresso delle scienze neurobiologiche. E opportuno, però, chiedersi se siano compatibili con i dati attualmente noti e in quale misura risultino da essi corroborati. La filogenesi della specie umana attesta inequivocabilmente lo sviluppo di una duplice predisposizione: alla socialità e alla differenziazione individuale. Tali predisposizioni, già evidenti nei primati come rilevò Darwin, sorpreso dal fatto che si volessero negare all’uomo attributi acquisiti da specie inferiori si amplificano singolarmente nel corso dell’ominazione.
Non v’è alcun dubbio che ciò debba attribuirsi allo sviluppo della corteccia cerebrale, e, in particolare, ad una ricca e complessa integrazione di strutture cognitive dovute alla cultura, prodotto di quello sviluppo che determina un’interazione circolare tra organizzazione biologica, psicologica e sociale. La plasticità della struttura cerebrale è un dato acquisito, ma interpretato in maniera controversa.
Si va, infatti, dall’eccesso della sociobiologia “dura”, che mira a invalidare il significativo evolutivo della plasticità in nome di una programmazione genetica che la utilizzerebbe per agevolare la selezione naturale, incrementando lo scarto tra individui più adatti e meno adatti, all’eccesso opposto di uno storicismo radicale, rappresentato, tra gli altri, da A. Heller, che tende a minimizzare l’importanza della natura biologica, ritenendola ormai totalmente subordinata alla “seconda natura” dell’uomo, quella culturale. Come giustamente nota J. Monod, il corredo genetico umano comporta con certezza, a livello cerebrale, un confine tra rigidità ed elasticità, tra i vincoli che esso determina e le possibilità la cui realizzazione è affidata all’interazione con l’ambiente.
Identificare questo confine, oggi, è impossibile dal punto di vista neurobiologico. Ma non esistono altre vie atte a suggerirlo, anticipando i tempi di una effettiva integrazione tra scienze neurobiologiche e scienze umane e sociali?
E’ suggestivo pensare che la storia sia null’altro che una sperimentazione su vasta scala nello spazio e nel tempo orientata a sondare i vincoli e le possibilità della natura umana: sperimentazione che, per effetto del bisogno di integrazione e di condivisione sociale, tende a dar luogo a strutture economiche, sociali e culturali relativamente stabili, che il mito gerarchico tende a perpetuare naturalizzandole, ma che appare, nel contempo, animata da un misterioso drive, riconducibile al bisogno di opposizione che, periodicamente, a livello individuale e/o collettivo, induce degli attacchi all’ordine di cose esistente orientati verso un adeguamento delle strutture sociali alle potenzialità e ai bisogni umani. Il movimento, di certo non lineare, della storia si potrebbe identificare come una deriva che muove dall’allentamento dei vincoli istintuali e va verso un’organizzazione socioculturale capace di offrire ad ogni membro l’opportunità di realizzare le possibilità iscritte nel suo corredo genetico. Il tragitto accidentato di questo movimento, in parte dovuto al suo carattere casuale, che solo l’uomo, riconoscendolo, può programmare, è riconducibile al conflitto non dialettico tra tendenze alla stabilità strutturale sociale, che danno luogo ad un ordine gerarchico che il potere mira a sancire e a cui le masse tendono a sottomettersi, e tendenze al disordine che affiorano, in singoli individui o nel corpo sociale subordinato, come espressione di nuovi bisogni di adeguamento delle strutture economiche, sociali e culturali alle potenzialità della natura umana. Queste due tendenze sono, da sempre, attive nella storia e, più o meno esplicitamente, al centro di ogni riflessione ideologica sul rapporto tra totalità sociale e membri appartenenti ad essa o, meglio, tra organizzazione normativa socioculturale e diritti individuali. Da punti di vista opposti, esse sono state giudicate vicendevolmente negative: al Contratto sociale di Rousseau, che rivendica la libertà per tutti gli uomini dal diritto del più forte in nome di un patto che sancisca una volontà generale sovrana «per la quale ognuno unendosi a tutti, non ubbidisce tuttavia che a se stesso, e resti altrettanto libero di prima», fa eco, a due secoli di distanza, The social contract di R. Ardrey che propone agli uomini di dedicarsi alla formazione o al mantenimento di società gerarchiche per non rischiare l’estinzione della specie, ratificando il diritto naturale del più forte di dominare il più debole.
Noi pensiamo che la contrapposizione tra l’impostazione sociobiologica, che tende a minimizzare le possibilità plastiche della natura umana, e quella storicista, che tende ad esaltarle per ridurre il peso dei vincoli genetici, vada sormontata nel nome di una teoria dei bisogni che dimostri che essi, nel loro fondamento genetico, nel loro essere rappresentati strutturalmente e funzionalmente a livello cerebrale, e nella tensione dialettica loro propria, che si realizza attraverso le interazioni con l’ambiente, si definiscono, nel contempo, come vincoli e come possibilità.
Più specificamente, essi vincolano ogni uomo ad appartenere ad un gruppo sociale e a condividerne la cultura, ma, nel contempo, ne sollecitano l’individuazione, e cioè la definizione di un’identità soggettiva che, come coscienza morale critica, può entrare in conflitto con l’eredità culturale, e introdurre in essa delle variazioni.
I bisogni umani, promuovendo la socializzazione e l’individuazione, mirerebbero a portare a compimento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse strutturali e funzionali del cervello, possibile solo per via culturale, un progetto evolutivo avviato dalla riproduzione sessuale che, nel contempo, replica e combina il materiale generico, dando luogo a corredi individuali speciespecifici ma unici e, statisticamente, pressoché irripetibili
La teoria dei bisogni conterebbe, dunque, la chiave della tendenza alla sottomissione, che sarebbe espressione del bisogno di integrazione sociale nella misura in cui esso postula e impone di appartenere ad un gruppo sociale e di condividerne la cultura; e della tendenza alla opposizione, espressione di un bisogno complementare e dialettico, mirante a rendere possibile l’utilizzazione selettiva dell’eredità culturale in nome dell’autorealizzazione individuale.
Il rapporto tra rigidità ed elasticità della natura umana va, dunque concepito in termini dialettici, come rapporto che promuove l’organizzazione sociale, permette la trasmissione dell’eredità culturale e assegna a ogni esperienza umana il compito di assimilare selettivamente quella tradizione: il che implica la possibilità di rifiutarla per alcuni aspetti, e sopprimerla dialetticamente.
Affrancata da vincoli istintuali, la struttura cerebrale umana riconosce nel corredo dei bisogni, che non è improprio, forse, definire, attrattori, un’eredità filogenetica la cui rigidità è attestata precipuamente dalla lunga dipendenza dell’infante dall’ambiente adulto, e la cui plasticità è comprovata dal relativo grado di libertà rispetto all’ambiente socioculturale cui può pervenire l’individuo. L’identità umana, culturale e soggettiva, si costruisce ontogeneticamente attraverso fasi di sviluppo la cui dialetticità, assicurata dalla tensione tra i bisogni, è restituita immediatamente dalle polarità che inaugurano e concludono l’evoluzione della personalità: l’attaccamento originario e la crisi di differenziazione adolescenziale.
Tali fasi corrispondono ad una programmazione genetica e visceralmente connotata, e cioè sono dovute a investimenti emozionali estroflessivi e introflessivi che solo lentamente, in rapporto all’integrazione e alla maturazione dell’Io, si arricchiscono di elementi cognitivi e culturali atti a strutturare un mondo interno, un mondo esterno e specifiche modalità di relazione tra l’uno e l’altro.
Il bisogno di integrazione sociale appare, originariamente, sotto forma di aggrappamento/attaccamento fusionale, cieco e impersonale. Non appena maturano elementari capacità discriminative, atte a dar luogo alla distinzione dell’Io dall’altro, quel bisogno si traduce in un legame di identificazione con le persone con cui l’infante intrattiene un rapporto privilegiato. Tale legame, attraverso meccanismi imitativi, permette l’assimilazione del linguaggio, di schemi e valori comportamentali la cui realizzazione, soddisfacendo le aspettative degli adulti, procura all’infante gratificazioni necessari all’integrazione dell’Io. Da un punto di vista neurobiologico, l’identificazione corrisponde, probabilmente, a complessi circuiti riverberanti che coinvolgono strutture sottocorticali e corticali.
Il bisogno originario di contatto/attaccamento/fusione/aggrappamento è, con certezza, filogeneticamente determinato. Le intuizioni precorritrici di Hermann a riguardo hanno trovato conferma attraverso gli esperimenti di Harlow e gli studi di Bolbwy.
L’attivarsi di questo bisogno corrisponde ad una programmazione del cervello viscerale. La soddisfazione del bisogno consente la maturazione delle strutture corticali che presiedono alla discriminazione dell’Io e dell’altro. Ma questa discriminazione non comporta, in sé e per sé, l’opposizione, poiché, nella misura in cui si dà, è negata dall’identificazione, in virtù della quale l’Io tenta di mantenere una relazione privilegiata di armonia con l’altro. L’identificazione è il meccanismo attraverso cui si esercita l’educazione, che, per mezzo di messaggi verbali e non verbali, attiva e modella il sistema di ricompensa e di punizione cerebrale, i cui centri, come è noto dalle esperienze di Olds e Miller, sono rappresentati a livello sottocorticale. Il bisogno di contatto interpersonale determina, dunque, una permeabilità dell’infante alle influenze ambientali, che danno luogo all’acquisizione di schemi di comportamento e di valori secondo criteri che muovono dall’altro e non dall’Io: schemi, in una certa misura, obbligati poiché dalla loro realizzazione discende la ricompensa o la punizione. E’ chiaro, dunque, che la dipendenza plastica dell’infante dall’ambiente, come promuove l’integrazione dell’Io a livello emozionale e corticale, così comporta il pericolo di un’assimilazione dell’Io all’altro, e cioè il definirsi di un’identità culturale stereotipica.
E’ questo il pericolo che si è realizzato presso le società che LeviStrauss definisce “fredde”, le quali, in nome di un’eredità culturale immobile nel tempo, sono riuscite a mantenere il primato della comunità sull’individuo, e che si è riprodotto, nel corso della storia, sia pure in misura minore, nelle società altamente gerarchizzate. E’ questo, ancora, il pericolo che, inesorabilmente, si realizza nel corso dell’evoluzione di ogni singolo individuo umano: la prima identità acquisita, quale che sia l’ambiente, è e non può essere che un’identità superegoica, l’espressione, cioè, interiorizzata, di un’eredità culturale.
Se la plasticità cerebrale si esaurisse nel bisogno di integrazione sociale, la differenziazione individuale in senso proprio, espressa dalla coscienza morale critica, e, in senso lato, l’evoluzione storica risulterebbero praticamente incomprensibili. Le società umane dovrebbero essere tutte fredde, e, al loro interno, gli individui tutti conformi ad un’eredità culturale autoperpetuantesi, con variazioni minime dovute all’unicità del corredo genetico individuale espressa da ruoli diversi. Occorre, dunque, ammettere, per inferenza logica, che la plasticità cerebrale sia in qualche misura limitata nella sua potenziale pericolosità e, nel contempo, arricchita da un fattore intrinseco al corredo genetico. Per definire questo fattore noi abbiamo introdotto il concetto del “bisogno di opposizione” come bisogno complementare in tensione dialettica con quello di integrazione sociale.
Il bisogno di opposizione è deputato a promuovere la definizione dell’identità individuale soggettiva in virtù della capacità di interagire selettivamente con le influenze ambientali. Bisogno drammatico, sia perché il suo affiorare è periodico e turbolento introducendo elementi di squilibrio soggettivo e relazionale in situazioni di equilibrio sia perché, finché non si definisce (e posto che si definisca) una struttura cognitiva e culturale adeguata a dare ad esso un senso dialettico, il suo erompere si configura come irrazionale e arbitrario.
Il modo fasico e critico con cui il bisogno di opposizione si manifesta nel corso dell’evoluzione della personalità, dal periodo in cui si definisce l’lo fino alla crisi adolescenziale, lascia pensare ad una programmazione genetica iscritta nelle strutture paleoencefaliche. La sua fenomenologia nel corso dell’infanzia, quando la componente emozionale dell’opposizione prevale di gran lunga su quella cognitiva, che si rende invece evidente a livello adolescenziale, lascia pensare ad un’attivazione, talora tempestosa, di sistemi catacolaminergici. Le fasi di opposizione sono, di fatto, fasi di conflitto più o meno intenso con l’ambiente. Esse non inattivano il sistema di punizione che, in rapporto alle influenze ambientali, può produrre sensi di colpa intensi, ma sembrano avere un’energia motivazionale Super-Iore. Si può ragionevolmente pensare che il bisogno di opposizione soddisfi in qualche modo il sistema cerebrale di ricompensa; ma, se le cose stanno così, occorre ipotizzare una ricompensa intrinseca dovuta all’affermazione, sia pure arbitraria, della volontà personale: una sorta di gratificazione anticipata riferita alla differenziazione rispetto all’ambiente e alla definizione di un’identità autonoma.
Il cervello viscerale veicolerebbe dunque una duplice programmazione: l’una, che promuove l’integrazione sociale attraverso l’identificazione, rivolta ad aprire l’infante al mondo esterno e ad indurlo a stabilire legami partecipativi, attraverso i quali scorrerebbero schemi e valori comportamentali, l’eredità culturale del gruppo di appartenenza; l’altra, che promuove la differenziazione attraverso l’opposizione, mirante ad assicurare una tensione in rapporto all’ambiente tale da dar luogo ad un’interazione selettiva. Presupposto, questo, indispensabile alla definizione di una coscienza morale critica capace, se necessario, di entrare in conflitto con l’eredità culturale o l’ideologia del gruppo di appartenenza.
Questa complessa dialettica, destinata ad integrare strutture emozionali e strutture cognitive, pone dunque in rapporto i bisogni della natura umana con le risposte proprie di una determinata organizzazione sociostorica, mediate dai sottosistemi con cui l’individuo interagisce. Tale rapporto ha inevitabilmente degli aspetti critici.
Le fasi oppositive, infatti, rispondendo ad una programmazione biologica, si manifestano come prese di posizione irrazionali. Il loro carattere funzionale ai fini dell’individuazione sfugge del tutto al bambino, data la sua modesta attrezzatura cognitiva e culturale. Ciò significa che, almeno fino alla preadolescenza, l’opposizione non può essere significata dall’interno: il suo significato, dunque, dipende dal modo con cui l’ambiente la recepisce e interagisce con essa. Per quanto questo modo vada riferito ai microsistemi sociali con cui il bambino interagisce e alle dinamiche che essi veicolano, è fuor di dubbio che esso deve essere ricondotto sempre a matrici culturali e quadri di mentalità propri del sistema totale entro cui avvengono processi di socializzazione. La dialettica tra bisogno di integrazione sociale e di opposizione da un lato, e ambiente dall’altro, dà luogo, in rapporto alle singole esperienze, ad una specifica economia dei sistemi cerebrali di gratificazione e di punizione. E’ ovvio che l’attivazione di questo ultimo sistema, dovuto ad una significazione negativa dell’opposizione, rappresenta la matrice originaria emozionale del Super-Io. Tale economia riconosce, in ogni caso, le sue radici in una forma a priori filogeneticainente determinata e visceralmente connotata, che associa all’integrazione con il gruppo di appartenenza e con il suo sistema di valori benessere e, viceversa, al conflitto il senso di colpa soggettivo.
Questa forma a priori, come si è accennato, rappresenta la matrice emozionale strutturale del Super-Io, i cui contenuti però, e cioè i sistemi di valore che significano la relazione armoniosa o conflittuale dell’individuo con il gruppo d’appartenenza, sono esperienziali, e possono dunque produrre effetti soggettivi di benessere e/o di malessere in rapporto a codici sociali più o meno alienanti. La dialettica dei bisogni, con la fasicità che caratterizza tutto il periodo evolutivo, a partire dal momento in cui l’interazione comunicativa con l’ambiente viene ad essere mediata dai processi di simbolizzazione, si integra con i fattori cognitivi e culturali, e ciò comporta la possibilità che le strutture informazionali acquisite a livello di corteccia associativa riverberino sulle strutture emozionali, dando luogo a nuovi assetti economici riguardanti il sistema di gratificazione e quello di punizione. Ma, per quanto l’apertura cognitiva e culturale al mondo, il cui orizzonte si estende via via che avviene l’evoluzione della personalità, non possa essere sottovalutata in nome di un determinismo primario dell’esperienza soggettiva, è opportuno tener conto che i fattori cognitivi e culturali non giungono mai ad avere un significato indipendente dalle strutture emozionali. Sono infatti «le strutture nervose del sistema limbico che assicurano l’adattamento del comportamento all’esperienza passata dell’organismo, che gli conferiscono i suoi tratti individuali e la sua dimensione “storica”» (4).
L’interazione tra forma a priori superegoica, maturazione emozionale e acquisizioni cognitive, culturali e ideologiche si apre, in virtù del rapporto con un ambiente sociostoricamente determinato, ad un ventaglio di possibilità le più varie che, al loro estremo negativo, comportano una più o meno radicale scissione tra ideale superegoico e “vocazione” esistenziale, e cioè tra come il soggetto deve o dovrebbe essere e come sente che sarebbe dovuto essere o divenire. E’ questo scarto, più o meno consapevole, che definisce una doppia identità, ciascuna con i suoi correlati emozionali, cognitivi ed ideologici, ciascuna con un’economia specifica le cui radici affondano nei sistemi cerebrali di gratificazione e di punizione.
Il grado di consapevolezza che il soggetto giunge ad avere di questa doppia identità varia da esperienza a esperienza, e va dall’estremo di una coscienza superegoica che rimuove il sistema di significazione egoico, all’estremo opposto di una coscienza egoica che rimuove il sistema di significazione superegoico, riconoscendo tutte le possibilità intermedie. La coscienza, in pratica, può identificarsi con uno dei sistemi di significazione prodottisi nel corso dell’evoluzione della personalità, oppure oscillare dall’uno all’altro o tra l’uno e l’altro. In ogni caso, essa è costretta a porsi e ad agire nel mondo per soddisfare le esigenze di stabilità strutturale che permettono all’identità soggettiva di mantenersi.
Alla fine del periodo evolutivo, il sistema psichico tende a chiudersi operativamente: da questo momento in poi, sia pure in senso relativo, gli equilibri intrinseci del sistema, dovuti all’economia dei bisogni così come essa si è configurata nel corso della evoluzione della personalità, cominciano a prevalere sulle influenze ambientali. Lo sappia o meno, lo voglia o meno, il soggetto non può interagire con l’ambiente che secondo la logica di una determinazione intrinseca. Il paradosso, che investe tutto l’universo psicopatologico, è che più gli equilibri intrinseci sono precari, essendo devoluti a soddisfare esigenze superegoiche, più il soggetto deve darsi da fare per mantenerli. In tali casi la dialettica dei bisogni, potenzialmente intrinseca alla natura umana, può riavviarsi solo a partire da una presa di coscienza del significato di quegli equilibri, e del sacrificio inutile di una quota di bisogni che essi comportano sull’altare di un’identità culturale superegoica.
3. Teoria dei bisogni e psicologia evolutiva
Postulando un corredo binario di forme affettive innate, programmate psicobiologicamente e dunque dotate di una fasicità intrinseca che motiva le interazioni con l’ambiente nel corso delle fasi evolutive e, attraverso l’integrazione dei dati esperienziali, dà luogo allo strutturarsi di un sistema di significati specifici, inerenti l’immagine di sé, dell’altro e delle possibili relazioni tra sé e altro, la teoria dei bisogni rappresenta la scoperta della dialettica, intesa come legge dinamica ed oggettivabile del divenire, laddove, almeno a nostra conoscenza, nessuno si è curato di cercarla: nel corredo della natura umana e, di conseguenza, nel cuore stesso della struttura soggettiva. La storia che, assunta marxianamente come naturalizzazione e umanizzazione della natura e cioè come rivelazione delle potenzialità umane attraverso la trasformazione della natura e arricchimento della stessa attraverso la rivelazione delle potenzialità di questa , è un prodotto di quella dialettica, ma è anche una testimonianza altamente infedele, poiché, non essendo programmata e difficilmente programmabile, essa comporta lunghe fasi inerziali e brusche accelerazioni, il cui gioco dinamico, già turbolento in sé e per sé, lo diventa ancor più in rapporto ai tempi diversi evolutivi che caratterizzano le componenti e i livelli della struttura sociale: l’economico, il sociale, il mentale.
Se è vero che il corredo della natura umana comporta una potenzialità e dunque una legge dialettica che si esprime nello sviluppo e nell’organizzazione della personalità; se è vero che tale legge, pur corrispondendo ad una programmazione genetica, dipende, nella sua realizzazione, dalle opportunità offerte dall’ambiente sociale e dall’integrazione con esso; se è vero, infine, che esse, pur rimanendo dinamicamente vincolate ad assetti psicobiologici che perdurano nel corso dell’esistenza, da un certo punto in poi dell’evoluzione della personalità, è mediata dai sistemi di significati acquisiti ed elaborati dall’individuo, risulta ovvio chiedersi, dopo averne illustrato le compatibilità con i dati forniti dalla neurobiologia, se la teoria dei bisogni sia compatibile anche con i dati accertati nell’ambito della psicologia evolutiva, soprattutto per quanto riguarda le scoperte, in una certa misura rivoluzionarie, maturate nell’ambito della infant research. Non esitiamo a rispondere positivamente: sia la predisposizione sociale ormai universalmente riconosciuta al bambino a partire da Bowlby e Winnicott, sino a M. Mahler, C. Travarthen, D. N. Stern e R. N. Emde, attestata da una precocissima ricerca di relazione oggettuale e di sintonizzazione con i caretakers; sia l’attribuzione al bambino, promossa soprattutto dagli studi di M. Maher, di una “pulsione” alla separazione e all’individuazione, attribuzione più o meno esplicitamente confermata da tutti gli studiosi, e anticipata intuitivamente da D. W. Winnicott, rappresentano inconfutabili prove a favore della teoria dei bisogni.
Un problema ancora aperto, e destinato indubbiamente a ricevere risposte da ulteriori studi e teorizzazioni, è individuabile nelle fasi e nelle modalità di integrazione delle forme emozionali e delle strutture cognitive. Per questo aspetto, i tentativi di Stern appaiono di grande interesse. Né si può negare che le ricerche di Emde sulle emozioni morali precoci e sulle interiorizzazioni delle norme culturali, che sembrano conseguire una qualche autonomia sin dall’età di 3 anni, nonché l’attribuzione al bambino di una capacità precoce di condividere i significati sociali, che apre la straordinaria prospettiva di una psicologia del noi, rappresentano intuizioni e prove a favore del riconoscimento del bisogno di appartenenza come forma affettiva sistemica innata e matrice della funzione superegoica.
Ciò detto, occorre riconoscere che la teoria dei bisogni, nonché compatibile con i dati della psicologia evolutiva sperimentale, sia ad indirizzo psicoanalitico, che cognitivo, si pone rispetto ad essi, e soprattutto alle teorizzazioni cui hanno dato luogo, in funzione critica e propositiva.
Due aspetti vanno considerati sotto questo profilo: se è vero che i dati, forniti da una sperimentazione che oggettiva i comportamenti infantili precoci e inferisce da ciò i processi costruttivi della personalità, consentono di integrare scientificamente e, per molteplici aspetti, di correggere le ricostruzioni ricavate dalla pratica psicoanalitica; se è vero, in altri termini, che il “bambino osservato” appare radicalmente diverso dal “bambino clinico”, soprattutto per quanto concerne le ricostruzioni che, da Freud a M. Klein, vertono sulla pulsione aggressiva, non si può negare che quei dati comportano il rischio di un’ideologizzazione incentrata sull’armonia affettiva e più o meno radicalmente ristretta all’interazione duale madrebambino. Come non vi può esser dubbio, ormai, che la sintonizzazione affettiva tra bambino e ambiente familiare rappresenti un fattore decisivo del processo evolutivo precoce che esita nella nascita del Sé e nel riconoscimento della differenza “irrimediabile” tra Sé e altro, attribuire a questa nascita e a questo riconoscimento un significato etiopatognetico fondamentale nella genesi delle esperienze psicopatologiche, costringe la teoria psicopatologica in un ambito angusto e riduzionistico. Il modello “malformativo”, valido per le psicosi infantili e quello interattivo, valido per le nevrosi infantili vengono proposti come modelli che, mutatis mutandis, non possono non valere anche per la psicopatologia adolescenziale e adulta. Ciò comporta un’illecita omologazione della psicopatologia malformativa, interattiva e strutturale, e il misconoscimento che quest’ultima, la cui genesi è indubbiamente interattiva, è caratterizzata da una conflittualità intrapsichica che fa capo ad una scissione del corredo dei bisogni prodotta, alimentata e resa irriducibile da sistemi di significazione elaborati cognitivamente a partire da matrici culturali sempre oggettivabili. Il riduzionismo pedomorfo, ideologicamente implicito nella teoria psicopatologica elaborata a partire dall’ infant research, comporta il misconoscimento del fatto che, in ambito adolescenziale e adulto, il problema terapeutico si pone meno nei termini di aiuto emozionale rivolto a liberare il soggetto dalle fissazioni e dalle regressioni infantili, che definiscono comunque la sua immaturità, che nei termini di un intervento atto a dotarlo di strumenti critici capaci di indurre l’affrancamento dalla funzione superegoica e l’autorizzazione emozionale a vivere in regime di autonomia e di libertà morale rispetto al gruppo di appartenenza e ai valori che esso rappresenta.
Il secondo aspetto, intimamente correllato al primo, concerne l’isolamento del processo evolutivo della personalità e del contesto familiare e/o istituzionale (asilinido, istituti d’infanzia) entro cui esso si realizza rispetto alla storia e al sistema sociale. La valorizzazione ideologica delle interazioni affettive, provocatoriamente ristretta alla diade madrebambino, nella pressoché assoluta ignoranza del significato storico che essa assume nel contesto della nuclearizzazione dell’istituzione familiare (sperimentazione prodotta dalla logica sociale, ma con rischi che, già oggi, appaiono Super-Iori ai vantaggi), comporta il misconoscimento sia delle componenti biografiche e storicosociali che incidono nel determinare il comportamento materno, e nel dare ad esso un significato più spesso proiettivo che “naturale”, sia del fatto che l’allevamento del bambino, pur affidato giuridicamente dalla società alla famiglia, rientra inesorabilmente nell’ambito di un modo di produzione la produzione antropologica che, per quanto non programmato, è comunque determinato dalla logica dei processi sociali, e, attraverso la deriva dei gruppi di appartenenza, si rifrange inesorabilmente nelle strategie e negli obiettivi che le famiglie perseguono investendo le loro risorse economiche, emozionali e culturali nell’allevamento dei figli.
Da questo punto di vista, le interazioni affettive, pur fondamentali nel promuovere la nascita del Sé psicologico, risultano necessariamente funzionali, e, da una certa epoca dello sviluppo, subordinate alla costruzione di una personalità idonea e/o adattata al sistema sociale nel quale la famiglia si impegna, con il concorso attivo del soggetto, ad integrarla, vedendo in questo obiettivo l’esaurimento del suo compito istituzionale. Da questo punto di vista, i legami affettivi, che già di per sé indebitano, vanno considerati anche come canali di indebitamento ideologico. Il conflitto tra debito affettivo (che non esclude, in molte circostanze, un credito del soggetto) e debito ideologico appare un aspetto strutturale e dinamico specifico e essenziale a livello della psicopatologia adolescenziale adulta. E’ un aspetto solo embrionalmente presente, e il più spesso sotto forma di interazioni viscerali del bambino con aspettative genitoriali eccessivamente coercitive c/o esattive riferite a valori culturali impliciti, nelle fasi precoci dello sviluppo sino a 23 anni.
Ciò significa che se i dati della psicologia evolutiva sperimentale possono essere facilmente integrati nella teoria dei bisogni, a cui favore adducono prove preziose, non è vero il contrario. La teoria dei bisogni, in quanto teoria dialettica della natura umana e dei rapporti tra natura e cultura, ha un’ottica di più ampio respiro rispetto alla infant research, e può forse contribuire, nonchè a dare ai risultati da questa raggiunti un significato meno riduttivo, a mettere a fuoco ipotesi di ricerca, atte ad integrare neurobiologia e psicologia evolutiva, di grande interesse.
Per fare un solo esempio, essa potrebbe promuovere delle ricerche sulle fasi oppositive, non limitate come nella Mahler ai primi tre anni ma estese sino alla risoluzione della crisi adolescenziale: ricerche miranti a dimostrare che esse corrispondono a fasi programmate di squilibrio psicobiologico il cui fine sarebbe di indurre, attraverso il conflitto, una più ricca integrazione emotiva, cognitiva e culturale del Sé atta ad indurre una presa di posizione del soggetto in rapporto alla realtà, precorritrice dapprima e infine destinata ad esitare nella nascita della coscienza morale critica: nascita necessariamente tardiva, che, quando si realizza, conclude la fase evolutiva della personalità. Nascita, a nostro avviso, non meno importante di quella del Sé, che ne rappresenta la premessa “embrionale”.
La teoria dei bisogni, risolvendo il problema della natura umana, che incombe come un noumeno in tutti gli studi che vertono sull’evoluzione della personalità, consente il definitivo superamento del modello pulsionale freudiano in nome di un modello relazionale che tenga conto però che i legami interpersonali, pur nella loro specificità intersoggettiva, rappresentano comunque, quale che sia la consapevolezza degli agenti in relazione, l’interfaccia della dialettica tra natura umana rappresentata in un corredo individuale e cultura veicolata e rifratta dal gruppo di appartenenza.
In ultima analisi, la strutturazione del Sé, assunta come esito più o meno alienato dell’intero periodo evolutivo, rappresenta pur sempre la definizione di una personalità che, in base ai sistemi di valore acquisiti ed elaborati cognitivamente, deve operare delle scelte morali nel mondo: decidere, in breve, se come e fino a che punto adattarsi alla tradizione e allo stato di cose esistente in nome del debito di fedeltà, e se, come e fino a qual punto disadattarsi in nome della vocazione personale, dell’autonomia e della coscienza morale critica.
Dato l’intento del saggio, non ci pare opportuno soffermarci sulle implicazioni della teoria dei bisogni al di là dell’ambito che immediatamente ci interessa: quello dei processi di socializzazione e delle interazioni tra soggetti e ambiente che esitano in esperienze di disagio psicopatologico. Tali implicanze sembrano però molto ampie e, in rapporto a problematiche tuttora aperte nell’ambito delle scienze umane e sociali, se non risolutive, di certo suggestive.
Poste queste premesse, il discorso può ora delimitarsi nell’ambito che appare più immediatamente illuminato da esse e verificabile: i fenomeni di disagio psichico.
La psichiatra transculturale ha dimostrato l’universalità, nel tempo e nello spazio, di tali fenomeni. Nonché attestare una loro presunta origine organica, questo rilievo, dal nostro punto di vista, conferma che nessuna civiltà, sinora, è riuscita ad affrancarsi dal mito gerarchico e ad organizzarsi in maniera da rispondere adeguatamente alle potenzialità intrinseche della natura umana. La relativa concordanza fenomenologica delle forme psicopatologiche depone a favore del fatto che l’alienazione dei bisogni, comunque essa si produca, dà luogo a strutture di esperienza soggettive intrinsecamente determinate. Una psichiatria dialettica non prescinde dalla fenomenologia psicopatologica, ma si interessa dialetticamente ai processi di socializzazione che la producono e alla struttura economica, sociale e mentale entro la quale quei processi si realizzano.
Essa non può non essere sistemica e contestuale, non può darsi che come una vasta, e incessante, inchiesta sulle interazioni tra la natura umana e una determinata organizzazione sociale.
Capitolo quinto
Eteronomia, antinomia, autonomia
La scoperta freudiana del Super-Io, analizzata nella cornice di riferimento della teoria dei bisogni, conduce dunque a conclusioni antitetiche a quelle cui è pervenuto Freud. Nonchè da un corredo naturale di pulsioni asociali e amorali, l’uomo, nella definizione di un’identità autonoma, necessariamente culturalizzata ma nel contempo dotata di un potere critico, è, per così dire, minacciato dalla sua stessa predisposizione sociale che, in virtù della forma a priori superegoica e di circostanze ambientali atte a “criminalizzare” il bisogno di opposizione, può produrre facilmente una condizione di assoggettamento dell’Io al Super-Io, e cioè una strutturazione della personalità integrata al prezzo dell’alienazione. E evidente che la forma a priori superegoica rappresenta la ricchezza e la miseria della natura umana: senza di essa, e della programmazione emozionale che la sottende, l’uomo non potrebbe pervenire all’acquisizione di un’identità culturale; ma essa comporta anche il pericolo, che si realizza in rapporto a determinate circostanze ambientali, che l’Io rimanga assoggettato ad un sistema di valori meramente introiettato e non assimilato, e cioè che rimanga in una condizione di alienazione psicologica e sociale tale che l’appartenenza al gruppo, con le sue tradizioni, le sue ideologie e la rete di obblighi sociali, giunge a mortificare ogni atteggiamento critico, impedendo il salto dialettico dell’assimilazione, che, promuovendo la nascita di una coscienza morale critica, associa alla necessità dell’adattamento all’ambiente il bisogno, iscritto nella natura umana, di adattare l’ambiente a sé.
In altri termini, la ricchezza potenziale della forma a priori superegoica si attualizza solo in virtù della sua soppressione dialettica, in conseguenza della quale l’Io, secondo la bella formula di Rousseau, partecipa ai valori collettivi ma obbedisce e risponde anzitutto a se stesso.
Non insisteremo, per ora, sui motivi storicosociali che, in nome del mito gerarchico, hanno interferito e interferiscono sulla realizzazione di questa possibilità intrinseca al corredo della natura umana, ovviamente temibile per ogni potere che rifiuta di essere convalidato dal consenso critico di coloro su cui si esercita, e quindi di rispondere di sé a coloro che lo hanno delegato. Ciò che importa, ora, è rilevare che, se il Super-Io è un’istanza che non può non essere presente in ogni personalità al culmine della fase evolutiva contrassegnandone, nel contempo, l’integrazione e l’alienazione; e se essa, in quanto retaggio delle originarie identificazioni affettive, non può essere in alcun caso, anche quando appare necessario, compiutamente soppressa dialetticamente, ogni personalità riconosce una struttura profonda che può essere definita a partire dal Super-Io, il cui sistema di significazione rappresenta un’identità originaria, una mente sociale che, in nome della forma a priori superegoica, impone di condividere la ragione degli altri. Tale sistema, quale che sia il grado di consapevolezza soggettivo in rapporto alla sua genesi, ai suoi contenuti e al suo potere emozionale costrittivo, determina il potere dell’Io, e cioè la sua capacità di differenziarsi e di evolvere dialetticamente integrando la ragione degli altri con il bisogno di opposizione/individuazione. Il rapporto dinamico tra Super-Io e Io può essere ricondotto a tre configurazioni di base: la prima, caratterizzata da una subordinazione pressoché passiva dell’Io al Super-Io, mascherata il più spesso da una fusione consensuale; la seconda da una ribellione viscerale, più o meno consapevole, che, attivando i sensi di colpa, paradossalmente, nonché scalzare, incrementa il potere superegoico; la terza, da un processo dialettico di assimilazione che dà luogo a una soppressione, sia pure relativa, del Super-Io e alla formazione di una coscienza morale autonoma e critica.
La prima configurazione corrisponde ad una personalità normale o, più propriamente, normalizzata, e cioè pienamente adattata a convivere con i valori tradizionali o dominanti; la seconda, ad una personalità psicopatologica, dinamicamente scissa tra una normalizzazione, il più spesso repressiva, imposta dai sensi di colpa, e una ribellione che, non trovando adeguati sbocchi culturali e pratici, si pone a livello fenomenologico in termini di disordine, distruttività, anarchia, immoralità; la terza, ad una personalità creativa in quanto dialettica, integrata nel mondo sociale ma differenziata, capace cioè di assumere atteggiamenti e decisioni critici e autonomi, fino al punto, se necessario, di entrare in conflitto con i valori tradizionali e le ideologie dominanti.
La distinzione di queste tre strutture di personalità va intesa solo come uno schema orientativo meramente teorico. Nel concreto dell’esperienza umana, nessuna di essa si realizza in forma compiuta. La teoria dei bisogni fondamentali impone di pensare che nessuna personalità possa essere normalizzata fino al punto di eliminare, nella sua struttura profonda, ogni opposizione; nessuna totalmente alienata in un conflitto irriducibile tra potere superegoico e anarchia pulsionale; nessuna, infine, giungere, attraverso un tragitto individuale, a dotarsi di un sistema di valori assolutamente autonomo.
Cionondimeno, per quanto teorico, lo schema ha una sua validità, poiché permette di definire l’orientamento prevalente di ogni struttura di personalità nella direzione della subordinazione o della opposizione al mito gerarchico.
La coscienza patologica, alla quale dedicheremo l’attenzione ora, rappresenta una condizione affatto singolare, poiché essa risulta letteralmente scissa tra un’identità superegoica, più o meno dittatoriale, minacciosa e repressiva, e un’identità egoica “viscerale” carica di contenuti oppositivi, ribelli, trasgressivi, anarchici.
E a livello psicopatologico che l’intuizione di Freud di una doppia personalità, una delle quali spadroneggia sull’altra che è asservita ma non doma, riceve clamorosa conferma e apre la via ad una nuova scienza del disagio psichico. Ma, per dare ad essa il suo pieno significato, che contrariamente agli intenti di Freud, implica il superamento di un punto di vista meramente psicologico, occorre dimostrare che il cosiddetto antropomorfismo superegoico, nonché un’infelice metafora, è una verità di fatto.
L’esperienza che riferiamo, da questo punto di vista, si può ritenere esemplare e probante. Perciò, nelle pagine seguenti ci riferiamo ad essa più volte analizzandola da prospettive diverse.
Un ampio “materiale” clinico verrà pubblicato successivamente. Per ora importa dar conto di una metodologia ermeneutica, strutturalistica e nel contempo dialettica, che appare in grado di restituire ai fenomeni psicopatologici il valore testimoniale che essi hanno nell’universo dei fatti umani.
A 17 anni, Paola, uscendo di chiesa dopo la messa domenicale, con il consueto atteggiamento compunto di “madonnina”, a testa china, passa accanto ad una macchina in sosta. Il suo sguardo incontra quello del ragazzo al volante e, rimossa ogni castigatezza, saetta un fuoco di seduzione. Conscia di aver perduto il controllo e di aver commesso una colpa, Paola si allontana rapidamente. Ma, ormai, ciò che è accaduto è irreversibile. Il ragazzo, infatti, in virtù di quello sguardo maliardo, ha perduto la testa per Paola. Nei giorni successivi, ovunque essa vada, la segue in macchina con la muta devozione di un cagnolino. A qualunque ora del giorno, se Paola guarda in strada dalla finestra di casa, lo vede in attesa. Esaltata da questa cattura nonostante il cuore già le rimorda, Paola sta al gioco, facendo finta però di essere indifferente, quest’atteggiamento avendo come scopo di rinforzare la passione del ragazzo. Dopo alcuni mesi di incessante “persecuzione”, vissuta positivamente, Paola intuisce repentinamente di non ricambiare i sentimenti del ragazzo. Seducendolo e rinfocolando la sua passione, lo ha dunque preso in giro. Sentendosi in colpa, decide di affrontarlo per dirgli la verità e risolvere la questione. Ma è a questo punto che Paola scopre, con sgomento, di non riuscire ad identificarlo. Quando il ragazzo è ad una certa distanza, ne identifica infallibilmente il “tipo” la sagoma un po’ massiccia, i capelli neri e ricci, e, soprattutto, lo sguardo da innamorato; quando gli si avvicina, l’identificazione diventa incerta e problematica. Paola teme di sbagliare, di salire sulla macchina di un altro ragazzo e di essere violentata, come merita una donna che abborda uno sconosciuto.
Scoperta l’imprevista difficoltà di identificazione, Paola comincia a lanciare dei messaggi al ragazzo per fargli capire che deve essere lui a prendere l’iniziativa. Ma questi, evidentemente, ferito nell’orgoglio dall’atteggiamento altezzoso avuto sino allora da Paola e, probabilmente, incredulo, continua a seguirla con la costanza consueta ma mantiene un atteggiamento passivo, aspettando che sia Paola a piegarsi. Il problema si configura, dunque come insolubile. A questo punto entrano in scena i parenti e gli amici del ragazzo, sdegnati per la lunga presa in giro. Dapprima con velate allusioni poi con messaggi inequivocabili, lasciano intendere a Paola che non credono alle sue difficoltà di identificazione, e le concedono una sola possibilità di farla franca: recedere dalla sua orgogliosa ostinazione e riparare la colpa con il matrimonio. Per sollecitarla alla resa, cominciano a sottoporla quotidianamente, persino quando è in casa, ad un fuoco di fila di giudizi sprezzanti e di accuse sempre più pesanti. Per porre fine alla persecuzione, che, ormai, le impedisce di vivere, Paola sarebbe disposta a tutto: non a gettarsi però tra le braccia di uno sconosciuto. Per dignità, ma, ancor più perché sa che sia il ragazzo che gli amici e i parenti hanno una mentalità estremamente tradizionale, sì che la eventuale perdita della verginità non le verrebbe mai perdonata. Sarebbe, comunque, costretta a sposare il ragazzo, e a subire il disprezzo perenne di tutti. La disperazione di Paola è totale. Può fornire la prova della sua onestà solo chiudendosi in casa ma la persecuzione continua, perché ci si attende da lei un gesto di resa. Tutta la città, ormai, è alleata del ragazzo. Passano gli anni in una situazione di stallo angosciosa. Paola decide, infine, nell’attesa che la sua buona fede sia riconosciuta, di dedicarsi allo studio, unico conforto di una vita claustrale. Tenta di portare a compimento gli studi magistrali, che ha interrotto, con l’intenzione di iscriversi, successivamente, all’università. Scopre, in questa fase, il sadismo della persecuzione.
I parenti e gli amici del ragazzo si scatenano, poiché, non avendo questi un titolo di studio, interpretano la decisione di Paola come l’espressione di un progetto ambizioso, mirante a sancire l’inferiorità di quello e a orientare lei verso altre scelte sentimentali. Dopo poco tempo, lo studio viene interferito e reso impossibile da un perpetuo frastuono di voci, che accusano Paola di volersi liberare del ragazzo. Per questa ingiustizia, che chiude l’ultima via di scampo dalla disperazione, Paola si disamora, giunge a nutrire rabbia e odio contro il ragazzo e tutti coloro che lo difendono. Si vota ad una resistenza passiva: rinuncia a studiare, ma si propone di non cedere mai ad un odioso ricatto.
Questa conclusione, alla quale Paola giunge dopo 10 anni, nel corso dei quali ha tentato in ogni modo, nonché di difendere la sua dignità, di giustificare le ragioni del ragazzo e dei suoi alleati, attribuendo al primo autentici sentimenti di amore e agli altri intenti riparatori di una colpa realmente commessa, questa conclusione, che, all’improvviso, rivela alla coscienza il carattere persecutorio e repressivo di un atteggiamento vissuto sino ad allora come protettivo, è, in realtà, la premessa del delirio. Cosa pretende la tradizione che, per Paola, parla in nome di tutto il mondo, mettendo in luce la logica della sua istanza superegoica? Che essa accetti di calarsi nel ruolo proprio della donna secondo la tradizione: ruolo che impone di giungere vergine al matrimonio; di essere per sempre di un solo uomo, il primo, lo si ami o no; di subordinarsi al suo potere, dedicandosi esclusivamente a lui, alla casa e ai figli; di non avere alcun interesse né sociale né culturale, poiché tutto ciò che non è dovere domestico può fuorviare la mente.
Alla luce di questa mentalità, che impone alla donna di essere umile schiava dell’uomo che ad essa tocca in sorte, ogni desiderio di libertà, di autonomia, di individuazione si configura, toutcourt, come espressione di anarchia, di disordine e, da ultimo, di immoralità.
Non appare opportuno, né necessario, ricostruire qui la biografia ulteriore di Paola. Basterà dire che la sua cultura ha origini contadine; che la nonna, allevata dalle suore in un collegio, pur avendo spiccate attitudini per lo studio, è stata costretta dal padre a sposarsi precocemente in virtù di un matrimonio combinato; che la madre, donna piuttosto affascinante, immigrata da sola a Roma in giovane età per sottrarsi al regime patriarcale, si è protetta dalle infinite insidie della città sposando il primo uomo buono e onesto che ha conosciuto, pure senza amarlo né provare attrazione per lui. E che costui, pur di carattere sostanzialmente mite, e inferiore ad essa culturalmente, l’ha sempre trattata autoritariamente, comandando ad essa come a una serva. Paola è stata educata in casa, dalle suore, in parrocchia nel rispetto assoluto della tradizione, ed esteriormente si è conformata ad essa, apparendo una ragazza docile, giudiziosa, irreprensibile moralmente. Ma ha, da sempre, avvertito dentro di sé, mascherandola a tutti, una strana inquietudine sotto forma di avversione “viscerale” nei confronti del padre autoritario, di incessanti dubbi religiosi, di rabbia nei confronti del ruolo servile cui la tradizione e la religione destinano le donne. Sarebbe illecito attribuire quella inquietudine alla pressione di pulsioni asociali e amorali, visto che Paola rifiuta di lanciarsi nelle braccia del primo che capita, pagando questa dignità con il sacrificio della vita, e, infine, oppone alla tradizione un progetto incentrato su di un bisogno: il bisogno di studiare, di conseguire una laurea, di svolgere un lavoro significativo e di rendersi autonoma economicamente.
Con ciò, la struttura di personalità profonda di Paola e la genesi del delirio risultano chiare. Alla tradizione che vuole la donna schiava e inferiore all’uomo, alla tradizione gerarchica veicolata dal Super-Io, si oppone un bisogno di individuazione orientato, in sé e per sé, al conseguimento di uno statuto sociale e culturale di pari dignità. Ma questo bisogno è ostacolato e distorto dal Super-Io, che vieta a Paola di dedicarsi allo studio, e le concede solo due possibilità: o l’isolamento assoluto, la rinuncia totale a vivere, o abbordare uno sconosciuto, esibendo infine la sua “vera” natura di cacciatrice di uomini.
Che cosa impedisce al bisogno di individuazione di Paola di tradursi in coscienza critica? Benché oppositiva al livello del sentire, Paola purtroppo è rimasta coscientemente vittima della tradizione e della religione: crede autenticamente nei valori morali veicolati dall’una e dall’altra, e non riesce a comprendere che quei valori, che possono essere autentici in sé e per sé, sono immorali nella misura in cui essi sono utilizzati per promuovere non la liberazione bensì la subordinazione cieca e passiva della donna al suo destino. La ribellione di Paola rimane pertanto sterile, poiché essa, a livello profondo, identifica liberazione e trasgressione. La prima volta che Paola tenta di affrancarsi dal ruolo di madonnina, di giovane compunta che non deve osare di rivolgere uno sguardo di interesse nei confronti di un uomo, la prima volta che si ribella alla maschera sociale superegoica della donna virtuosa, essa commette una colpa che decide del suo destino e che va riparata per riacquistare la perduta dignità. Ma questo è impossibile perché alla dignità della virtù, cui pure Paola tiene, ma che, nella logica tradizionale, impone alla donna di vivere nella subordinazione e nell’assoggettamento passivo all’uomo, si oppone, visceralmente, un sentimento radicale di parità e di giustizia.
L’esperienza di Paola è esemplare perché la struttura del delirio lascia trasparire, con un’evidenza assoluta, il conflitto tra un’istanza superegoica che, in nome della moralità, promuove l’assoggettamento gerarchico della donna all’uomo, e un bisogno di opposizione orientato verso la parità.
Purtroppo, per quanto intenso, questo bisogno rimane in Paola connotato visceralmente, e non giunge a tradursi in coscienza critica: insopprimibile, quali che siano la sofferenza e le rinunce che esso comporta, rimane nondimeno sterile, poiché non può esitare in un cambiamento reale. Ciò dà all’esperienza psicopatologica di Paola un carattere statico di un’esperienza scissa e sospesa tra una tradizione cui non ci si può sottrarre e una ribellione cui non si può rinunciare, ma che non può neppure realizzarsi.
Se Paola, come è accaduto alla nonna e alla madre, avesse potuto conformarsi ai valori superegoici introiettati, sarebbe vissuta in una dimensione normalizzata; se, viceversa, fosse giunta, oltre che a rifiutarli emozionalmente, a oggettivarli criticamente, affrancando il suo bisogno di moralità dalla logica intrinseca alla tradizione introiettata secondo la quale l’onestà della donna è comprovata dall’accettazione di un controllo sociale, reso indispensabile dalla sua natura tendenzialmente squilibrata, Paola sarebbe potuta pervenire alla definizione dialettica di un codice di moralità autonomo. Essendosi rese entrambe queste soluzioni impossibili, la sua esperienza si configura come psicopatologica, scissa cioè tra una normalizzazione persecutoria e una liberazione desiderata ma temuta.
In conseguenza di questa scissione, Paola vive soggettivamente in un universo di colpa e di punizione: la colpa ha radici nel suo rifiuto viscerale di accettare il “destino” della donna, la punizione nell’essere isolata, privata di ogni libertà, e perpetuamente ingiuriata. Il Super-Io appare, nella trama del delirio, in tutta la sua implacabile e sadica severità, giungendo a coalizzare tutto il mondo contro Paola. Si tratta è ovvio di un mondo soggettivo, nel quale, tuttavia, si riflette un dramma storico: il dramma di una condizione quella femminile sottoposta ancora a potenti pressioni culturali, che inducono, in una quota rilevante della popolazione, il servaggio, e impegnata, in una percentuale ancora minoritaria, in una dura lotta per la conquista di una pari dignità rispetto all’uomo. Il Super-Io in Paola parla in nome di una tradizione che si fonda su un codice morale articolato, assoluto e rigoroso. Benché funzioni come istanza psicologica, è fin troppo evidente che esso fa riferimento ad un quadro di mentalità la cui appartenenza al mondo storico è indubbia. Non è, dunque, un homunculus, bensì un quadro di mentalità mirante ad assoggettare e ad assimilare l’Io, dotato di un potere tale da connotare la sua ribellione come una colpa da espiare. Il potere del Super-Io, funzionario psicologico del mito gerarchico, si fonda, dunque, meno sulla autenticità dei valori che esso veicola che sulla capacità che ha di distorcere il bisogno di opposizione, restituendolo al soggetto come una minaccia pulsionale che, se sfuggisse al controllo, potrebbe compromettere l’identità sociale. E in conseguenza di questo ricatto che l’Io, sia pure malvolentieri, è costretto ad allearsi con il Super-Io.
Ci si può chiedere, ora, se questa matrice conflittuale, che contrappone di fatto Super-Io e bisogni umani, e fenomenologicamente l’appartenenza sociale come subordinazione alla libertà individuale anarchica come minaccia di esclusione, sia occasionale nel senso di concernere alcune esperienze di disagio psichico, o non piuttosto generalizzabile a tutto l’universo psicopatologico.
Capitolo sesto
Strutture psicopatologiche
L’esperienza di Paola si presenta strutturata come un cristallo. Gli elementi strutturali sono agevolmente definibili. C’è, anzitutto, un insieme di bisogni di contatto e di investimento nel mondo ma, nel contempo, di opposizione e di riscatto frustrato e distorto fino al punto di configurarsi sotto forma di disordine pulsionale (è una perdita di controllo, di fatto, che avvia l’esperienza delirante). C’è, in secondo luogo, l’Io che, sotto la spinta delle pulsioni la cui fenomenologia rende impossibile il riconoscimento dei bisogni, tende a rifuggire da esse identificandosi con un ideale elevato, che comporta l’isolamento dal mondo e il raccoglimento nello studio. C’è, infine, la persecuzione del Super-Io che in nome di una tradizione culturale identificabile con precisione cui Paola, nel suo intimo, si è ribellata, rifiutando visceralmente il ruolo servile da essa assegnato alle donne si esercita sotto forma di un controllo sociale, sia pure immaginario, che la mantiene comunque nell’ordine, imponendole di vivere in una dimensione di perenne pentimento e di espiazione. Essendosi sottratta al ruolo di moglie, a Paola, in breve, non rimane altro che la claustrazione sororale.
La trasparenza dell’esperienza lascia intendere quale debba essere il metodo che la scienza psicopatologica deve fare proprio per porre ordine in un universo nel quale le molteplici variabili legate all’esperienza individuale, familiare e socioculturale sembrano rendere ogni interpretazione opinabile: il metodo dello strutturalismo genetico. Esso mira a semplificare l’universo psicopatologico in virtù della definizione di modelli, e cioè di costruzioni più o meno astratte che condividono alcune caratteristiche strutturali del dominio modellato. Con ciò non si intende negare l’unicità irripetibile di ogni vicenda umana: nella sua raffinatezza logica, il delirio di Paola si può ritenere un’autentica “creazione”. Ma l’unicità concerne i contenuti esperienziali e i modi in cui essi sono organizzati, non la struttura dell’esperienza che è riconducibile ad un modello, che può essere rappresentato come nello schema seguente.
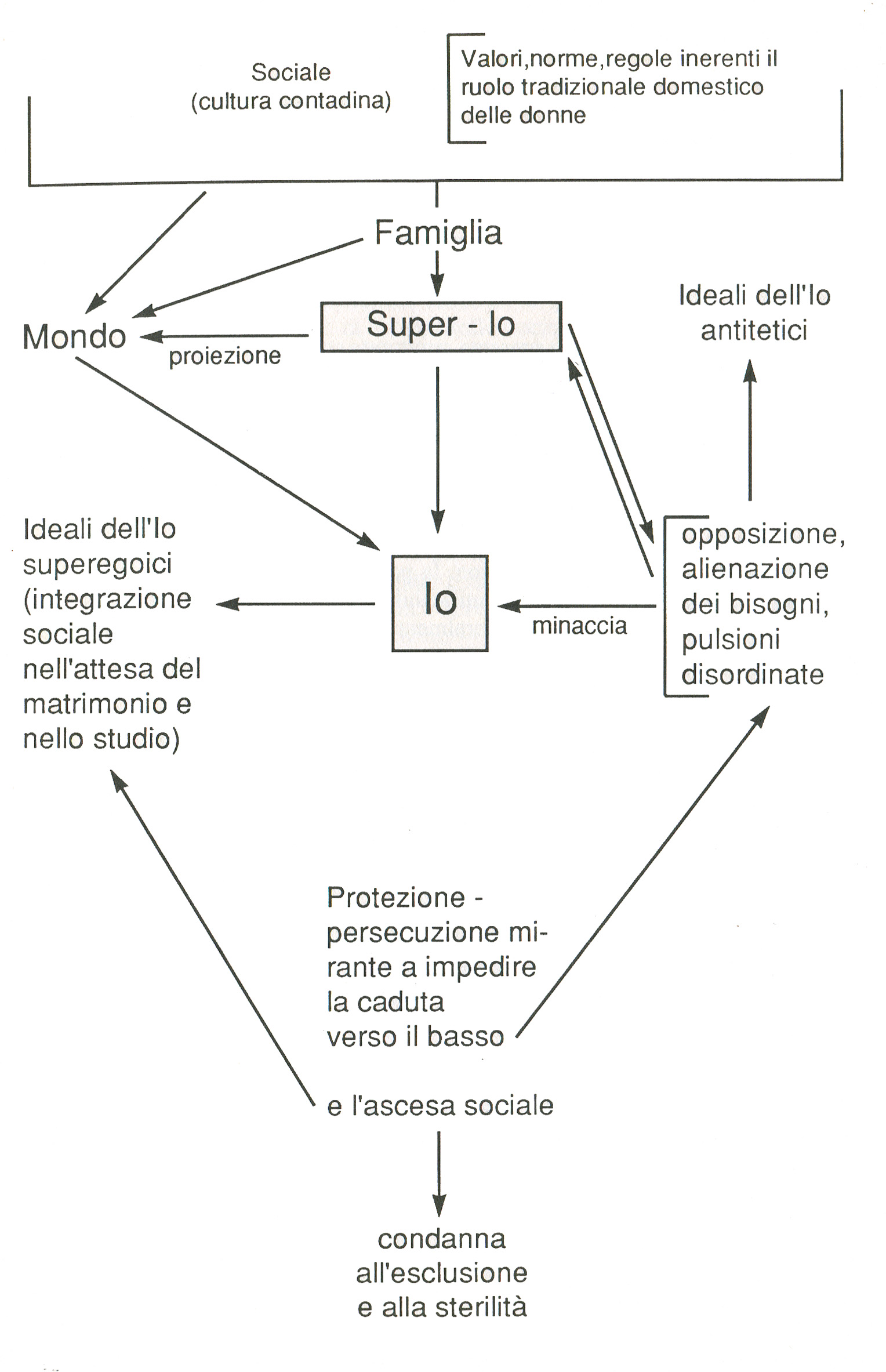
Il modello si può definire strutturale poiché la costrizione emotiva, intellettiva, volitiva che in virtù di esso si esercita non è riconducibile alla somma degli elementi che lo compongono (bisogni alienati, lo, Super-Io, ideale dell’Io), bensì all’interazione dinamica tra di essi, dall’insieme. L’organizzazione interna del modello è, dunque, strutturale, ma la sua spiegazione non può ricavarsi che dalla genesi. Per esempio, se si ignorasse che i valori proposti a Paola rientrano nel quadro di un mito gerarchico repressivo, di matrice religiosa, sarebbe impossibile capire la rappresaglia superegoica nei confronti della vocazione di Paola per lo studio, attività non istintuale, ma, nel contesto di quel mito, egualmente pericolosa, poiché può “guastare” l’anima.
Questa osservazione permette di comprendere la differenza tra lo strutturalismo genetico adottato dalla psicoanalisi e quello che noi utilizziamo, che, in riferimento alla teoria dei bisogni, può essere definito dialettico. Dal punto di vista psicoanalitico, la struttura psicopatologica è funzionale al mantenimento di un sia pur precario equilibrio tra l’istanza superegoica e le pulsioni. Dal nostro punto di vista, che assume le pulsioni come espressione fenomenologica di bisogni frustrati che continuano a premere per essere integrati nella personalità e nel suo rapporto con il mondo, la struttura psicopatologica appare funzionale solo al fine di mantenere il potere del Super-Io. La catastrofe dell’identità personale e sociale che essa sembra scongiurare, e la paura della quale sancisce l’alleanza dell’Io con il Super-Io, è nulla più che un inganno fenomenologico, riconducibile all’incapacità della coscienza di ricostruire il tragitto di esperienza che ha prodotto l’alienazione dei bisogni.
C’è una seconda differenza, forse ancora più rilevante. Lo strutturalismo psicoanalitico, pur riconoscendo una matrice univoca psicopatologica il conflitto tra Super-Io e Es , non essendo dialettico, postula genesi diverse per diverse fenomenologie psicopatologiche: tanto più arcaiche quanto più il conflitto è intenso.
In conseguenza di ciò, la teoria psicoanalitica finisce nel vicolo cieco del soggettivismo assoluto, destorificante, poiché la strutturazione del Super-Io, nelle forme più gravi, si configura come l’effetto di fantasmi meramente proiettivi. Mettendo tra parentesi la psicopatologia infantile, della quale si dirà qualcosa nel capitolo sui sistemi familiari, e dunque in riferimento ai fenomeni di disagio psichico che si manifestano dalla fine delle fasi evolutive in poi, il nostro punto di vista porta a pensare che non solo la matrice psicopatologica sia univoca, e riconducibile al conflitto tra Super-Io e bisogni alienati, ma che esiste un’unica struttura psicopatologica quella ossessiva della quale le altre strutture rappresentano delle varianti, e alla quale possono essere ricondotte tutte le manifestazioni di disagio psichico. E inutile aggiungere che la struttura ossessiva, le cui premesse risalgono alle fasi evolutive della personalità, si definisce in epoca adolescenziale, in rapporto allo schiudersi di un orizzonte che investe la relazione del soggetto con il mondo. E il progettarsi del soggetto nel mondo, e nel futuro, alla luce della struttura del suo mondo interiore, a porre le premesse per l’affiorare del disagio psichico.
L’esperienza di Paola rappresenta, sotto questo profilo, un’esperienza esemplare. Il delirio di amore destinato poi a connotarsi come persecutorio, insorge ex abrupto, da un giorno all’altro, nel momento stesso in cui, sotto la spinta dei bisogni, Paola apre gli occhi sul mondo. Come si configura la struttura della sua esperienza il giorno prima? Non ci può essere dubbio riguardo al fatto che il conflitto tra Super-Io e bisogni alienati fosse già strutturato e che Paola, com’è attestato dal ruolo di “madonnina” in cui si era calata, fosse già orientata verso un ideale dell’Io elevato e repressivo. La struttura preesistente al delirio si configurava, dunque, come una struttura ossessiva, atta a controllare un’esigenza di libertà identificata con una tendenza alla perdizione.
Ammettendo che la pressione dei bisogni, mirante ad affrancare Paola da un’identità superegoica alienata, abbia determinato la perdita di controllo sullo sguardo, assoggettato sino a quel momento al codice comportamentale dell’apparente indifferenza all’universo maschile, ne discende che il delirio ha rappresentato una “catastrofica” trasformazione della preesistente struttura ossessiva.
La convinzione superegoica che la natura femminile, in sé e per sé squilibrata, richiede un rigido controllo morale, rafforzata dal repentino cedimento soggettivo, si ripropone proiettivamente sotto forma di controllo sociale. Il cambiamento strutturale, che trasforma in esperienza psicopatologica una dinamica conflittuale precedentemente infraclinica, pone in luce l’opposizione tra l’identità superegoica e un bisogno di libertà incoercibile, che, in sé e per sé, potrebbe funzionare come attrattore di una riorganizzazione dialettica dell’esperienza di Paola.
La fenomenologia clinica, dunque, non è solo un indice dell’intensità del conflitto tra identità superegoica e bisogni frustrati. Ciò che determina l’irriducibilità del conflitto e ciò, come vedremo, vale per ogni esperienza psicopatologica è la confusione soggettiva in rapporto ad esso, che determina la scissione dell’Io. In Paola, tale confusione è attestata dal modo drammatico in cui essa elabora coscientemente il cedimento al bisogno seduttivo, che pone in luce la sua connivenza con l’ideologia della natura femminile squilibrata. Questa connivenza incrementa, nonostante la ribellione, l’alleanza con il Super-Io, determinando la fuga verso un ideale dell’Io onesto vissuto come salvifico, mentre è in realtà ulteriormente mortificante, e lo strutturarsi di un rapporto con il mondo che, per effetto della protezione/persecuzione sociale, esclude ogni ulteriore possibilità di espressione di bisogni frustrati. La trasformazione strutturale che traspare nell’esperienza di Paola è, a nostro avviso, generalizzabile.
Esiste un’unica matrice conflittuale psicopatologica. Tale matrice si esprime immediatamente, e cioè fenomenologicamente, nella struttura ossessiva, che rappresenta, dunque, il modello psicopatologico di riferimento, rispetto al quale le altre strutture rappresentano delle varianti. Quanto a queste altre strutture, a noi sembra che siano riconducibili a tre: la struttura isterica, la struttura maniacodepressiva e la struttura delirante.
Ci rendiamo conto che l’ipotesi di una matrice conflittuale univoca e di una sola chiave strutturale può apparire scarsamente credibile in rapporto alla fenomenologia e all’epidemiologia del disagio psichico. Ma occorre tenere conto, anzitutto, che l’ipotesi fa riferimento ad un modello, e cioè ad una costruzione astratta che mette tra parentesi le variabili soggettive, familiari, sociali e culturali. A livello reale, sono queste variabili a differenziare le esperienze psicopatologiche e a definire ciascuna di esse, per alcuni aspetti, come unica e irripetibile.
In secondo luogo, per valutare adeguatamente quell’ipotesi occorre considerare che i termini adottati per definire la struttura chiave e le varianti appartengono al linguaggio tradizionale psichiatrico, ma, dal nostro punto di vista, essi non hanno un significato immediatamente clinico. Ovviamente, si dà un rapporto tra strutture psicopatologiche e fenomenologia clinica; ma, come vedremo, si tratta di un rapporto molto più articolato rispetto alla tradizione psicopatologica, tal che ad ogni struttura fanno capo fenomeni di disagio diversi, e, talora, apparentemente estranei.
Prima di dedicarsi all’analisi delle singole strutture, appare opportuno tentare di raffigurare il modello strutturale al quale facciamo riferimento:
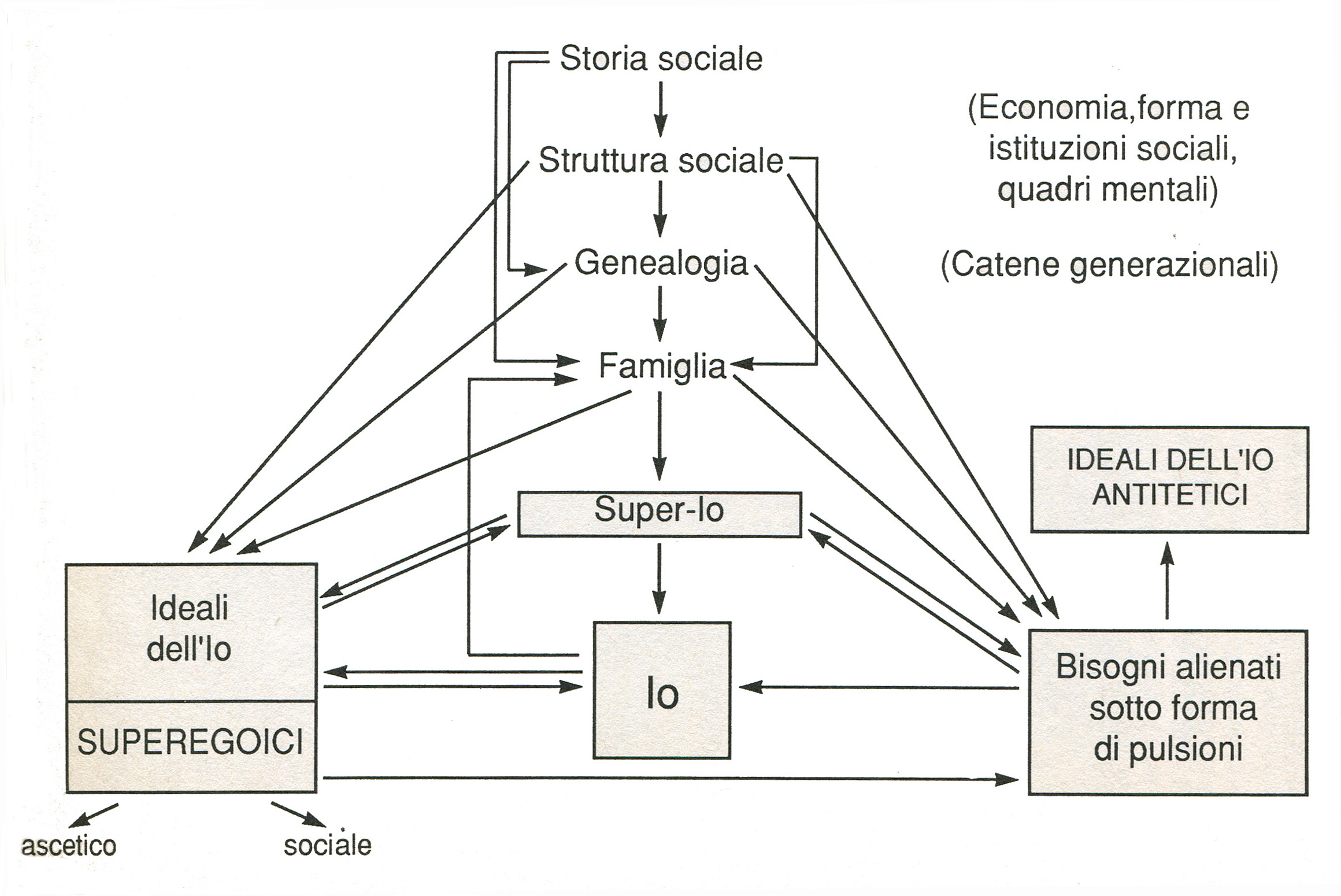
Si tratta, come è evidente, di un modello strutturale inerte nel quale l’Io appare perseguitato dalla minaccia pulsionale, assoggettato alla dittatura superegoica e orientato verso la realizzazione di un ideale posto al riparo dal pericolo di un’esclusione sociale. Alla luce di questo modello si può capire meglio la dinamica delle singole strutture.
1. La struttura ossessiva
La struttura ossessiva è una rigida armatura interiore e comportamentale superegoica che mira a preservare un livello di integrazione sociale acquisito, e quindi un’immagine di sé corroborata da uno o più ruoli agiti e convalidati da una rete di relazioni interpersonali, dai pericoli che il soggetto associa alla rivelazione del suo “vero” essere, che urge per effetto di un incoercibile bisogno di individuazione. In altri termini, la struttura ossessiva è caratterizzata dalla necessità di mantenere, a qualunque costo, una condizione soggettiva e sociale alienata, di normalità meramente mimetica, per scongiurare un cambiamento, peraltro irrinunciabile, vissuto in termini catastrofici.
Fenomenologicamente, la catastrofe si riferisce a due pericoli apparentemente antitetici: l’uno concerne la possibilità che l’Io, venendo meno l’armatura superegoica, crolli manifestando agli occhi degli altri la sua intima inadeguatezza, la sua vulnerabilità e impotenza; l’altro, che l’lo, travolto dalle pulsioni amorali e asociali che alberga, esploda abbandonandosi a comportamenti anormali, folli e/o criminali.
Dinamicamente costitutiva della struttura ossessiva, al di sotto di una maschera superegoica dotata solitamente di un elevato grado di coerenza, è la percezione, più o meno consapevole, di un Io “vero” scisso in due comportamenti negative: una patetica debolezza e una drammatica pericolosità sociale. La debolezza comporta la paura di poter intrattenere con gli altri solo relazioni di dipendenza, acquiescenza, sottomissione, senza peraltro scampare allo stigma del ridicolo, che l’ossessivo associa al suo essere nano, impedito nello sviluppo e cristallizzato nell’inadeguatezza.
La pericolosità sociale, viceversa, determina la paura di una perdita di controllo comportamentale che, dando luogo ad azioni amorali e asociali, esporrebbe ad un’inesorabile rappresaglia sociale sotto forma di rifiuto e/o di privazione della libertà. Per scongiurare entrambi questi pericoli, il soggetto si arrende a vivere in un’armatura, superegoicamente prescritta, che coincide vuoi con una protesi vuoi con una camicia di forza comportamentale, valutando razionalmente la normalità dei suoi comportamenti, perennemente nel dubbio che essi possano aprire uno spiraglio sul mondo interno. La percezione scissa, e in ogni caso negativa, di questo mondo determina però anche una paura fobica dell’introspezione. Anche sul versante soggettivo, non meno che su quello sociale, l’ossessivo teme, dando libero corso ai pensieri, alle emozioni, alle fantasie, di trovarsi di fronte a prove inconfutabili della sua anormalità, e dunque di impazzire. Nonché gli altri, deve dunque ingannare anche se stesso. Ciò rende necessario alimentare la scissione dell’lo, per poter continuare a dubitare, e cioè opporre ad una disarmata vulnerabilità una potenziale pericolosità e viceversa.
In conseguenza dell’immagine negativa di sé, l’ossessivo vive male sia da solo che in relazione agli altri: la solitudine, che obbliga a stare faccia a faccia con se stesso, si anima infatti della paura di una spersonalizzazione; la socialità, della paura di una perdita di controllo comportamentale che, smascherando l’Io vero, potrebbe produrre il rifiuto e/o l’esclusione.
La struttura ossessiva comporta, dunque, una perpetua oscillazione dall’isolamento alla socialità e viceversa; quando è solo, l’ossessivo avverte il desiderio di una relazione, che funzioni come rinforzo della maschera superegoica; quando è in relazione sperimenta il desiderio di sottrarsi ad essa il più presto possibile per scongiurare una drammatica resa di conti vissuta costantemente come imminente. La paura di stare li lì per crollare o per esplodere, che incombe come una nuvola minacciosa su ogni dimensione esistenziale, è, pertanto, il momento dinamico più specifico, fino al punto di assumere un valore patognomonico, della struttura ossessiva.
C’è da chiedersi come una siffatta tensione minacciosa possa essere sopportata a lungo, talora per anni, senza dar luogo a destrutturazioni che intervengono, come vedremo, in un numero esiguo di esperienze. Ciò è dovuto a due diverse difese: la prima, che obbliga l’ossessivo a vivere, per così dire, alla giornata, si fonda sulla fiducia di poter mantenere l’ipercontrollo, e cioè la mistificazione, rinforzata dalle prove di scampato pericolo che si susseguono; la seconda, su di un progetto di “guarigione”, e cioè di soluzione radicale del problema, che si configura solitamente nei termini di un dominio razionale assoluto sul mondo delle emozioni, che trasformerebbe la maschera superegoica in una realtà esistenziale definitiva, affrancata da ogni fluttuazione.
L’ideale dell’lo ossessivo comporta la rinuncia ad integrare culturalmente la vita emozionale in nome di una “computerizzazione” logica dell’esperienza interiore e relazionale. Per rimanere proteso verso questo ideale, che mira letteralmente a cristallizzare ciò che nell’uomo è necessariamente fluido, il corso delle emozioni, l’Io ossessivo accetta e subisce le prescrizioni superegoiche che, benché lo schiavizzino, vengono vissute come potenzialmente liberatorie. La subordinazione dell’Io a quelle prescrizioni, che si esprime in una maschera sociale irrigidita dalla necessità di esibire una perfetta normalità, lo rende però penosamente schiavo, sia pure solo formalmente, delle aspettative altrui e, in senso lato, dei codici sociali di normalizzazione, impedendogli il salto dialettico verso l’individuazione, che, benché irrinunciabile, è vissuto come catastrofico.
Nella struttura ossessiva, la scissione dell’Io è l’espressione immediata di un conflitto irriducibile tra i bisogni fondamentali che, per effetto delle interazioni con l’ambiente, giungono ad alienarsi, e cioè a configurarsi in termini tali da non poter essere integrati dialetticamente. Il blocco dell’opposizione lascia di fatto l’lo in una condizione di dipendenza impotente in rapporto alle aspettative e alle volontà altrui. Ma, nel contempo, quel blocco determina, di solito inconsapevolmente, il rifluire dell’opposizione in fantasie pulsionali che mantengono la tensione dell’Io verso la liberazione ma, per la loro configurazione esplosiva, anarchica e trasgressiva, conseguono l’effetto di terrorizzare l’Io, ponendolo di fronte alla sua intima “natura” asociale e amorale. Non potendo, perciò, procedere sulla via della individuazione, l’Io è costretto a rimanere socialmente integrato secondo la maschera alienata superegoica, che impone il rispetto, sia pure meramente formale, di norme, regole e valori che oppongono irriducibilmente natura e cultura. Il sacrificio della libertà personale in nome dell’appartenenza sociale è reso possibile, e alimentato, dall’aspettativa mitica di conseguire un dominio assoluto sulle pulsioni. L’aspettativa è vana, poiché dietro le pulsioni premono i bisogni, e la pressione si incrementa in misura direttamente proporzionale alle frustrazioni cui essi sono assoggettati dal regime superegoico.
Già il solo punto di vista psicodinarnico basta a spiegare l’inerzia della struttura ossessiva: sottoposto a due forze di pari intensità ma di verso opposto l’ideale dell’Io e i bisogni alienati di individuazione l’lo può permettersi di oscillare solo modestamente intorno ad un punto di equilibrio che rappresenta la componente delle forze stesse. Ma, al di là del punto di vista dinamico, occorre tener conto di altri elementi che determinano l’inerzia. Come la perdita di controllo pulsionale evoca la paura di una rappresaglia sociale, così, paradossalmente, la possibilità di raggiungere un dominio completo e razionale sulle pulsioni evoca la paura della vendetta.
Affrancato dalla necessità di conformarsi alle aspettative degli altri, sterilizzato nelle emozioni e nella sensibilità, cosa potrebbe infatti impedire all’Io di trattare gli altri come oggetti, sia pure nell’ottica di una fredda razionalità? La liberazione verso l’alto, in direzione dell’ideale dell’lo, comporta rischi diversi ma non meno gravi della liberazione verso il basso, nella direzione delle pulsioni. Dovendo vivere come un servo senza dignità, l’ossessivo teme di poter diventare un padrone senza cuore. Il rapporto padrone/servo, che struttura la personalità, è l’unica forma di rapporto sociale che l’ossessivo riesce a concepire: ma la stessa sensibilità che gli impone di mantenere un atteggiamento servile, sia pure riscattato dal sentirlo come falso, gli impedisce di asservire l’altro. Non sorprende, pertanto, che egli miri vanamente a liberarsene, e che, al fine di occultarla e di negarla, frapponga tra essa e la sua coscienza una barriera di cinismo e di barbarie.
Queste considerazioni offrono l’occasione di accennare alla genesi esperienziale della struttura ossessiva. Il dato originario, infatti, è proprio la sensibilità, strumentalizzata al fine di estinguere l’opposizione da contesti educativi o francamente repressivi tali da concedere all’opposizione solo lo sbocco della rabbia cieca o, viceversa, insidiosamente seduttivi e armoniosi tali da identificare l’opposizione con l’ingratitudine, il disordine, la cattiveria. Non di rado entrambe le circostanze si condensano negli stessi contesti. La conseguenza univoca è la criminalizzazione del bisogno di opposizione che va frustrato o per non entrare in conflitto con un ordine gerarchico minaccioso o per non attaccare un mito dell’armonia mortificante. Non potendo agire l’opposizione, e dunque non potendo individuarsi, il soggetto rimane schiavo della sensibilità e delle identificazioni che ha essa prodotto, introiettata sotto forma di Super-Io e ideale dell’Io. L’unica possibilità di affrancarsi da questa penosa schiavitù è l’utopia di un universo sociale assoggettato a rigide regole di comportamento e vigilato da un’autorità suprema giusta. Universo di automi disposti, in nome di una giustizia formale, a sacrificare i bisogni umani di contatto, di interazione e di conflitto evolutivo. Questa ideologia, latente in ogni struttura ossessiva, rievoca ed esprime la nostalgia di un ordine gerarchico sperimentato prima che insorgesse il bisogno di opposizione: un ordine reale e mitico al tempo stesso che essa riabilita, rimuovendo il fatto che quell’ordine, fondato sul potere assoluto dei “grandi” e sulla cieca fiducia dei “piccoli”, non può riprodursi che in virtù di un conflitto che approdi al riconoscimento della pari dignità tra gli esseri.
La pressione di un Super-Io, che, criminalizzando il bisogno di opposizione, fa incombere incessantemente la minaccia di esclusione sociale, il fascino persistente di un ideale dell’Io elevato, affrancato dagli istinti e da ogni perturbamento emozionale, e la pressione dei bisogni frustrati, permettono di comprendere i modi diversi in cui la struttura ossessiva si declina nelle esperienze soggettive.
La pressione dei bisogni, vissuta angosciosamente come minaccia pulsionale anarchica, mirante a trasformare il soggetto in una sorta di mister Hyde, funziona come un tapis roulant, la cui velocità di scorrimento è direttamente proporzionale alla frustraziohe dei bisogni, sul quale l’ossessivo spende le sue migliori energie nel tentativo di non perdere terreno, rimanendo rivolto ad un ideale dell’Io irraggiungibile. La apparente staticità della struttura ossessiva non dipende, però, solo dalla pari intensità delle forze opposte, l’ideale dell’Io, i bisogni che la animano. Di fatto, l’Io stesso partecipa a mantenere quella staticità con un atteggiamento ambivalente: l’alleanza cosciente con l’ideale dell’Io, nel quale l’ossessivo vede la salvezza, è minata infatti dall’intuizione che quell’ideale comporta l’inclusione nel mondo al prezzo della rinuncia ad ogni contatto autentico. Per quanto alienati sotto forma di istinti, i bisogni, dai quali l’ossessivo di difende, sono vissuti come irrinunciabili, poiché essi rappresentano l’apertura emozionale al mondo.
La fenomenologia clinica della struttura ossessiva è riconducibile, nei suoi molteplici aspetti, alla necessità di mantenere una condizione di equilibrio precario e mistificato, rivolto apparentemente allo scioglimento dei vincoli istituali ed emozionali, ma, di fatto, anelante a ristabilire con il mondo un contatto autentico e liberatorio. Questa contraddizione di fondo, dovuta al fatto che l’Io ossessivo vive la propria condizione in termini rovesciati in rapporto al processo di vita che l’ha prodotta, è denunciata con chiarezza dalla sovrastruttura fobica che si associa sempre alla struttura ossessiva. L’ideale dell’Io verso cui tende l’ossessivo rappresenta la libertà dagli istinti e la chiusura rispetto al mondo delle emozioni: momento “agorafobico” ma nel contempo “claustrofobico”, riconducibile alla metafora del deserto, aperto in tutte le direzioni ma assente di vita; i bisogni, altresì, in rapporto alla loro configurazione istintuale, rappresentano la libertà assoluta nel rapporto con il mondo ma una radicale messa in gioco dell’identità sociale: tentazione prepotente “agorafobica” associata alla “claustrofobia” della tomba, della prigione o del manicomio.
E chiaro che la struttura ossessiva, in virtù della sua genesi e della sua dinamica, comporta molteplici possibilità evolutive, riferibili alla necessità di mantenere un equilibrio minimale tra le diverse istanze o di restaurarlo quando esso, per circostanze legate all’intensità del conflitto soggettivo o alle influenze ambientali, giunge ad essere compromesso. Il quadro conclamato della nevrosi ossessivo-fobica è solo la punta di un iceberg il cui corpo è l’universo psicopatologico.
Il rapporto tra la struttura ossessiva e le altre strutture, assunte come varianti, sarà analizzato successivamente. Ora ci preme soffermarci sulla fenomenologia clinica della struttura ossessiva che comporta un quadro di riferimento e delle organizzazioni complementari. Il quadro di riferimento è caratterizzato dalla necessità di mantenere un equilibrio strutturale rigido, e di correggere prontamente le oscillazioni dovute alla pressione del Super-Io e dei bisogni alienati. Si tratta, però, di un equilibrio ingannevole, nel senso che l’Io scambia come dominio e controllo un modo di essere che corrisponde totalmente alle prescrizioni e proscrizioni superegoiche. La prescrizione è attestata dal comportamento sociale, animato da un’angoscia che induce l’ossessivo ad attenersi ad un codice di normalità anonima e conformistica; dai rituali, la cui ambivalenza si esaurisce nel prevalere costante del momento repressivo; e dalle fobie, che impongono di evitare situazioni che darebbero luogo a squilibri emozionali. Le proscrizioni investono, sul versante sociale, ogni comportamento spontaneo, e, sul versante interiore, ogni abbandono intersoggettivo, che pone l’ossessivo a contatto con pensieri, fantasie e desideri asociali e amorali nei quali egli non sa decifrare la pressione dei bisogni.
Le organizzazioni complementari corrispondono a lievi squilibri strutturali verso l’ideale dell’lo o verso le libertà pulsionali che, anziché essere corretti, vengono razionalizzati.
Lo squilibrio verso l’ideale dell’Io postula una più o meno rilevante mortificazione del corpo, del piacere, della libertà. L’ascetismo può realizzarsi in vari modi. Talora e sono le esperienze che con maggiore facilità appaiono normali, in conseguenza della efficienza prestazionale che le caratterizza l’ascetismo si esprime sotto forma di un’organizzazione di vita totalmente dedita al dovere, si tratti di studio, di lavoro o di attività domestiche. In questi casi è facile che si realizzi un brusco trapasso dalla apparente normalità alla depressione o al blocco psicotico. Altre volte l’ascetismo coincide con una pratica religiosa esasperata, e perpetuamente minacciata da tentazioni demoniache.
Il vissuto del corpo come fonte e veicolo di istinti “morbosi” può anche tradursi in paure e angosce ipocondriache, che esprimono la pressione colpevolizzante delle pulsioni. Non di rado queste angosce inducono la convinzione di una malattia tumorale o contagiosa che andrebbe radicalmente risolta.
In alcuni casi la mortificazione si realizza con stragegie che mirano direttamente alla inibizione degli istinti. Rientra in questo ambito l’anoressia, che è quasi sempre il sintomospia di una spietata dittatura superegoica che investe tutto l’ambito dei comportamenti. Ancora in questo ambito rientra il delirio di contatto, che, in nome di un ideale dell’Io di assoluta innocenza, impone al soggetto di offrire, a se stesso e agli altri, una prova perpetua di non voler avere nulla a che fare con la “sporcizia” del mondo.
Lo squilibrio verso la libertà pulsionale si organizza secondo modalità diverse. Talora è l’angoscia estetica a raggiungere livelli fobici: in tali casi, un minimo difetto fisico reale o immaginario induce nel soggetto la convinzione assoluta che la sua immagine interna, animata dal disordine pulsionale, si sia resa percettibile già socialmente, e lo esponga, dunque, al rifiuto o all’esclusione. Altre volte, il rigido regime superegoico viene, nonché allentato, negato e compensato da comportamenti episodici o ricorrenti di disordine pratiche sessuali “perverse”, uso di alcool o droghe, trasgressioni sociali, ecc. la cui caratteristica è di realizzarsi sul filo del rasoio di un rischio sostanzialmente calcolato. Altre volte ancora e sembra un paradosso la fenomenologia comportamentale appare totalmente votata alla esibizione di atteggiamenti anticonformistici, ribellistici, asociali: ma anche in questi casi il soggetto sembra molto attento nel valutare le conseguenze sociali dei suoi comportamenti, la massima parte dei quali sono agiti all’interno di spazi familiari.
C’è da considerare, infine, un’ultima possibilità: quella legata al fatto che una struttura ossessiva latente, sia socialmente che soggettivamente, si manifesti repentinamente sotto forma di actingout più o meno violenti. In questi casi, il passaggio all’atto può bruscamente inaugurare un’esperienza delirante.
2. La struttura isterica
Data la stessa matrice conflittuale che, colpevolizzando il bisogno di opposizione, determina la scissione dell’Io in due parti non integrabili dialetticamente, la struttura isterica si differenzia dalla ossessiva per caratteristiche molteplici. Anzitutto, la scissione è connotata culturalmente in maniera diversa: il nanismo, impotente e ridicolo, che l’ossessivo si affanna ad occultare, si configura, a livello isterico, in termini di infantilismo, innocenza, ingenuità tale che spesso è esibito; viceversa, il riferimento alla follia criminale, che incombe sull’ossessivo, si pone, nell’isterico, come onnipotenza relazionale sull’altro, su di un registro che spazia dalla seduzione al sadismo. La scissione ossessiva tra Io nano e Io folle/criminale e quella isterica tra Io angelico e Io demoniaco/stregonesco permette di comprendere i motivi per cui, nella storia della psicopatologia non meno che a livello di opinione pubblica, la struttura ossessiva risulta associata all’universo maschile e quella isterica all’universo femminile. Benché non del tutto priva di significato, soprattutto per quanto concerne il modo in cui il bisogno di opposizione viene pedagogicamente qualificato in rapporto all’esser uomo o all’esser donna, tali associazioni si possono oggi ritenere superate in nome di una fenomenologia psicopatologica comparata che pone in luce caratteristiche differenziali più sottili. In primo luogo, mentre nella struttura ossessiva la maschera sociale serve a fingere una perfetta normalità sul registro della correttezza comportamentale formale e ad escludere una qualunque forma di intimità, aborrita fobicamente, la maschera isterica mira meno a scongiurare l’esclusione che a promuovere una perpetua conferma. Essa si anima, dunque, su di un registro espressivo che va dall’estremo di una innocenza “infantile”, che sollecita la protezione, all’estremo opposto di una disponibilità relazionale disinibita e seduttiva. Tanto l’ossessivo teme la relazione con il mondo, quanto l’isterico ne ha un perpetuo, disperato bisogno. Questa differenza fa capo al modo diverso in cui viene perpecita l’immagine interna. Nella struttura ossessiva questa è vissuta come traboccante di pensieri, desideri e fantasie asociali e amorali; nella struttura isterica, il mondo interiore si configura come vuoto e indistinto, avvolto e velato da una nebbia che lo rende indecifrabile. L’ossessivo sa e teme di albergare una parassitaria “mostruosità”, l’isterico sa di non essere che come “appare”, e dunque di dover apparire continuamente per essere.
Per quanto fitta, la nebbia non riesce mai a rimuovere del tutto l’animazione dei bisogni frustrati. Ogni tanto, il velo si squarcia repentinamente e irrompono nella coscienza fantasie più o meno organizzate, quasi sempre a carattere terrificante che o la tramortiscono o si convertono immediatamente in inibizioni funzionali.
A differenza della struttura ossessiva, che argina i temuti actingout con uno stato permanente di allarmato ipercontrollo, la struttura isterica che, per effetto della rimozione, può associarsi ad uno stato di coscienza di assoluta serenità, tende ad estinguere le irruzioni del mondo interno in virtù di collassi funzionali, fino all’estremo limite del venir meno della coscienza.
Questa drammatica reazione lascia intuire che, dietro la nebbia, ci sia un’immagine antitetica rispetto a quella che socialmente l’isterico esibisce: una seconda identità, che preme per affiorare. Mentre la maschera ossessiva, pur minacciata dall’angoscia perpetua di stare lì lì per cedere, riesce ad essere mantenuta indefinitamente, la maschera isterica, di fatto, può venir meno: in conseguenza di ciò, l’angelo, bianco o azzurro, si trasforma in un “demonio”. Il cambiamento di identità si realizza, il più spesso, in un ambito privato, nel contesto di una relazione duale: la dipendenza, la passività, l’innocenza, il bisogno di tenerezza e di protezione vengono letteralmente soppiantati dall’aggressività, dalla prepotenza e da un’insensibilità fredda nei confronti dell’altro che va da uno sprezzante cinismo ad un incoercibile sadismo. Il realizzarsi socialmente di questa identità negativa differenzia compiutamente la struttura isterica da quella ossessiva: tanto quest’ultima tende ad essere inerte, rigida e ripetitiva a livello sociale, quanto la prima appare caratterizzata da una fluidità che può esitare da un momento all’altro in un brusco cambiamento di personalità. Si tratta però di una fluidità circolare: come l’isterico si affranca da una dipendenza passiva, che lo pone in balia dell’altro, assumendo un atteggiamento di rabbiosa sopraffazione, così egli, in conseguenza dei sensi di colpa, può crollare nuovamente nella subordinazione.
Con un’evidenza maggiore rispetto alla struttura ossessiva, quella isterica pone in luce la drammatica alienazione dei bisogni fondamentali: l’integrazione sociale sembra poter avvenire solo al prezzo di un assoggettamento alle aspettative dell’altro; l’individuazione, viceversa, potersi realizzare solo sul registro della sopraffazione, della cattiveria e dell’oggettivazione dell’altro.
Facendo capo a due diverse identità, quest’alienazione orienta l’isterico verso due ideali antitetici: per un verso, infatti, egli appare autenticamente proteso a debellare la sua cattiveria in virtù dell’assunzione definitiva di un ruolo infantile, dipendente o docile; per un altro, sembra aspirare ad estirpare una sensibilità vissuta come debolezza per diventare irreversibilmente freddo, egoista e cinico. Di fatto, il primo ideale esprime una condanna superegoica. Benché ingannevole, poiché rievoca la nostalgia di un passato connotato miticamente, allorché la dipendenza e l’affidamento cieco all’altro assicurava una perpetua
conferma, di una condanna si tratta, che subordina il riconoscimento e la conferma dall’esterno al mantenimento da parte dell’Io di una posizione di dipendenza infantile e di impotenza. Tale condanna incombe sul bisogno di opposizione, che viene distorto dal suo fine primario che è quello di trasformare, per mezzo della conflittualità, l’impotenza originaria in una condizione di pari dignità rispetto agli altri.
Se l’isterico, infatti, vuole affrancarsi dalla schiavitù della dipendenza, non gli rimane altra possibilità che incattivirsi. E, se non vuole rischiare, in conseguenza di ciò, il rifiuto e l’abbandono, deve farlo nei confronti di qualcuno che non possa sottrarsi, per debolezza, pietà o amore, al rapporto: istaurare, infine, una crudele dittatura su chi, non potendo sottrarsi ad essa, si trova di fatto in una condizione di estrema debolezza.
Il bisogno profondo di giustizia, da cui muove la ribellione isterica, giunge dunque ad esprimersi in maniera perversa, il riscatto personale potendo realizzarsi solo al prezzo dell’umiliazione dell’altro. La crudeltà con cui, talora, l’isterico persegue questo progetto, giungendo a liberarsi sprezzantemente dell’altro dopo averlo torturato, rivela il pericolo da cui egli si difende: la sensibilità intesa come debolezza che rende schiavi. In rapporto a questo pericolo, l’unica soluzione possibile sembra essere l’anestesia e la resa ad una logica che sancisce il diritto del più forte di trattare il debole come un servo o un oggetto.
La fobia della sensibilità, vissuta come esposizione al rischio di cadere in balia dell’altro, è dunque la matrice prima della struttura isterica. E’ chiaro che questa matrice è la stessa della struttura ossessiva, ma organizzata diversamente. Mentre la struttura ossessiva dà luogo ad una corazza atta ad isolare la sensibilità e rifugge da ogni situazione relazionale che possa metterla in gioco, la struttura isterica gravita verso una soluzione totale del problema: l’estinzione della sensibilità. Ma, non potendo questo obiettivo essere conseguito all’interno della personalità, esso non può realizzarsi che attraverso la relazione con l’altro. La maschera di innocenza o di disponibilità seduttiva dell’isterico è, dunque, una sorta di trappola, che mira a catturare una preda che, ingannata dalle apparenze, accetti la relazione; scattata la trappola, l’isterico può torturare l’altro e cercare di estirpare la propria sensibilità con il sadismo.
La tristemente nota malvagità isterica è una drammatica testimonianza dell’odio verso tutto ciò che è debole, dentro e fuori di sé. Quest’odio pone l’isterico di fronte a due soli modi di essere possibili: essere nella debolezza, nella dipendenza e nella schiavitù del bisogno di amore, rimanendo in una patetica condizione di impotenza infantile, o diventare adulti, potenti, insensibili e vivere godendo dello sfruttamento dell’altrui debolezza.
La genesi della struttura isterica appare, ormai, ampiamente decifrabile. Occorre muovere da una sensibilità strumentalizzata dall’ambiente per imporre al soggetto di rimanere in una condizione di dipendenza passiva e connivente, esibita, sotto forma di maschera di innocenza, di serenità, di gioia, al fine di confermare la sua integrazione armoniosa con un mondo familiare che rifiuta il conflitto. Il bisogno di opposizione, date queste circostanze, non può essere espresso se non al prezzo di una colpa tremenda, la colpa di attaccare e distruggere l’armonia.
In nome di questo mito, il soggetto deve continuare ad apparire passivo, dipendente ed innocente: deve lasciarsi manipolare dalle aspettative degli altri per continuare a sentirsi confermato. Questa necessità esterna corrisponde anche ad una necessità interna, il bisogno d’amore, che giunge ad essere vissuto come una schiavitù. Il bisogno di opposizione, non potendosi esprimere a livello di realtà, si ripiega e, animandosi nel corso del tempo, giunge a configurarsi come identità negativa, nodo di rabbia e di protesta contro la dipendenza e di rancore vendicativo nei confronti dell’altro, che la strumentalizza. In sé e per sé, il bisogno di opposizione mira solo ad eliminare la schiavitù e la falsificazione dei rapporti di potere in nome dell’esigenza di un legame significativo tra gli esseri che ne riconosca la pari dignità. Ma la configurazione rabbiosa che esso assume negli anni va oltre questo segno, e si orienta verso un radicale ribaltamento dei ruoli, per realizzare e mantenere il quale occorre rinunciare alla sensibilità e mirare ad estinguerla. Il Super-Io, che colpevolizza l’opposizione, lascia ad essa un solo scampo: esprimersi attraverso l’anestesia della sensibilità, che pone transitoriamente al riparo dalla colpa. Ma, se l’isterico non vuole ricadere nella trappola dell’espiazione, egli deve mantenersi anestetizzato: non accettando di rimanere un bambino passivo, dipendente e innocente, che è l’ideale dell’Io originario, egli deve accettare di diventare adulto nella logica imposta dalla categoria del Padrone e del Servo.
La fenomenologia clinica in cui si esprime la struttura isterica è straordinariamente complessa, data la fluidità della struttura stessa. Talora la fenomenologia tende ad esaurirsi in sintomi di inibizione o di angoscia che non pongono in gioco l’immagine sociale: l’isterico appare, in questi casi, un essere sostanzialmente docile, che intrattiene buoni rapporti con gli altri, sia pure su un registro di dipendenza e di socievolezza un po’ artefatta, e che viene attaccato dall’interno da una “malattia” che, compromettendo episodicamente le funzioni psichiche o fisiche, induce un repentino aumento della dipendenza sotto forma di aggrappamento, talora disperato, agli altri.
Talaltra, l’affiorare dei sintomi dà luogo, invece, ad una più o meno rilevante modificazione del carattere: l’isterico, giustificando ciò con la condizione di sofferenza, diventa nervoso, irritabile, rabbioso, intrattabile. Più diventa dipendente dagli altri, più sembra orientato a far pagare loro il prezzo della dipendenza. In altri casi ancora, è la modificazione del carattere e dello stile di vita a prevalere sui sintomi. Dopo essere rimasto per anni in una condizione di docilità e di dipendenza, l’isterico si ribella, attacca i legami preesistenti, e si lancia nel mondo con una sicurezza apparente del tuffo imprevedibile, cercando con insistenza prede con cui giocare la sfida del padrone e servo.
Un’altra possibilità clinica della struttura isterica è riconducibile al prevalere di una inibizione che pone il soggetto in condizione di non sperimentare la conflittualità sul piano relazionale. In questi casi, la struttura evolve verso un ritiro dalle situazioni emotivamente significative, e si traduce in una maschera di indifferenza nei confronti del mondo familiare ed extrafamiliare. Apparentemente il soggetto non soffre e razionalizza questa condizione, attribuendola ad una scelta di vita. Ma, di fatto, la sua inerzia, che lo obbliga ad una protratta dipendenza dalla famiglia, nei cui confronti egli sembra non avvertire alcun
sentimento che non sia di essere mantenuto, esclude una qualunque evoluzione sociale. Sono queste le situazioni di “insabbiamento” giovanile, che tradizionalmente identificate come psicotiche, di fatto possono, nel tempo, in virtù del difetto di vita e della pressione dei bisogni, diventare tali.
La manifestazione più rilevante, sotto il profilo clinico, della struttura isterica è data dall’alternanza della doppia identità, il più spesso entro uno spazio relazionale privato. In questi casi si realizza, sia sotto il profilo soggettivo che intersoggettivo, una dinamica tipicamente sadomasochistica: oppresso dal sadismo “protettivo” superegoico, il soggetto regredisce in una condizione di totale dipendenza familiare rispetto all’altro, al quale si aggrappa in maniera umiliante; quando il peso della dipendenza diventa intollerabile soggettivamente e fa insorgere il timore dell’abbandono, il soggetto trova la forza di ribaltare i ruoli e di sottoporre l’altro ad un’implacabile dittatura, finché il senso di colpa, che fa affiorare la paura del rifiuto e dell’abbandono, non determina un nuovo “crollo” nella dipendenza.
I giochi relazionali senza fine messi in luce dalla teoria sistemica, e che essa attribuisce a violazioni di leggi comunicative, rientrano in questo ambito: ma sono, con evidenza, drammatici giochi di potere, intrappolati nella categoria dinamica del padrone e del servo.
3. Gradienti strutturali
L’ipotesi di una matrice conflittuale costante, generatrice di tutte le forme di esperienza psicopatologica, definisce, come è ovvio, un oggetto teorico, e cioè una struttura che può essere costruita a partire dai dati forniti dalla fenomenologia clinica, ma che, in sé e per sé, non è empirica. Tale struttura riconosce due livelli conflittuali correlati tra loro: il primo oppone la forma superegoica, che veicola il bisogno di integrarsi socialmente e di condividere la cultura del gruppo di appartenenza, alla pressione del bisogno di opposizione/individuazione, che promuove un’integrazione critica, non passiva e l’assimilazione della cultura come soppressione dialettica dell’introiezione; il secondo, specifico di ogni esperienza psicopatologica individuale, oppone ad un sistema di autorizzazioni, proscrizioni e prescrizioni superegoiche emozionali e cognitive - rigidamente codificato, una ribellione viscerale che attesta l’impossibilità del soggetto di adattare ad esse la sua esperienza di vita.
Il primo livello conflittuale, secondo la nostra ipotesi, riverberebbe costantemente sul secondo, dando un carattere sacro e inattaccabile ai contenuti superegoici e, di conseguenza, colpevolizzando la ribellione soggettiva in termini di asocialità e amoralità. Costretto, in conseguenza di questa colpevolizzazione, a rimanere integrato socialmente su di un registro alienato, l’Io non può assumere il ruolo di mediatore dialettico dei bisogni e va incontro ad una scissione: una parte rimane identificata e subordinata al Super-Io; un’altra, sotto la spinta incoercibile del bisogno di opposizione, entra in conflitto con esso.
Definire ossessiva questa matrice conflittuale, e ipotizzare dunque che un nucleo dinamico ossessivo sia comune a tutto l’universo psicopatologico è reso
sufficientemente credibile dal fatto che un qualche grado di strutturazione ossessiva della personalità, caratterizzata da introiezioni superegoiche non ancora assimilate e quindi sovrapposte ad una quota di bisogni che gravita verso una coscienza morale critica, e cioè una differenziazione dell’identità, si può ritenere normale sino all’adolescenza. Non sussiste, però, alcuna difficoltà ad ammettere che la struttura isterica, fondata sulla rimozione della negatività, possa rappresentare, nonché una variante di quella ossessiva, un’espressione relativamente autonoma di una stessa matrice conflittuale. Adottando la prima ipotesi, e dando ad essa un significato di probabilità, a noi sembra che sia possibile fondare in maniera più rigorosa una psicopatologia strutturalista, che riconosca una matrice conflittuale della quale tutte le manifestazioni cliniche rappresenterebbero delle varianti o trasformazioni. Ma l’approccio strutturalista rimane sterile, ed esposto al rischio dell’astrazione, se non si tiene conto che le trasformazioni strutturali sono dovute non ad un gioco combinatorio logicoformale, bensì alla configurazione e alla dinamica dei bisogni: l’una determinata dalle introiezioni superegoiche, l’altra da una programmazione genetica.
Le strutture si trasformano per la necessità di adattare all’identità superegoica, che non può essere assimilata se non in virtù di una soppressione dialettica, la pressione dei bisogni frustrati che, nel corso del tempo, può rimanere costante o accrescersi. È allora evidente che, come l’approccio strutturalista permette di descrivere la fenomenologia delle forme di esperienza psicopatologiche, così il punto di vista dialettico postula dei gradienti strutturali, e cioè delle configurazioni dinamiche, espresse a livello clinico, la cui forma relativamente costante non può mantenersi che sino ad un livello critico, determinato dal conflitto tra i bisogni, al di là del quale va incontro, in maniera progressiva o critica, ad una trasformazione. I gradienti strutturali coincidono, in una certa misura, con le categorie nosografiche. Per quanto sommaria, e linguisticamente criticabile, la distinzione tra forme nevrotiche e forme psicotiche può essere riconosciuta, a patto che se ne ammetta la continuità dinamica, dovuta ad una comune matrice conflittuale, apparentemente smentita dai salti strutturali, che coincidono con trasformazioni che possono avvenire in entrambe le direzioni.
La nosografia funziona come un quadro di riferimento che risulta orientativo, e dunque di una qualche utilità, solo se viene adottato nella più ampia cornice fornita dal punto di vista strutturale e dialettico.
Riprenderemo ulteriormente questo discorso, che era però necessario anticipare prima di affrontare la struttura che, più visibilmente di tutte le altre, pone in luce i gradienti strutturali tra forme nevrotiche e forme psicotiche.
4. La struttura depressiva e maniacale
II conflitto tra Super-Io e bisogni alienati, che determina la scissione dell’Io, riconosce nella struttura depressiva e maniacale la sua espressione più trasparente in conseguenza di una fasicità che rende socialmente percettibile quella scissione. L’interesse di questa struttura sotto il profilo epistemologico è duplice. Per un verso, essa, infatti, attesta l’assoluta prevalenza dinamica del
Super-Io: benché la depressione investa, sia pure episodicamente, il 20% della popolazione adulta, è solo nello 0,5% che essa giunge ad attivare l’eccitamento maniacale. Considerare questo dato solo sotto il profilo clinico è errato per due motivi: primo, perché in ogni esperienza depressiva si può ricostruire il momento dinamico maniacale; secondo, poiché esistono forme fasiche depressive esclusivamente monopolari. Il dato statistico, dunque, attesta una straordinaria resistenza opposta dai soggetti, la cui integrazione sociale superegoica è tormentosa e mortificante, all’eccitamento maniacale, vissuto come rivendicazione di una libertà colpevole in quanto anarchica. Un secondo dato, atto a smascherare il sadismo superegoico, è fornito dal fatto che mentre l’eccitamento anche più intenso, pur rimuovendo ogni inibizione morale, non dà mai luogo a comportamenti criminali gravi, esaurendosi esso spesso nel fastidio alla quiete pubblica, nell’oscenità e nell’oltraggio, la depressione può esitare in una condanna a morte eseguita dal soggetto stesso. Per quanto possa apparire paradossale, la struttura maniacodepressiva è la prova più clamorosa contro la pretesa sfrenatezza della natura umana e viceversa la testimonianza più drammatica della sua predisposizione morale. Dato che si tratta di una struttura a gradiente, nel senso che è la depressione, giunta a certi livelli di profondità, ad attivare la mania, è giusto partire dalla prima, che è la causa, per giungere alla seconda, che è l’effetto. La specificità della struttura depressiva è denotata da varie caratteristiche. Anzitutto, come ha rilevato Freud, dalla severità del Super-Io, che in essa dispiega tutta la sua potenza colpevolizzante e mortificante. Mentre nella struttura ossessiva la minaccia superegoica produce la paura dell’esclusione sociale, e in quella isterica la condanna alla dipendenza e all’ assoggettamento relazionale, nella struttura depressiva essa si “vitalizza”. Nonché minaccioso e frustrante, il Super-Io appare impegnato in una progressiva azione mortificante e di affievolimento dei desideri e, parallelamente, di produzione di un dolore nel contempo viscerale e morale. L’effetto di questa azione è di evocare un senso di colpa di diversa intensità, che induce l’Io ad attaccare se stesso. L’autodenigrazione, che va da un sentimento generico di disvalore all’attribuzione a sé di colpe le più varie, pone in evidenza l’identificazione dell’Io con il Super-Io. Questo aspetto differenzia la struttura depressiva da tutte le altre, nelle quali l’Io riesce in qualche modo a difendersi e a mantenere una sia pur minima autonomia rispetto al Super-Io. Nella struttura depressiva viene meno ogni difesa: ancorchè discolparsi, l’Io denuncia la sua indegnità. Nelle forme gravi, nelle quali il parassitismo superegoico invade tutto il campo della coscienza, è il Super-Io che parla sotto le sembianze dell’Io: ciò rende possibile obiettivare i criteri di valore e la logica che esso adotta. Logica implacabile, secondo la quale esiste un ordine supremo, armonioso, integro, incorrotto contro cui l’uomo - quell’uomo con il suo corpo e la sua anima gravati di nequizie ha attentato e inquinato, e che va restaurato pertanto in virtù di una mortificazione adeguata. La seconda caratteristica della struttura depressiva, conseguente e complementare alla prima, è il bisogno di punizione. Nonché scongiurarla come l’ossessivo o rimuoverla come l’isterico, il depresso vive nell’aspettativa e nella convinzione assoluta che essa debba realizzarsi. Fino a certi livelli di depressione, egli, pur ritenendola giusta e inevitabile, la teme; al di là di questi, la desidera.
Il bisogno di punizione fa riferimento ad una immagine interna negativa la cui drammaticità è ad esso direttamente proporzionale. A differenza della struttura ossessiva, nella quale l’Io si sente parassitato da una mostruosità nella quale non si riconosce, e della struttura isterica nella quale l’Io frappone tra sé e l’identità negativa un velo di dubbio, che viene meno solo quando essa è agita come legittima difesa rispetto ad una temuta sopraffazione, nella struttura depressiva l’immagine interna negativa viene percepita come il vero Io, un Io indegno e colpevole. Questo vissuto, pur riconoscendo la stessa matrice dinamica, ha una configurazione diversa rispetto alle altre strutture. L’ossessivo vive nella paura che, non riuscendo a contenere le pulsioni che alberga, possa andare incontro ad una trasformazione mostruosa del suo essere; l’isterico, anche quando cambia identità, tende a giustificare la trasformazione; il depresso sente che dentro di lui nell’anima e/o nel corpo è avvenuta una trasformazione irreversibile e irreparabile, in conseguenza della quale ciò che era “sano” è divenuto “malato”. E’ questo il motivo per cui la depressione si associa sempre ad un vissuto di malattia in atto, che non esiste nell’ambito di alcuna altra esperienza psicopatologica.
Questo vissuto di malattia va dall’estremo dell’esaurimento delle energie e delle spinte motivazionali fisiche e psichiche in conseguenza delle quali il depresso si sente spento, finito, invecchiato all’estremo opposto della convinzione di un processo morboso maligno l’arteriosclerosi o la degenerazione cerebrale, un cancro, un’infezione, ecc. destinato a progredire irrimediabilmente.
Nelle depressioni più gravi il vissuto di malattia si specifica ulteriormente: il soggetto, anche senza alcun riferimento ad un processo morboso particolare, sente di essere marcio, degenerato, corrotto, preda ormai di una potenza negativa, il più spesso demoniaca, che pervade il suo essere e tende a conquistarlo. Sono questi i casi in cui il rischio che il soggetto “salvi” se stesso e gli altri suicidandosi è elevato. Ma sono anche i casi che rendono trasparente il sadismo paranoico del Super-Io, che vede nell’anima e/o nel corpo un ricettacolo e una fonte di nequizie.
Qual è, dunque, la colpa che viene imputata all’Io, e della quale questi si fa carico come se, avendola già commessa ed essendone stato trasformato, non rimanesse altro che pagarla? Non c’è alcun dubbio: è la rabbia, come conseguenza di una lunga e impercettibile frustrazione del bisogno di opposizione, che, raggiunto un limite critico, viene criminalizzata dal Super-Io, imputata e punita con la mortificazione. Ciò conferma che, prima che si definisca una struttura depressiva, deve esserci un’organizzazione della personalità di tipo ossessivo: è solo quando la rabbia non può più essere controllata dalla rigida dittatura superegoica, che essa si vitalizza e si ritorce contro il soggetto. La trasformazione, restituita dal vissuto di malattia proprio della depressione, è null’altro che un’incattivirsi giunto al limite critico al di là del quale esso potrebbe tradursi in comportamenti sociali distruttivi. L’intensità della rabbia inibita rende conto del fatto che i soggetti depressi si sentono per un verso disarmati, deboli, timorosi di ogni contatto relazionale, e per un altro nutrono un’intensa vergogna sociale, come se fossero divenuti trasparenti e tutti potessero leggere dentro di loro la vulnerabilità e la cattiveria.
E’ agevole ormai capire verso quale ideale dell’Io si orienta, per effetto della criminalizzazione superegoica, la struttura depressiva. E’ l’ideale di un Io innocente, inoffensivo, depurato di ogni maligno germe di distruttività: ideale che rievoca, e tenta di riabilitare il mito di un’armonia originaria, preesistente l’animarsi dell’opposizione, misconoscendo che essa si fondava su una condizione di totale impotenza del soggetto. Attribuendosi un istinto di morte, e rimuovendo dunque l’azione mortificante delle istituzioni, che il Super-Io perpetua all’interno della personalità, il depresso è indotto ad allearsi con questo e con il mito gerarchico. In conseguenza di ciò, egli si attribuisce delle colpe, sente di dover espiare la rabbia fino al punto di sciogliersi purificatoriamente dai lacci della distruttività per ricomporre un ordine compromesso. L’ideale dell’Io depressivo pone in luce la logica intrinseca al mito gerarchico, secondo la quale è l’essere inermi e imbelli dei subjecti il fondamento dell’armonia.
La pressione dei bisogni opponendosi alla mortificazione, la struttura depressiva può incrementarsi di continuo giungendo, talora, ad un bivio drammatico, tale che il soggetto o cede alla condanna superegoica suicidandosi o si ribella ad essa. La ribellione trasforma la struttura depressiva in struttura maniacale. Già si è fatto cenno ai motivi che permettono di assumere l’eccitamento maniacale come una clamorosa disconferma dello spietato sadismo superegoico: le colpe che, di fatto, commette il soggetto in stato di eccitamento, pur se giungono a configurarsi come reati, non sono mai tali da giustificare la condanna a morte sanzionata dal Super-Io. Ma c’è dell’altro.
Assumere l’eccitamento maniacale come prova dell’esistenza di pulsioni istintuali asociali e amorali è un errore epistemologico di enorme portata. Nonché di uno scatenamento pulsionale, infatti, l’eccitamento è l’espressione drammatica di una costrizione alla libertà che dà la misura della mortificazione che il soggetto ha subito o si è imposto. Con assoluta evidenza, l’eccitamento mira, piuttosto che a realizzare bisogni, ad infrangere delle regole: è il piacere, e la necessità, della trasgressione il leitmotiv dei comportamenti maniacali. Al fine che questo piacere si realizzi, occorre che i comportamenti abbiano un rilievo pubblico. Il venir meno di ogni ritegno e di ogni soggezione agli occhi degli altri pone in luce un altro obiettivo della struttura maniacale: la negazione della vergogna sociale. Da ciò si potrebbe ricavare che la ribellione maniacale al Super-Io riesce ad azzerare ogni senso di colpa. Ma non è così: ciò che affranca l’eccitamento maniacale da una sterile interpretazione istintualistica è la sua qualità essenzialmente angosciosa, il suo connotarsi come una ribellione che, nella misura in cui nega la colpa, postula e promuove la repressione. Metaforicamente, il modo avido con cui l’eccitato si abbandona al piacere è omologabile all’ultimo pasto del condannato a morte. In altri termini, la struttura maniacale mira a realizzare ciò che essa sembra scongiurare: l’impatto con un’autorità esterna che agisca la repressione. Ciò significa che essa, sia pure paradossalmente, rientra ancora nell’ambito del regime superegoico. Con inconfutabile evidenza, la ribellione alla dittatura interiore sollecita il soggetto a sfidare la struttura gerarchica sociale, e ad esasperare la sfida finché essa non incappa in una repressione che riabilita il primato del potere.
La genesi della struttura depressiva e maniacale è agevolmente riconducibile all’interazione con un ambiente repressivo nelle fasi evolutive dello sviluppo della personalità. A differenza degli ambienti che producono una struttura ossessiva in virtù di pretese eccessive che promuovono l’identificazione del soggetto con un modello iperadulto, e degli ambienti che incentivano una strutturazione isterica con l’imposizione di un modello angelicato e infantilizzante, negli ambienti che favoriscono una strutturazione depressiva prevale una strategia attivamente repressiva mirante a porre i soggetti al riparo dalle due più temibili devianze sociali: la criminalità per quanto riguarda gli uomini e il disordine sessuale per quanto riguarda le donne. La repressione determina un orientamento comportamentale mortificante, minacciato di continuo da un disordine orientato, paradossalmente, negli uomini verso la manifestazione di una rabbia incontrollata, e nelle donne verso la manifestazione di una sessualità incontrollata (provocatoria e rabbiosa essa stessa). La colpevolizzazione della rabbia, vissuta come espressione di distruttività, e la relativa facilità con cui la sessualità può essere liberata rende ragione della assoluta prevalenza statistica delle esperienze bipolari nelle donne.
Si è detto, all’inizio, che la struttura depressiva e maniacale è una struttura a gradiente. Volendo adottare una metafora di una certa efficacia si può pensare ad un vulcano spento nelle cui viscere si può presumere un serbatoio magmatico, pronto, se si realizzano certe condizioni, ad eruttare. La fenomenologia clinica della struttura maniacodepressiva si può ricavare da questa metafora, la cui utilità consiste, anzitutto, nel trascendere la sterile distinzione in forme reattive e forme endogene. La struttura è sempre la stessa: ciò che differenzia le esperienze soggettive è la quota dei bisogni frustrati e l’intensità della repressione superegoica.
Dal punto di vista dinamico, la polarità maniacale è sempre presente, poiché essa rappresenta il vero problema da risolvere, e cioè la quota dei bisogni che vanno recuperati, organizzati ed espressi perché la personalità si integri nel mondo su di un registro di calore e di partecipazione. Nelle forme più lievi, la depressione si presenta sotto forma di una più o meno vaga “neurastenia” che si associa costantemente all’irritabilità. Non si dà, a questo livello, alcun senso di colpa. Appartengono a questo ambito le depressioni “mascherate” il cui quadro clinico si riduce a sintomi, il più spesso dolorosi (cefalee, reumatismi, ecc) che rappresentano la punizione superegoica di piccoli “sismi” personali.
In alcuni casi, tipicamente legati all’adolescenza, quando la nuova attrezzatura psichica e fisica potrebbe permettere a fantasie di “scatenamento” a lungo covate di realizzarsi, la depressione si manifesta sotto forma di regressioni comportamentali, ritiro pessimistico dal mondo, vaghe paure ipocondriache, mortificazioni ascetiche, ecc.
Le cosiddette forme attive, che possono insorgere a qualunque età, sono in rapporto o con situazioni di vita costrittive e frustranti o con eventi deludenti e luttuosi. Nel primo caso, esse vanno ricondotte ad una rabbia crescente che viene inibita e sanzionata dal Super-Io; nel secondo, invece, fanno affiorare i sensi di colpa per una “cattiveria” latente in rapporto alla quale le delusioni e i lutti si configurano come giuste punizioni.
Quando la depressione si approfondisce, affiorano regolarmente l’autodenigrazione e un vissuto di colpa spesso poco sistematizzato. La pressione dei bisogni alienati, in questi casi, è restituita costantemente da un’angoscia viscerale che aggrovigliata nell’addome tende spesso ad irradiarsi eruttivamente verso la testa.
La sistematizzazione del senso di colpa, che si traduce in un’autoaccusa sempre più spietata e giunge infine a configurarsi come sentimento di totale corruzione psichica e fisica, segue la discesa del depresso nel buio cratere del suo mondo interiore fino al fondo, ove egli si imbatte in due estreme possibilità: o l’accettazione definitiva di un gelo mortale, che toglie senso all’esistenza, o lo sprigionarsi della maniacalità. Quando si realizza questa seconda possibilità, la depressione viene repentinamente sostituita da uno stato di benessere esaltante.
Di fatto, perlomeno al suo esordio, l’eccitamento maniacale mima una vita vissuta secondo la misura della ricchezza dei bisogni umani. La costrizione alla libertà, che esprime il grado di mortificazione che il depresso ha subito o si è imposto, obbliga però il soggetto a rilanciare sempre più la sua sfida al Super-Io e alle istituzioni sociali, nelle quali egli vede riflettersi le norme, le regole e i valori che lo hanno mortificato, finché egli si imbatte nella repressione sociale o nel senso di colpa.
5. La struttura delirante
La struttura ossessiva, quella isterica e quella depressiva possono esprimersi in maniera meramente sintomatica. Questa modalità fenomenologica configura un primo livello clinico, tradizionalmente definito nevrotico. A questo livello i sintomi appaiono avulsi dal tragitto di esperienza individuale e non organizzati ideologicamente, fatta eccezione per il vissuto di malattia che, per altro, può essere assente. In pratica, i soggetti vivono e subiscono i sintomi in maniera estremamente drammatica. L’analisi delle strutture porta a pensare che ciascuna di esse implichi una visione del mondo interno e di quello esterno, e, soprattutto, dei rapporti possibili tra i due mondi, suddivisi in due categorie: quelli temuti come minacce alla libertà personale e/o all’appartenenza sociale, e quelli auspicati come soluzioni ottimali del conflitto tra individuazione e integrazione sociale. Questi ultimi, che rappresentano progetti, il più spesso latenti, di guarigione, sono animati come si è visto da un ideale dell’Io e da un sistema di valori astratti, poiché prescindono dalla concreta esperienza microstorica del soggetto, dalla configurazione alienata dei bisogni e dagli ambienti cui il soggetto è vincolato. In un certo senso, fondandosi su convinzioni “viscerali” assolute, ricavate dall’esperienza reale ma generalizzate sotto forma di visione del mondo interno ed esterno, ogni struttura può essere definita come delirante. Ma è pur vero che, al primo livello, e cioè a livello di fenomenologia nevrotica, nulla o quasi nulla traspare della visione del mondo.
Si è anche detto, sommariamente, che ogni struttura, in rapporto alla sua dinamica intrinseca e ovviamente alle circostanze ambientali (aspetto - questo - su cui ci soffermeremo ulteriormente), ha delle potenzialità evolutive che sconfinano dal primo livello sia nella direzione di una risoluzione spontanea, e cioè di una normalizzazione, sia nella direzione di una progressiva intensificazione del conflitto strutturale, che non può più essere contenuto entro i confini della fenomenologia nevrotica.
Ciò che accade, in questi casi, è di grande interesse.
Le polarità conflittuali, non più contenibili, tendono a dissociarsi e ad esprimersi con modalità fenomenologiche apparentemente opposte. Benché non consapevolmente, dato che il conflitto strutturale si presenta in termini adialettici, il soggetto è costretto ad allearsi con una delle polarità conflittuali. Di conseguenza, egli deve giustificare in qualche modo questa alleanza, che determina il suo rapporto con il mondo interno ed esterno; deve, in altri termini, ideologizzare il suo modo di essere e di porsi nel mondo. Ciò che è implicito al primo livello fenomenologico, si esplicita. La struttura delirante rappresenta, per l’appunto, lo smascheramento delle convinzioni soggettive della ideologia implicita nella struttura ossessiva e nelle varianti. Ciò non significa, ovviamente, che l’esperienza delirante debba essere preceduta da un’esperienza nevrotica; la struttura ossessiva, isterica e depressiva possono, infatti, mantenersi latenti ed esprimersi fenomenologicamente solo, ed immediatamente, su un registro delirante. Ma, dal nostro punto di vista, non si dà la possibilità di un’esperienza delirante senza che essa riconosca un periodo di “incubazione” legato ad una struttura di personalità conflittuale.
Al di là del primo livello, tutto l’universo psicopatologico è, più o meno manifestamente, delirante. Si possono distinguere due ulteriori livelli: un secondo, caratterizzato da fenomenologie complesse i cui nessi con le strutture psicopatologiche originarie appaiono, in una certa misura, riconoscibili; un terzo, infine, la cui fenomenologia rende quei nessi poco o punto riconoscibili.
In rapporto al secondo livello si parla solitamente di “psicosi’ ossessiva, isterica, depressiva, maniacale; il terzo livello è invece definito tradizionalmente schizofrenico (compresi gli stati misti, dissociativi e distimici).
E’ inutile sottolineare che il linguaggio psichiatrico è impregnato di valenze semantiche pregiudiziali. Un giorno, indubbiamente, qualcuno dovrà assumersi l’impegno di un radicale rinnovamento linguistico. Dato che a noi, per ora, interessa maggiormente rinnovare paradigmi culturali, trascureremo questo problema.
Cercheremo solo di visualizzare con uno schema i rapporti tra i diversi livelli strutturali psicopatologici, utilizzando dei termini descrittivi atti a definire, per ogni struttura, la scissione tra le polarità conflittuali e le linee evolutive che da essa discendono.
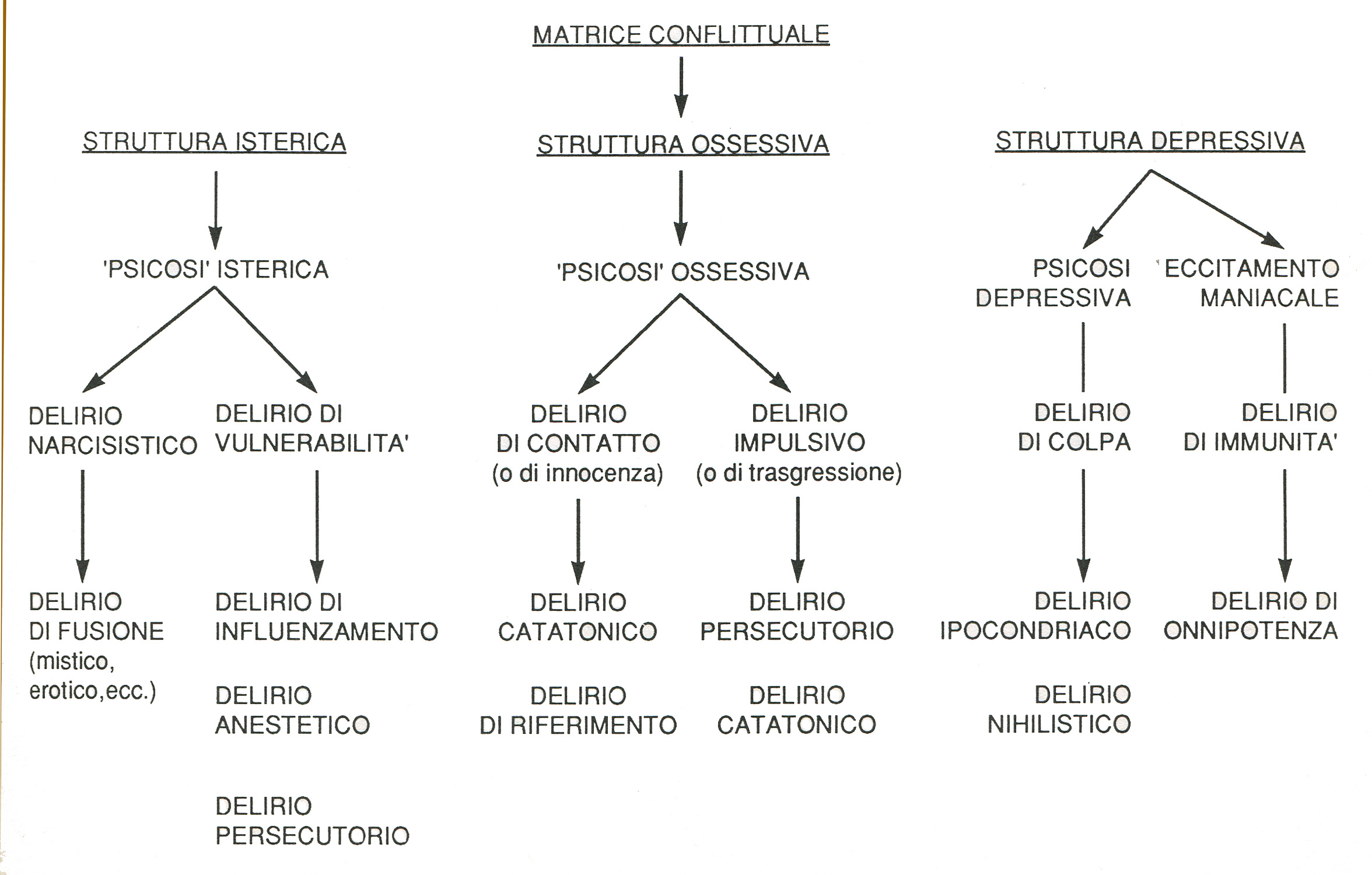
Lo schema, ovviamente, non pretende di essere esauriente. Esso suggerisce solo il fitto intreccio che struttura l’universo psicopatologico, la cui complessità, frustrando ogni tentativo nosografico, restituisce i vari modi in cui si declina il conflitto tra Super-Io e ideale dell’Io da una parte e bisogni alienati dall’altra.
È evidente che nel passaggio dal primo al secondo livello avviene una scissione tra le polarità conflittuali, ciascuna delle quali tende ad organizzarsi autonomamente, chiudendo il soggetto in un modo di essere e di porsi nel mondo adialettico. Nel passaggio dal secondo al terzo livello, la scissione si radicalizza, giungendo alle estreme conseguenze.
Tenteremo ora, sinteticamente, di analizzare le singole linee evolutive.
La psicosi isterica può evolvere nella direzione di un mascheramento narcisistico sempre più marcato o, viceversa, nella direzione di una drammatica trasparenza al mondo.
Il delirio narcisistico comporta la convinzione del soggetto di possedere qualità, sia psichiche che fisiche, straordinarie. Si tratta di un delirio di onnipotenza, la cui derivazione dalla struttura isterica è attestata dal comportamento solitamente passivo e dalla tendenza al rimando e all’attesa.
Il soggetto sa di valere, e pertanto non ha alcun bisogno di impegnarsi nella vita reale, nello studio, nel lavoro, nelle esperienze affettive. Egli è convinto che il suo solo apparire non può non indurre un riconoscimento immediato della sua eccellenza. Se tale convinzione investe la sfera privata, essa si traduce in un delirio di seduzione: non appena si mostra agli altri, il soggetto è gratificato da sguardi, gesti e parole che attestano inconfutabilmente un’avvenuta conquista. Se, invece, la condizione investe la sfera pubblica del successo sociale, il soggetto vive, apparentemente senza sofferenza, nell’attesa di un’occasione che permetta al mondo di conoscere il suo valore estetico, artistico, scientifico, politico, ecc. e di piegarsi ad esso.
In ogni caso, il delirio narcisistico esclude il confronto, la lotta, la competizione, il conflitto, la sopraffazione. Il dramma del Padrone e del Servo, che sottende la struttura isterica, è risolto, per effetto di un’ideologia che nega il conflitto, in nome di una naturale tendenza degli esseri umani a riconoscere una “oggettiva” gerarchia di valori. Ma ciò lascia intendere, con chiarezza, la trappola dinamica nella quale è irretito il soggetto, chiamato a realizzare un ideale dell’Io eccelso e, nel contempo, inibito dal manifestare una qualunque attività che potrebbe dar luogo ad un conflitto con il mondo. Il delirio narcisistico, pertanto, è meno l’espressione di sterili fantasie di onnipotenza che non di una radicale impotenza a far presa sulla vita dovuta all’inibizione del bisogno di opposizione e alla paura del conflitto. Tenuto conto di ciò, non sorprende che il delirio narcisistico, la cui economia si regge sulla capacità soggettiva di compensare con autoinganni gratificanti una condizione drammatica di frustrazione reale, possa esitare in un delirio di onnipotenza fusionale delirio di amore, mistico, politico, ecc. La fusione e l’identificazione con un altro essere dotato di qualità straordinarie realizza, infatti, l’ideale di un’armonia totale che esclude ogni conflitto e offre al mondo la prova di un’eccellenza che non potrà non essere riconosciuta.
Ma è a questo livello che, mancando l’atteso riconoscimento, può avviarsi una vera e propria guerra con il mondo, e affiorare un bisogno di opposizione alienato, che mira ad assoggettare il mondo anziché ad affrancare il soggetto dalla devozione ad uno sterile ideale dell’Io. L’inibizione del bisogno di opposizione che, essendosi trasformato in rabbia distruttiva, viene rimosso in conseguenza della minaccia di esclusione sociale che su di esso incombe, è all’origine dell’altra fenomenologia con cui si esprime la “psicosi” isterica: il delirio di vulnerabilità.
In conseguenza di questa rimozione, il soggetto giunge a viversi come un bambino inerme e disarmato in balia di un mondo capace di decifrare immediatamente questa sua condizione e, quindi, di approfittarne. A differenza del delirio narcisistico, che promuove una tendenza, più o meno marcata, all’esibizione passiva di sé agli occhi del mondo, il delirio di vulnerabilità determina invece la tendenza opposta a rifuggire da tutte le situazioni di esposizione relazionale. Il soggetto si sente letteralmente trasparente nella sua inadeguatezza e nella sua radicale impotenza e, dato che egli riconosce la legge del più forte come unico principio che governa le relazioni tra gli esseri umani, vive questa condizione come esposta a tutti i possibili attacchi da parte di coloro che sono forti. La vulnerabilità, che il soggetto sente come definizione ontologica del suo essere, è in realtà una categoria relazionale: categoria appresa per esperienza diretta, e rinforzata da quanto accade nel mondo che la conferma.
Il delirio di vulnerabilità, che muove da una struttura isterica, impone, pertanto, al soggetto di organizzare una vita che, premunendola da ogni esposizione relazionale, soddisfi il bisogno incessante di conferma che egli ha. Questo spiega la tendenza a rifuggire progressivamente da ogni forma di socialità entro spazi familiari e domestici. Ma, il più spesso, sono proprio questi gli spazi relazionali che, inibendo l’opposizione, hanno reso il soggetto vulnerabile. In essi, dunque, il conflitto tra dipendenza e vulnerabilità si ripropone, e si apre a due sole possibili soluzioni: o il soggetto, per frustrare la sua rabbia distruttiva, regredisce in una condizione di totale infantilismo, rivendicando passivamente il ruolo dal quale non gli è stato consentito di uscire; o, viceversa, egli tende ad agire quella rabbia, istaurando una tirannia vendicativa che tende a compensare l’impossibilità di aprirsi al mondo.
In ambedue i casi, è comunque la categoria dinamica del Padrone e del Servo ad imporsi, svelando una visione del mondo senza scampo. Gli equilibri precari che si realizzano a questo livello non possono, ovviamente, per il difetto di vita che essi comportano, durare all’infinito. Ciò determina la possibilità di un passaggio al terzo livello, che può avvenire secondo due diverse modalità. Se prevale il Super-Io punitivo che mira a far pagare al soggetto la colpa di essersi ribellato ad una relazione armoniosa che lo manipolava ma a fin di bene, può insorgere un delirio di influenzamento.
Nonostante il ritiro dalla socialità, il soggetto sente che la sua mente è senza difese, tale che gli altri possono influenzarla, imponendogli dei sentimenti, dei pensieri, delle volontà; o violarla, rubandogli i contenuti mentali e non lasciandogli alcuna intimità.
In altre circostanze, è un ideale dell’Io anestetico a prevalere. Identificandosi con esso, il soggetto si affranca dalla vulnerabilità poiché rimuove del tutto la sensibilità, divenendo freddo, duro e inscalfibile. Questa condizione può coincidere sia con un’ulteriore regressione (sono i casi che un tempo davano luogo alla diagnosi di “ebefrenia”), sia con un sorprendente recupero della socialità. In questo secondo caso, nonostante il soggetto possa manifestare una sicurezza beffarda, è facile che egli sviluppi un delirio persecutorio, poiché è sollecitato a interpretare gli atteggiamenti degli altri nei suoi confronti come orientati a sopraffarlo.
La sensibilità, tipicamente isterica, nei confronti di ogni sopraffazione può indurre con una certa facilità reazioni sociali aggressive, cui il soggetto si abbandona sicuro di non esercitare altro che un suo giusto diritto, e delle quali l’anestesia affettiva gli impedisce di valutare le conseguenze.
La psicosi ossessiva può evolvere in due direzioni: nella direzione di un ipercontrollo comportamentale che può giungere ad investire di significati fobici qualsivoglia contatto con il mondo esterno; e nella direzione di una libertà impulsiva che sembra votare il soggetto alla emarginazione sociale. II delirio di contatto che noi assumiamo in un’accezione più vasta rispetto alla psichiatria tradizionale, che riconosce “le délir de toucher” muove dalla convinzione soggettiva di poter mantenere la propria integrità, fisica ma soprattutto psichica, solo a patto di evitare rapporti diretti, intimi e coinvolgenti con il mondo. Risulta immediatamente evidente che il delirio di contatto implica la percezione di un’estrema vulnerabilità, ma, a differenza di quanto accade nel delirio di vulnerabilità isterico, nel delirio di contatto, anziché un sentimento di inadeguatezza e di inermità, prevale un vissuto di assoluta Super-Iorità, morale e intellettuale, rispetto ad un mondo inquinato da bassezze, disordini, volgarità e impulsi bestiali.
Se il delirio di vulnerabilità isterico si anima sul registro del rapporto di potere tra gli esseri umani, e non riconosce altra categoria che quella del Padrone e del Servo, il delirio di contatto prescinde del tutto da questa categoria, articolandosi su di una visione del mondo che distingue, nella personalità non meno che nel mondo, un alto e basso: ciò che è alto nobilita, spiritualizza, umanizza e rende integri: ciò che è in basso involgarisce, materializza, imbestialisce e corrompe. In virtù di questa scissione non dialettica, il delirio di contatto orienta il soggetto a rimanere al di sopra e al di fuori del mondo, e a temere ogni contatto con quanto potrebbe trascinarlo in basso. Da questo punto di vista, non sembra inopportuno parlare di un delirio di innocenza, essendo il soggetto impegnato a dar prova continuamente della sua totale estraneità ad un mondo colpevole e corrotto.
E’ ovvio che il giudice al quale il soggetto deve dar conto della sua innocenza è il Super-Io, le cui pretese impongono una severa frustrazione delle pulsioni la rabbia e la sessualità, in particolare che il soggetto giunge a misconoscere. Ed è altrettanto chiaro che le pretese del Super-Io agiscono in virtù della suggestione di un ideale dell’Io elevato, l’identificazione con il quale assegna il soggetto a un rango “nobiliare”. Ma non si fa fatica a comprendere che questa identificazione, per la sua astrattezza, non può che essere stata imposta. In effetti, essa, il più spesso, corrisponde all’introiezione di aspettative familiari che privilegiano l’ascesa sociale, sia sotto il profilo economico che spirituale, e in ordine a ciò mirano, nelle fasi evolutive della personalità, a depurare la natura umana dagli aspetti che potrebbero fuorviarla, orientandola verso la degradazione.
Il delirio di contatto impone al soggetto, a qualunque costo, di tener fede a quelle aspettative, di serbare intatta un’innocenza originaria, calandosi e cristallizzandosi in un ruolo iperadulto immune da ogni squilibrio emozionale, affrancato da ogni rozzo bisogno istintuale, intollerante, infine, di ogni contatto e di ogni investimento in un mondo contaminato e sconvolto da cieche pulsioni.
E’ evidente la differenza tra il primo e il secondo livello ossessivo: la “nevrosi” implica una drammatica percezione di pulsioni asociali e amorali contro di sé. Percezione che induce l’ossessivo a sentirsi potenzialmente un “mostro” in un universo sociale che, ai suoi occhi, appare normale. Con il passaggio al secondo livello, la visione del mondo si rovescia: il soggetto giunge a viversi come l’unico individuo integro e umano in un mondo degradato a livelli bestiali.
Nonostante le gratificazioni ricavate dall’identificazione con un ideale dell’Io innocente, gli equilibri assicurati dal delirio di contatto, postulando la frustrazione di ogni autentico investimento nel mondo, sono precari. Muovono da ciò due possibilità evolutive in direzione del terzo livello. La prima si realizza sotto forma di blocco “catatonico”: per mantenere la sua innocenza, il soggetto è costretto a sospendere i residui contatti che egli intrattiene con il mondo esterno, ad isolarsi in casa, ad allettarsi e a rifiutare ogni scambio con l’ambiente. Tentando di impietrirsi, pur di non cedere alle pulsioni, egli paga l’estremo tributo ad una sterile visione del mondo.
L’ altra possibilità evolutiva è che la maschera di innocenza venga imputata, dall’esterno, come una falsificazione, e che si avvii dunque un delirio di riferimento che può giungere a configurarsi in termini persecutori. Il soggetto, che mantiene una coscienza di sé innocente, si trova a vivere in un mondo che si anima di sospetti, di doppi sensi, di calunnie e, infine, di esplicite accuse. L’asocialità e l’amoralità del suo mondo interiore, che è la convinzione da cui muove la struttura ossessiva, vengono denunciate dall’esterno; e il soggetto, che ha sacrificato la sua vita per affrancarsene, frustrando i suoi bisogni vitali, non può che sentirsi ingiustamente offeso e perseguitato e, talora, giungere a reagire in maniera violenta per confermare la sua innocenza.
La “psicosi” ossessiva può organizzarsi in tutt’altro modo rispetto al delirio di innocenza. Dopo aver accettato, il più spesso per anni, di vivere sotto la dittatura superegoica, il soggetto, con l’intento di liberarsene, può avviare una catastrofica rivoluzione: cominciare a trasgredire impulsivamente regole sociali e valori morali per protestare la sua libertà e incoercibilità. Questo momento dinamico è identico a quello che sottende le esperienze maniacali. Ma la fenomenologia del delirio impulsivo si differenzia da queste per un elemento specifico: laddove l’eccitamento maniacale esprime una vitalità autentica che solo per la sua incontenibilità può, e di fatto, al di là di un certo limite, tende a scatenare un conflitto con la società, il delirio impulsivo si connota d’emblèe come una drammatica sfida all’autorità.
Nell’eccitamento maniacale, la trasgressione è un fine secondario rispetto al bisogno di vivere in un regime affrancato dai sensi di colpa; nel delirio impulsivo viceversa è un fine primario, che impone di commettere delle colpe per affermare i diritti di una libertà volutamente ribelle nei confronti di ogni costrizione.
La fenomenologia clinica del delirio impulsivo è straordinariamente vana, poiché indefiniti sono i possibili comportamenti “antisociali”. La distinzione più importante, per quanto generica, che si può fare riguarda i bersagli contro cui sono orientati quei comportamenti.
Talora il bersaglio è la famiglia: in questi casi, il soggetto può attaccare direttamente i suoi, deludere le loro aspettative abbandonandosi all’inerzia e al parassitismo, rubare beni familiari, comportarsi in maniera provocatoriamente offensiva nei confronti dei valori parentali, fuggire di casa e destinarsi al vagabondaggio, ecc. Talaltra, il bersaglio è manifestatamente la società e l’autorità riconosciuta: in questi casi i comportamenti asociali configurano dei reati, di rilievo minore o maggiore, orientati a sfidare le forze dell’ordine e a giungere ad un conflitto con esse. In questo ambito rientrano anche alcune esperienze di tossicodipendenza e di estremismo politico.
Se il delirio impulsivo non esita in una repressione sociale giudiziaria o psichiatrica è destinato ad evolvere, inesorabilmente, in un terzo livello, caratterizzato da un delirio persecutorio. Questo delirio può essere generico, e cioè riferirsi alla società da cui il soggetto si sente emarginato o minacciato.
Ma il più spesso si tratta di un delirio sistematizzato, che ha come oggetto la persecuzione da parte delle forze dell’ordine. Può anche accadere, benché più di rado, che il soggetto, oppresso dalla paura di una perdita completa della libertà come conseguenza dei suoi comportamenti antisociali, giunga a bloccarsi in un delirio catatonico, che, paradossalmente, lo pone in balia della volontà di altri. La struttura depressiva, che comporta un continuum dal primo al terzo livello, è stata già analizzata in via generale nelle sue potenzialità evolutive. Occorrerà dunque aggiungere solo alcune specificazioni.
La “psicosi” depressiva coincide, praticamente, con un delirio di colpa, sia esso attestato dall’implacabile severità con cui il soggetto si rivolge delle accuse, sia esso “visceralizzato” e cioè vissuto come aspettiva inconsapevole di una giusta, per quanto temuta, punizione. Queste due modalità di colpevolizzazione, incrementandosi, permettono di comprendere la fenomenologia del terzo livello: la “visceralizzazione” del senso di colpa porta infatti al delirio ipocondriaco, le autoaccuse al delirio nihilistico. Il delirio ipocondriaco si fonda sulla convinzione assoluta di albergare un male incurabile. Il soggetto di conseguenza tende ad anticipare, con il suicidio, una condanna a morte già in atto nel suo corpo, e, talora, a mettere gli altri al riparo da una possibile diffusione del male.
Il delirio nihilistico rappresenta l’espressione, forse, più drammatica dell’ordine entropico imposto dal Super-Io; il soggetto sente morto e in via di putrefazione il proprio corpo, annichilita la sua anima, spento l’universo intero, scomparso nel nulla Dio stesso.
L’eccitamento maniacale coincide, infine, con un delirio di immunità. Il soggetto appare affrancato da ogni umana debolezza e da ogni vincolo fisiologico: può fare a meno del cibo, astenersi dal sonno, esporsi impunemente al caldo e al freddo, sottoporsi a sforzi fisici straordinari, affrontare senza timore ogni situazione di rischio.
Questo scatenamento di vitalità è assolutamente reale. Ma è chiaro che esso crea i presupposti per l’affiorare di un delirio di onnipotenza: il soggetto sente allora di non dover riconoscere alcun limite, né personale fisico e psichico né morale, né sociale. E’ a questo livello che il delirio di onnipotenza giunge a coincidere con un delirio di trasgressione, e si apre alla possibilità di una repressione dall’esterno.
Capitolo settimo
Ideologie sociali, codici di normalizzazione e psicopatologia
La psichiatria transculturale, nonostante la relativa imprecisione dei criteri diagnostici da cui ricava il materiale su cui esercita un’analisi comparata, ha reso sufficientemente attendibile l’ipotesi che le forme di esperienza psicopatologica godano di una relativa uniformità nello spazio e nel tempo. L’universalità dei fenomeni psicopatologici, soprattutto per quanto concerne le psicosi, viene però troppo superficialmente adottata come prova di una predisposizione genetica alle malattie mentali. E’ evidente che, dal nostro punto di vista, si può fornire una diversa interpretazione dei dati acquisiti dalla psichiatria transculturale. Essendo universale la predisposizione sociale della natura umana (con la forma a priori superegoica attraverso cui essa si esprime), è chiaro che ovunque nel tempo e nello spazio si animi un conflitto tra cultura del gruppo di appartenenza e bisogno di opposizione/individuazione, possa prodursi una scissione dell’Io e, di conseguenza, una strutturazione psicopatologica. Il punto di vista formal-genetico strutturalista è, dunque, alternativo rispetto a quello organicista, e, in una certa misura, lo comprende senza correre il rischio del riduzionismo. Esso, però, come si è già accennato più volte, risulta sterile se non viene integrato dialetticamente, e cioè se non si tiene conto che, nella realtà, le forme psicopatologiche, la cui universalità è da ricondurre ad una matrice conflittuale costante, veicolano contenuti culturali sociostoricamente determinati.
Formalmente, un rituale ossessivo esprime sempre la necessità soggettiva di tenere sotto controllo un mondo di emozioni fluttuanti vissuto superegoicamente come minacciante l’identità personale e sociale. Ma un rituale di abluzione, che oppone alla torbida corrente degli istinti la purezza di fluidi come l’acqua, l’alcol, ecc. esterni al corpo, è incomprensibile se non si tiene conto di come, all’interno di un determinato contesto culturale, la storia sociale ha ideologizzato la categoria dello sporco e del pulito e il parallelismo tra anima e corpo.
L’attenzione ai contenuti culturali, che storicizzano le forme psicopatologiche, fa della psicopatologia dialettica uno strumento privilegiato di indagine sulle ideologie sociali e su come esse si rifrangono, attraverso la mediazione del gruppo di appartenenza, a livello soggettivo. Tale indagine è importante sotto il profilo pratico non meno che teorico. Per un verso, infatti, essa, permettendo di oggettivare i sistemi di valore superegoici e gli effetti alienanti che producono quando vengono ad urtare contro un’opposizione, offre ai soggetti disagiati la possibilità di avviare un processo di soppressione dialettica, e cioè di liberazione e integrazione dell’Io; per un altro, consente, sul piano di una psicopatologia dinamica, di mettere a fuoco i codici mentali di normalizzazione che organizzano e danno coerenza alla struttura sociale e i motivi “locali”, legati a particolari situazioni di intenzione con l’ambiente, per cui quei codici falliscono nella loro finalità.
Il significato terapeutico di questa metodologia e la possibilità di una sua concreta realizzazione saranno esposte e discusse ampiamente in un saggio successivo. Per quanto riguarda l’aspetto teorico, è giusto rilevare che esso, negli ultimi due decenni in particolare, è al centro delle riflessioni che muovono dalla pratica della terapia familiare, ma che il focalizzarsi della ricerca sui modelli di comunicazione intrasistemica ha impedito sinora l’analisi dei codici mentali, prodotti dalla storia sociale, che irretiscono i membri familiari in una comunicazione che è patologica non perché non permette di mettere in discussione le regole su cui si fonda, bensì perché non consente di oggettivare e di sopprimere dialetticamente quei codici in ciò che essi hanno di alienante.
E’ universalmente riconosciuto che non si dà comunicazione, e quindi neppure strutturazione di una personalità dotata di soggettività e di capacità relazionale, senza significazione.
Ciononostante, da parte dei teorici della comunicazione sistemica, il problema dei codici di significazione è messo tra parentesi. E’ chiaro che ciò consente di neutralizzare la teoria in ciò che essa ha di potenzialmente dialettico, e che postulerebbe un atteggiamento critico nei confronti dei bisogni dell’organizzazione sociale, miranti ad assicurare, a qualunque prezzo, la sua armonia. La descrizione fenomenologica e dinamica che abbiamo fornito delle strutture psicopatologiche impone di porre maggiore attenzione a questo problema.
In ogni struttura psicopatologica, infatti, si possono individuare tre diversi sistemi di significazione correlati: le convinzioni del soggetto riguardo al suo essere profondo, ricavate dalla fenomenologia dei bisogni alienati e restituiti dalla immagine interna; i valori, le norme, le regole che rappresentano il quadro di riferimento utilizzato dal Super-Io per giudicare il soggetto dal livello del comportamento a quello delle fantasie; gli ideali dell’lo, che configurano i modelli di normalità verso i quali i soggetti si orientano vedendo in essi una possibile soluzione del conflitto strutturale tra Super-Io e bisogni alienati.
Tutti e tre questi sistemi di significazione sono appresi. II primo muove dalla percezione destorificata dei bisogni alienati la cui fenomenologia accredita soggettivamente la teoria degli “istinti”, che, ancora oggi, a livello di mentalità non meno che di ideologie scientifiche, rappresenta il quadro mentale dominante sulla natura umana. Questa significazione viene rinforzata progressivamente dalla pressione dei bisogni frustrati, che a livello profondo si intensificano e si disordinano.
Il secondo sistema di significazione è dato dal codice di norme, regole e valori introiettato nelle fasi evolutive della personalità in conseguenza della identificazione con gli adulti.
Questo codice, il più spesso eterogeneo, produce l’alienazione dei bisogni, in conseguenza di una colpevolizzazione del bisogno di opposizione che viene significato in termini di tradimento rispetto al gruppo di appartenenza e, in senso lato, di asocialità e amoralità. Tale alienazione attiva la forma superegoica a priori, con i contenuti specifici ricavati dall’introiezione dei valori trasmessi culturalmente, e dà luogo dunque allo strutturarsi di un Super-Io su un registro di severità che può apparire incommensurabile rispetto alle matrici ambientali.
Gli ideali dell’Io rappresentano il sistema di significazione più complesso. La loro connotazione, spesso dereistica, può facilmente indurre a pensare che si tratti di prodotti meramente soggettivi, residui di precoci identificazioni immaginarie o espressioni di sterili fantasie. Ma, intanto, quand’anche si tratti di identificazioni immaginarie, è sempre possibile ricondurle a pretese o aspettative ambientali che irretiscono il soggetto. In secondo luogo, le soluzioni offerte dagli ideali dell’Io al conflitto strutturale, nonostante il fascino che esercitano sul soggetto, mortificano il corredo dei bisogni umani, poiché promuovono la realizzazione dell’uno integrazione sociale o l’individuazione al prezzo della frustrazione dell’altro. Ciò permette di comprendere perché esse non solo non si realizzano, ma producono un effetto paradossale: più il soggetto si impegna a perseguirle, più il bisogno frustrato si attiva, esercitando una pressione destrutturante.
Gli ideali dell’Io, in altri termini, esercitano sui soggetti un’attrazione direttamente proporzionale all’opposizione che suscitano. Opposizione inconsapevole, ma nondimeno insormontabile.
L’esempio più chiaro a riguardo è fornito dalla struttura ossessiva: per quanto minacciato dalle pulsioni asociali e amorali e risucchiato da un modello di assoluto controllo relazionale sulle emozioni, l’Io tende a mantenere, in rapporto alle polarità conflittuali, una posizione il più possibile statica e simmetrica. A livello fenomenologico, esso sembra rifuggire fobicamente dalle pulsioni, ma, identificando in esse la libertà, si oppone strenuamente alla cattura della normalità, che rimane nulla più che una maschera. Ciò impone di introdurre a livello teorico, riguardo agli ideali dell’Io, una distinzione complementare a quella enunciata tra Super-Io e coscienza morale critica. Da questo punto di vista, gli ideali dell’Io psicopatologici sarebbero ideali superegoici, ideali cioè che fanno capo a sistemi di valori propri del mito gerarchico nelle sue diverse versioni, e si impongono all’Io come miraggi di normalità. Occorre ammettere pertanto che essi funzionano all’interno di strutture che non manifestano alcun disagio psichico, poiché ad essi si conformano. Nelle esperienze psicopatologiche, invece, la cattura ideologica esercitata dagli ideali dell’Io sarebbe ostacolata e vanificata da un irriducibile opposizionismo, dovuto alla pressione dei bisogni frustrati.
Agli ideali superegoici impropriamente, dunque, definiti ideali dell’Io, in quanto essi sono riconosciuti solo dalla parte scissa dell’Io che si identifica con il Super-Io occorrerebbe contrappone gli ideali critici dell’Io, che possono essere formulati solo in virtù di una soppressione dialettica dell’alienazione dei bisogni e della scissione dell’lo.
Se ciò è vero, gli ideali superegoici, nella misura in cui si amplificano e diventano osservabili all’interno delle strutture psicopatologiche, rappresenterebbero una spia preziosa dei sistemi di valori che sottendono il mito gerarchico, e, in ultima analisi, un valido strumento di decrittazione della storia e della evoluzione dei “recinti” mentali entro i quali il mito gerarchico tenta di ingabbiare le coscienze.
L’impresa, dati i limiti della nostra competenza, appare tutt’altro che facile. Seguiremo, pertanto, l’itinerario più agevole: tenteremo di estrapolare dalle strutture psicopatologiche gli ideali superegoici, di definire i codici culturali cui essi fanno riferimento e, da ultimo, di correlare questi codici alle ideologie sociali attive nel contesto della nostra civiltà. Deve essere chiaro fin da ora che il nostro intento criticabile ma non equivocabile non consiste nel dimostrare che le esperienze psicopatologiche riflettono, distorcendoli, i sistemi di valori del contesto in cui essi si realizzano. Nessuno pone in dubbio, ormai, che gli uomini siano figli del loro tempo. Ciò che intendiamo dimostrare è che le esperienze psicopatologiche, con gli ideali superegoici che le governano, denunciano la logica profonda di quei sistemi di valori: la logica del mito gerarchico che, frustrando i bisogni umani e ponendoli irriducibilmente in conflitto, li orienta verso modelli astratti di normalità, la cui funzione è di sancire l’armonia sociale al prezzo dell’alienazione.
Ogni struttura psicopatologica si articola su di una visione del mondo interno ed esterno incentrata su di un codice di ordine generale che distingue, nella natura umana, nelle relazioni interpersonali e nella società, un “alto” e un “basso”. La pressione dei miti gerarchici l’uno di matrice religiosa, l’altro laicoliberale è restituita immediatamente alla connotazione dell’alto in termini spirituali di perfezione morale e intellettuale , o in termini sociali di potenza e di prestigio. Ogni struttura può configurarsi come tributaria dell’una o dell’altra connotazione.
Se la struttura ossessiva riconosce una matrice religiosa, la normalità cui essa fa riferimento giunge a coincidere con la virtù, la moralità, l’ascetismo; quando la matrice, altresì, è liberale, la normalità corrisponde ad un modello di rispettabilità conformistica. Nel primo caso, l’ossessivo tende costantemente a differenziarsi dagli altri, esibendo una Super-Iorità aristocratica che non lo espone ad alcuna rappresaglia; nel secondo, viceversa, egli aspira soprattutto all’anonimato, a non dare nell’occhio.
La struttura isterica di matrice religiosa comporta l’ostentazione di un’innocenza angelica e vagamente infantile che suscita l’ammirazione e la tenerezza; se di matrice liberale, essa invece si esprime in una disinvolta e fredda sicurezza, animata da una costante intenzione seduttiva che tende ad irretire esseri deboli. Nel primo caso viene esibita la vulnerabilità come indice di virtù, nel secondo viene ostentata una glaciale inaccessibilità.
Quando riconosce una matrice religiosa, la struttura depressiva gravita verso una normalità caratterizzata dall’affievolimento di ogni emozione calda e intensa rivolta al mondo; quando, altresì, la matrice è liberale, essa postula la repressione della rabbia come indice supremo di moralità sociale. Nel primo caso, il depresso vive nell’incubo di un senso di colpa ch’egli deve espiare mortificandosi; nel secondo, nell’incubo di una vergogna sociale che realizza, per effetto del giudizio degli altri, l’espiazione.
Ciò che viene connotato come basso all’interno di ogni struttura è agevolmente definibile secondo la logica degli opposti: nella struttura ossessiva è rispettivamente la degradazione morale e la perdita di controllo sulle emozioni; nella struttura isterica, la malizia e la vulnerabilità; nella struttura depressiva, l’abbandono alla rabbia e al piacere, come espressione di una ribellione ad un ordine sacro o sociale.
Nel delirio di contatto il soggetto difende la sua integrità morale e psichica, nella quale vede l’espressione di un’ascesa già avvenuta o il presupposto di un’ascesa da realizzare, dal rapporto con un mondo degradante e contaminante; nel delirio di trasgressione, altresì, per affermare la sua indipendenza da ogni autorità, sia essa religiosa o civile, egli tende ad infrangere le leggi o le regole sociali, votandosi alla degradazione.
Nel delirio narcisistico il soggetto mira a realizzare la sua elevazione in virtù della fusione con un oggetto d’amore sacro o mondano il rapporto con il quale configura una suprema armonia, immune da ogni conflitto; nel delirio di vulnerabilità, viceversa, egli regredisce in una condizione di totale inermità in rapporto ad un mondo che riconosce il diritto dei forti di dominare i deboli.
Nel delirio di colpa, il soggetto, attribuendosi desideri di vivere immorali e asociali, tende a preservare la sua anima e la sua libertà in virtù di una mortificazione che può giungere all’estremo dell’autosoppressione; nel delirio di immunità, affiora, altresì, una sfrenata voglia di vivere al di fuori degli schemi di una grigia e neghittosa normalità.
Risulta chiaro, da quanto si è detto, che il codice di ordine generale che sottende le strutture psicopatologiche riconosce almeno due diverse significazioni delle categorie di “alto” e di “basso”, che permettono di distinguere le strutture stesse in due gruppi. Lo schema seguente raffigura sinteticamente questi due gruppi, gli ideali dell’Io verso i quali esse appaiono orientate e le minacce da cui tendono a rifuggire in nome di quegli ideali.

Le differenze tra i due gruppi risultano evidenti.
Nel primo, gli ideali superegoici promuovono una integrazione sociale che postula la frustrazione del bisogno di opposizione; nel secondo, viceversa, essi promuovono un’individuazione pagata al prezzo della frustrazione del bisogno di integrazione sociale.
Se ci si ferma a livello fenomenologico, questa distinzione appare poco credibile. Il bisogno di differenziazione aristocratica morale, intellettuale e sociale di alcuni ossessivi, l’autosufficienza di alcuni isterici, l’autoattribuzione di qualità eccelse di alcuni narcisisti possono facilmente ingannare, lasciando pensare ad un bisogno di individuazione spiccato e incoercibile. Se si tiene conto delle minacce da cui essi si difendono la degradazione, l’aver bisogno degli altri, la disconferma risulta chiaro che la differenziazione è promossa da ideali che impongono al soggetto di reprimere, negare o rimuovere la quota dei bisogni che risulta incompatibile con quelli. Adottando quegli ideali, il soggetto vi si incarcera e, di conseguenza, non può individuarsi, ma solo mimare un’identità autentica.
Nello schema gli ideali superegoici risultano notevolmente eterogenei. Appare possibile, però, ricondurli a quattro tematiche: la prima concerne il potere di cui dispone un individuo in rapporto agli altri;la seconda, il rango che gli compete nella gerarchia sociale; la terza, il grado di libertà di cui dispone in rapporto alle norme sociali e alle opportunità di piacere offerte dal sistema; la quarta, l’attrezzatura culturale che può utilizzare per organizzare una visione del mondo interno ed esterno. Si tratta di tematiche che fanno capo a problemi reali ed essenziali ai fini del modo di essere e di porsi di ogni uomo nel mondo. Ma, nelle strutture psicopatologiche, queste tematiche appaiono organizzate da codici culturali particolarmente rigidi. Il riferimento univoco ad un “alto” e un “basso” comporta, infatti, a livello di ogni nucleo tematico, una scissione e un’opposizione irriducibile dei bisogni umani, che esclude ogni possibilità di mediazione dialettica. Mentre il Super-Io si incarica di reprimere ciò che deve essere vissuto come “basso”, gli ideali superegoici impongono ai soggetti modelli di normalità astratta che funzionano come miraggi.
La rigidità adialettica dei codici culturali che animano le strutture psicopatologiche può essere interpretata solo in due modi: o come effetto del disagio psichico, e cioè come ideologia privata prodotta dai soggetti per negare la loro vera realtà, che sarebbe rappresentata dal “basso”, o come causa di esso, e cioè come ideologie sociali che irretiscono i soggetti, impedendo loro di prendere coscienza dell’alienazione dei bisogni.
La prima ipotesi, come già detto, è invalidata dal fatto che, nelle esperienze psicopatologiche, gli ideali superegoici sono alienati non meno che rifiutati. Rimane dunque da prendere in considerazione l’altra ipotesi, secondo la quale la rigidità dei codici culturali che animano il disagio psichico rivelerebbe l’organizzazione adialettica degli stessi a livello delle ideologie sociali, e cioè dei quadri mentali collettivi, attraverso i quali il mito gerarchico persegue, in nome dell’armonia sociale, l’integrazione nel mondo così come è e la sanzione di coloro che “visceralmente” ad essa si ribellano.
Correlare gli ideali superegoici alle ideologie sociali non è impresa agevole. L’eterogeneità e la complessità dei primi lascia pensare che il mito gerarchico funzioni come un mostro con più teste, a ciascuna delle quali corrisponde un’organizzazione ideologica apparentemente autonoma. L’unico dato certo in comune sarebbe un’antropologia filosofica tributaria della teoria degli istinti. Quanto alle differenze, la difficoltà di rendere ragione di essa fa capo al fatto che, nel corso della storia, i sistemi di valori di matrice religiosa e liberale si sono intrecciati e sovrapposti, stratificandosi ad un livello, quello dei quadri mentali, che a giusto titolo può definirsi “inconscio sociale”. La via più agevole, l’unica, peraltro, possibile in rapporto alle nostre competenze, consiste nel ricostruire quei sistemi di valori in rapporto ai quattro nuclei tematici enunciati.
Lo schema seguente rende conto di questa ricostruzione.
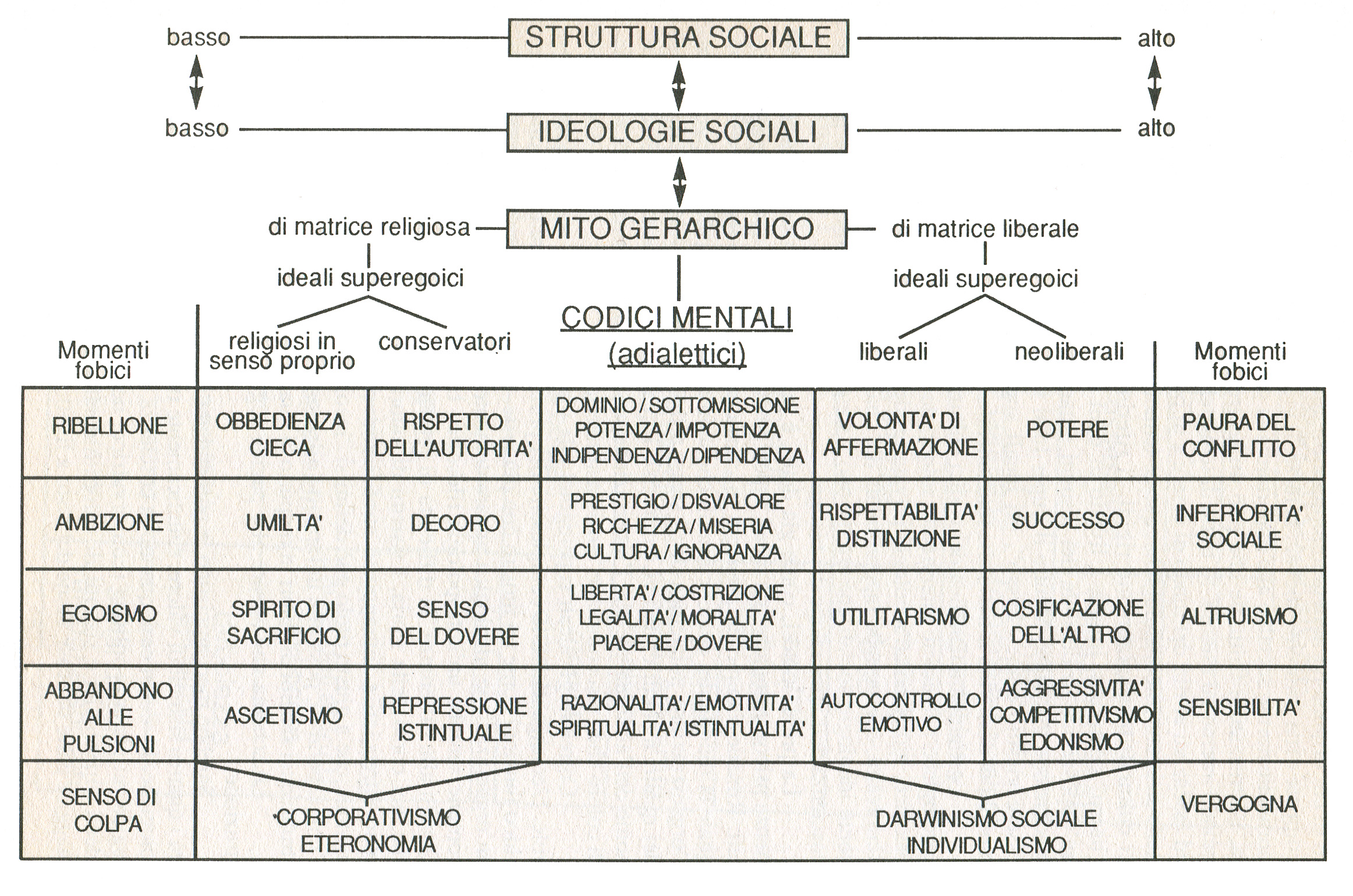
Sarebbe meccanicistico, e non dialettico, definire una correlazione rigida tra i quattro sistemi di valore, sinteticamente raffigurati, e le esperienze psicopatologiche. In alcuni casi, quando la coscienza riconosce una sovrastruttura ideologica religiosa o politica (conservatrice, neoliberale), la corrispondenza tra ideali superegoici e sistemi di valore è denunciata dal soggetto stesso. Nella maggior parte dei casi, come del resto a livello sociologico, gli ideali superegoici sono indefiniti o latenti, e i sistemi di valori cui essi fanno riferimento del tutto inconsci. Questo rappresenta un aspetto di estrema importanza sotto il profilo teorico e pratico.
Come è risultato evidente nel capitolo precedente, le strutture psicopatologiche riconoscono una matrice conflittuale univoca; ma la fenomenologia clinica, e cioè l’espressione soggettiva e sociale del soggetto e l’evoluzione del conflitto dipendono meno dalla matrice che dagli ideali dell’Io verso cui il soggetto si orienta vedendo in essi la salvezza da una temuta catastrofe personale e sociale. Quale che sia l’entità del conflitto, riconducibile all’alienazione dei bisogni e alla scissione dell’Io, sono gli ideali superegoici a fuorviare il soggetto da soluzioni possibili, dialettiche, e ad orientarlo verso i vicoli ciechi che impongono la realizzazione di un bisogno al prezzo della frustrazione dell’altro. Benché il soggetto stesso tenda, più o meno consapevolmente, a vivere quegli ideali come ideali dell’lo, si tratta di ideali superegoici che mirano ad impone un modo di essere e di porsi nel mondo inadeguato ai bisogni soggettivi e del tutto astratto in rapporto alle sue concrete esperienze di vita.
Ciò spiega il paradosso dell’opposizionismo che, benché inconscio, denuncia la vanità di pretese, ambientali prima soggettive poi, che urtano contro un’insormontabile “fissazione” ai bisogni, e gravita verso un sistema di valori “utopistico”, incentrato sulla pari dignità degli esseri, sulla giustizia sociale e sul valore supremo della socialità, intesa come riconoscimento dell’altro e da parte dell’altro.
Se questo è vero, la soluzione del conflitto, e cioè la liberazione dal labirinto superegoico, non può avvenire che in virtù di una critica degli ideali superegoici, che rendono seduttivo quel labirinto, e di una liberazione dei bisogni che traduce l’opposizionismo in opposizione attiva, mirante a definire e a realizzare un nuovo sistema di valori. La soluzione del conflitto psicopatologico impone, in altri termini, un cambiamento di mentalità: il riconoscimento dei bisogni alienati, la loro reintegrazione e una pratica della vita orientata a realizzarsi in nome di un sistema di valori nuovo rispetto a quelli veicolati dal mito gerarchico.
Questo discorso non stentiamo a riconoscerlo può apparire privo di senso a chi recinta il problema psicopatologico, e la propria capacità di capire i fatti umani, nei confini della biologia, dei meccanismi psicodinamici o della comunicazione interpersonale. Ciò che noi sosteniamo è che l’universo psicopatologico è il retro di una medaglia il cui verso è la normalità; esso, dunque, intrappolerebbe drammi microstorici, che si producono localmente per effetto dell’alienazione dei bisogni costitutiva del sistema sociale totale, entro labirinti di pietra ideologici che, come funzionano a livello sociologico normalizzando, e cioè assoggettando gli individui al mito gerarchico, così, in rapporto ad un’opposizione inconsapevole, funzionano amplificandola e sazionandola, conseguendo l’effetto di estraniarla rispetto al sistema sociale. Per dare credito a questa ipotesi, occorrerebbe una ricca documentazione di esperienze psicopatologiche, che i limiti del presente saggio non consentono di fornire. Ripromettendoci di assolvere questo impegno in un lavoro successivo, possiamo utilizzare ancora, a mo’ di esempio significativo, l’esperienza di Paola.
Costei si perde nel labirinto di un delirio d’amore mirante a salvarla dalla perdizione in virtù dell’approdo ad un matrimonio riparatore, che la confinerebbe nel ruolo domestico assegnato alle donne dalla tradizione, poiché non riesce a dare un senso propositivo e dialettico alla sua ribellione inconsapevole, frustrata e colpevolizzata da un sistema di valori ideologico cosciente, religioso e conservatore al tempo stesso. Benché mediato dal sistema familiare, il modello di normalità che la perseguita, e a cui essa si oppone visceralmente, pur volendovisi coscientemente piegare, viene dal mondo esterno e rappresenta un codice culturale normativo di significato storico. Ma dal momento in cui Paola, terrorizzata dai bisogni disordinati che alberga e minacciata dal Super-Io, si chiude in quel modello, proiettandolo su di in mondo, quello urbano, che non riconosce più come univoco, la sua esperienza si estranea e diventa delirante, il suo mondo, pur animato da un sistema di valori normativo, prodotto dalla storia, non coincide più con il mondo.
Pur non potendo essere ulteriormente documentate, le ipotesi che abbiamo formulato promuovono una serie di riflessioni.
Come si è detto, non si dà, se non occasionalmente, una corrispondenza puntuale tra i sistemi di valori superegoici rappresentati nello schema e le strutture psicopatologiche. Eccezion fatta, forse, per il delirio di colpa, che riconosce un’univoca matrice religiosa, ogni struttura può definirsi in rapporto ad uno qualunque dei sistemi di valori ed evolvere in rapporto ad esso o a un qualunque altro. La struttura ossessiva, per esempio, può far capo sia ad un ascetismo rigorosissimo di chiara derivazione religiosa sia ad un senso del dovere implacabile sotteso da una terrificante paura della libertà sia ad un codice di rispettabilità formale, che funziona come una maschera mimetica di normalità sociologica, sia infine ad una volontà di ascesa sociale, che postula il sacrificio totale degli affetti e del piacere.
Non è azzardato affermare, pertanto, che gli ideali superegoici, siano essi introiettati con il Super-Io siano essi appresi dal soggetto in rapporto alla sua esperienza sociale, rappresentano il momento più propriamente storico delle strutture psicopatologiche. La loro inadeguatezza in rapporto al corredo dei bisogni umani svela a sufficienza il loro essere a servizio del mito gerarchico.
Essi, e i sistemi di valori cui fanno riferimento, rappresentano i camuffamenti ideologici del mito gerarchico: soluzioni astratte offerte agli uomini perché il loro essere, psicologico e sociale, si modelli in maniera tale da sancire e riconoscere l’ordine di cose esistente, fondato sulla diseguaglianza, come l’unico possibile; perfettibile ma non modificabile strutturalmente.
Nel secondo capitolo si è tratteggiata, per sommi capi, la insidiosa trasformazione del mito gerarchico che, al suo potere tradizionalmente repressivo, ha associato, in concomitanza con l’avvento dell’ideologia liberale, un potere ipnotico e seduttivo. Ciò è avvenuto introducendo nel sistema sociale una mobilità senza apparenti limitazioni che relega in una condizione di inferiorità politica, economica e culturale non la maggioranza della popolazione, come postulava il mito gerarchico repressivo, bensì una cospicua minoranza: un terzo, secondo la pregnante formula di P. Glotz. La dinamica sociale è assicurata da un sistema di valori che, apparentemente, sembra soddisfare le aspirazioni più profonde della natura umana: ogni uomo, di fatto, aspira ad un potere reale, ad un riconoscimento sociale del suo valore, ad un certo grado di libertà e ad una partecipazione razionale alle vicende del mondo. In cosa consiste, dunque, l’inganno? Anzitutto, nella necessità strutturale di mantenere vivi i fantasmi fobici che alimentano la dinamica del sistema, connotandola come una perpetua e angosciosa fuga verso l’alto; fantasmi di impotenza e dipendenza, di disvalore e di indigenza, di costrizione e di pena, di ignoranza e di irrazionalità.
Per tenere vivi questi fantasmi occorre che qualcuno li rappresenti: e a ciò è chiamato un terzo della popolazione, che deve essere costituito da poveri, disoccupati, sottooccupati, emarginati, diversi.
Ancor più importante di questa necessità strutturale, è l’incidenza soggettiva dei sistemi di valori liberale e neoliberale: nonché la società, essi gerarchizzano la struttura stessa della personalità, scindendo e opponendo in essa ciò che è funzionale all’ascesa sociale e ciò che può comprometterla. Questa scissione è restituita dallo schema che abbiamo elaborato: la volontà cieca di affermazione personale postula la rimozione della paura del conflitto interpersonale, il mascheramento di ogni umana debolezza che possa offrire il fianco ad un attacco, la repressione della solidarietà e di ogni investimento emozionale a livello sociale. E’ questa, in pratica, l’ideologia della deregulation, che riabilita, entro i limiti della legalità, la legge del più forte, inducendo una fobia della sensibilità, alla quale si concede di esprimersi entro spazi privati rigorosamente recintati. Si tratta di un’ideologia ibrida, che ha innestato sulla matrice liberale classica valori propri dell’ideologia fascista, affrancandoli dal riferimento ad un etica che li subordina ai fini supremi della nazione e dello stato, e assumendoli come fini ultimi dell’individuo in quanto tale, che può prescindere dalla lotta per sopravvivere solo entro i confini delle mura domestiche e degli affetti familiari.
Come C. Lasch (?) ha tentato di dimostrare ne L’lo minimo questa ideologia non funziona, poiché l’interiorizzazione del sistema di valori neo liberale, in conseguenza della fobia della sensibilità, tende a invadere e a pervadere la soggettività e gli spazi privati, dando luogo alla condizione penosa di un io assediato, affetto da un delirio di vulnerabilità, il cui unico progetto essendo quello di non cadere in basso, e cioè di non trovarsi in balìa degli altri, tende a ritirarsi emotivamente dal mondo e a difendersi dalla vergognosa condizione di essere bisognoso anche negli spazi privati.
La psicopatologia contemporanea, che dimostra, peraltro, la persistenza di tutti i sistemi di valori rappresentati nello schema, permette di confermare e approfondire l’analisi di Lasch. Essa attesta, infatti, che il sistema di valori neoliberale, apparentemente propositivo, poiché promuove l’affermazione personale, il prestigio, la libertà, la razionalità pragmatica, è animato in realtà da quattro nuclei fobici, che fanno capo all’essere inadeguato e impotente, all’esibizione di comportamenti che attestano origini miserabili o una condizione attuale di indigenza, al trovarsi in una condizione di penosa costrizione che attesta l’appartenenza al mondo simbolico degli schiavi, e alla manifestazione di una sensibilità che, in quanto debolezza, rende vulnerabili ad un attacco. Questi quattro nuclei fobici integrano altrettanti codici mentali, che, sotto forma di ideali superegoici, animano l’universo psicopatologico contemporaneo, e che possono essere definiti rispettivamente come codice adultomorfo, rupofobico, claustrofobico, anestetico.
L’interesse analitico che dedicheremo ad essi è imposto dalla pressione ideologica che esercitano a livello del presente sociologico. Ma ciò non deve indurre ad ignorare che la loro pretesa imperialistica urta ancora contro la sopravvivenza, a livello di storia sociale, di codici antitetici sia di ispirazione religiosa che socialista e marxista. L’analisi dei codici neoliberali ha, dunque, un carattere parziale e non esauriente, il cui scopo è, anzitutto, di mettere a fuoco una possibile metodologia dialettica di ricerca sulle ideologie sociali.
Analizzeremo, ora, i singoli codici, accennando alle loro matrici storiche quanto basta per comprendere la configurazione che essi hanno assunto a livello di mentalità: configurazione psicologica e astratta, che permette ad ogni individuo, che li introietti sotto forma di ideali superegoici, di sentirsi integrato nel suo essere e nella società. La psicopatologia contemporanea, nella misura in cui amplifica questo effetto normalizzante in virtù dell’opposizionismo, rivela il carattere alienante di quei codici in rapporto al corredo dei bisogni umani.
1. Il codice adultomorfo
Alle sue origini, che coincidono con l’avvento della borghesia, il codice adultomorfo si contrappone a due modelli negativi: quello delle masse popolari, e soprattutto dei poveri, fondato su un’incoercibile tendenza all’ozio e all’abbandono agli appetiti “bestiali”, e quello nobiliare, parassitario e frivolo. Entrambi questi modelli sono colti come esempi d’imprevidenza e di dipendenza passiva l’una, tirannica l’altra : espressioni, dunque, di debolezza di carattere dovuta a lassismo morale.
In contrapposizione ad essi, il modello adultomorfo propugna la forza di carattere come attributo proprio dell’uomo nuovo. Per quanto questa possa far capo ad una predisposizione individuale, essa va promossa e forgiata attraverso un’educazione rigorosa, mirante ad espungere dalla natura umana i germi maligni che essa alligna. Tale educazione deve inculcare nel soggetto la fiducia nelle sue capacità individuali, l’accettazione della competizione e della lotta come legge dell’esistenza, l’etica del lavoro e, come obiettivi ultimi, l’indipendenza e l’autosufficienza.
Proposto originariamente come modello di normalità e di maturità valido universalmente, il codice adultomorfo è venuto ad urtare rapidamente contro un sistema strutturale: l’impossibilità di concedere a tutti le stesse opportunità di sviluppo, e la necessità fisiologica di mantenere una quota della popolazione in uno stato di indigenza. L’ostacolo è stato utilizzato paradossalmente: anziché emarginati dal sistema, i poveri sono divenuti i rappresentanti di una categoria quella degli esseri deboli e privi di tensione morale che, per demeriti personali, nonché elevarsi, tende a scivolare verso il basso. Ciò ha permesso di significare quella categoria come un fantasma fobico, atto ad alimentare una dinamica sociale di fuga verso l’alto.
Un’ulteriore estensione della categoria è più recente, e si deve, in larga misura, alla scoperta psicoanalitica del bambino come rappresentante ottimale di essa, in quanto radicalmente bisognoso e dipendente dagli altri. Questa scoperta ha provocato un ulteriore rafforzamento del codice adultomorfo, che è giunto a configurare, in ogni vicenda individuale, una soluzione di continuità tra esperienza infantile ed esperienza adulta: soluzione critica che fa coincidere la morte del bambino con la nascita dell’adulto come essere forte, autonomo, autosufficiente, capace di affrontare il mondo e di lottare per affermare la sua potenza.
La contestazione fascista del modello adultomorfo borghese, giudicato mediocre, egoisticamente dedito all’interesse privato e scarsamente incline a correre dei rischi, è stata integrata al modello stesso, con l’effetto di togliere ad esso ogni residua valenza morale.
Dagli anni ‘70 in poi, il codice adultomorfo è giunto a definirsi nei termini di una cieca volontà di affermazione contro tutto e contro tutti. Ma la realizzazione di questa volontà impone di nascondere e di negare ogni bisogno che possa essere vissuto e interpretato come debolezza.
L’effetto del codice adultomorfo a livello educativo consiste nel pretendere dai bambini prove sempre più precoci della loro predisposizione a divenire indipendenti e forti di carattere. Dall’adolescenza in poi, l’influenza delle istituzioni educative viene soppiantata dai massmedia, che, con frequenza sempre maggiore, propongono dei modelli di normalità di tipo adultomorfo. La somma di questi effetti è l’introiezione di un ideale superegoico che fa incombere una cappa di ridicolo e di vergogna su tutti gli aspetti della personalità che, alla luce di esso, rientrano nella categoria della debolezza e dell’inadeguatezza.
La crescente pressione a livello di mentalità del codice adultomorfo e attestata da numerose esperienze psicopatologiche.
In alcuni casi, l’introiezione del codice adultomorfo orienta gli individui ad un perpetuo inseguimento di una normalità che è sempre lì lì per essere realizzata, ma fugge in avanti come un miraggio. Sotto il profilo sociale, queste esperienze, incentrate spesso su una dedizione totale allo studio e al lavoro, danno luogo a risultati eccellenti. Ma, a livello di vissuto, i soggetti continuano a vivere nell’incubo di essere inadeguati e non all’altezza rispetto all’ideale superegoico. Ciò li induce a non sentirsi mai soddisfatti, e ad investire quote sempre maggiori di energie nella direzione di una piena realizzazione di sé, che li affranchi da un’angoscia penosa e perpetua di precarietà, che fa riferimento ai bisogni personali mortificati in nome del codice adultomorfo. Questa dinamica, che fa capo alla struttura ossessiva, può, ovviamente, evolvere in molteplici direzioni psicopatologiche.
Più drammatiche sono le esperienze sempre più frequenti nel corso degli ultimi anni di soggetti che, in nome del codice adultomorfo, rifiutano di vivere l’adolescenza e, al suo esordio, si chiudono in una rigida maschera di autocontrollo
La negazione dell’esperienza infantile, vissuta drammaticamente, e la paura di esporre la propria inadeguatezza agli occhi di un mondo cui si attribuisce un univoco metro di misura adultomorfo creano i presupposti di catastrofi psicologiche di vario genere. Talora, in conseguenza di una totale inibizione della vita sociale, esse sono repentine, configurandosi sui registri del delirio di vulnerabilità, di innocenza o di colpa. Talaltra, esse evolvono lentamente. La persistente dipendenza familiare viene occultata, il più spesso, da atteggiamenti di distacco, di sfida e, talora, di prepotenza tirannica.
A livello sociale, l’identificazione dell’Io con un ideale adultomorfo promuove o un atteggiamento di fredda Super-Iorità sui coetanei o la tendenza ad imporsi ad essi nella logica della legge del più forte.
Non di rado, la paura di manifestare la debolezza o la sottomissione dà luogo all’esibizione di comportamenti temerari e rischiosi come pure a una spiccata tendenza a sfidare l’autorità costitutiva. Talora questi atteggiamenti si radicalizzano, configurandosi un delirio di trasgressione.
L’esito di queste esperienze è sufficientemente prevedibile. O il soggetto, infatti, deteriorati tutti i rapporti sociali, si ritira in una solitudine animata da vissuti rabbiosi di riscatto onnipotente; o egli comincia a sentirsi smascherato nel suo vergognoso “nanismo” da sguardi, allusioni, dicerie e calunnie, che inducono spesso una reazione violenta.
2. Il codice rupofobico
Mentre il codice adultomorfo ha conosciuto una progressione lineare, vanamente ostacolata dal conservatorismo religioso e politico, oscillando solo tra l’esaltazione della potenza individuale in nome dei fini supremi dello stato o dei fini privati, il codice rupofobico, codice di differenziazione incentrato sulla categoria adialettica pulito/sporco, ha una storia più complessa.
Le sue origini sono molto più antiche dell’avvento della civiltà borghese, risalendo alla contestazione cristiana del formalismo farisaico, alla cui moralità meramente esteriore viene contrapposta una moralità interiore, che propone all’uomo una lotta perpetua contro tutto ciò che di sporco agita la sua anima per effetto del Maligno.
Codice morale e, successivamente nel corso del Medioevo, codice igienico, mirante a scongiurare i contagi, esso, a partire dal Settecento, si è definito come codice sociale, devoluto a sottolineare la differenza di rango, soprattutto in rapporto alle necessità o meno di sporcarsi lavorando.
Valenze morali e valenze sociali sono poi confluite nell’ideologia della rispettabilità borghese, che implica un’intima corrispondenza tra forme esteriori e valori interiori. Alla luce di questa ideologia, l’elevazione sociale è imprescindibile da un’elevazione culturale e spirituale: lo sporco, dunque, viene ad identificarsi con la miseria, la volgarità, l’animalità istintuale, il disordine morale; il pulito, viceversa, con l’agiatezza, la Super-Iorità, la distinzione, l’autocontrollo istintuale, la cultura e la moralità.
Proponendo un sistema di valori che associa allo status e al rango la funzione di indicatori sociali, morali e culturali, il codice rupofobico borghese tende a squalificare tutto ciò che, nella natura umana non meno che nel corpo sociale, sta in basso come primitivo, selvaggio, non evoluto, e quindi tendenzialmente amorale e asociale.
Da questo punto di vista, si può comprendere in quale misura la psicoanalisi freudiana, accreditando la teoria istintualistica, e cioè attribuendo alla natura umana un corredo filogenetico che postula la repressione come momento individuale e collettivo di civilizzazione, abbia contribuito a convalidare quel sistema di valori.
In tempi più recenti, il codice rupofobico ha subìto però un’ulteriore trasformazione. Le esigenze del capitalismo avanzato hanno trasceso la morale dell’ascetismo e della rinuncia al piacere su cui si fondava, nell’Ottocento, la rispettabilità. L’ascesa sociale e intellettuale delle classi Super-Iori, cooptate al consumismo, ha imposto nuovi criteri di differenziazione. Nell’ottica neoliberale, stare in alto non implica più la rispettabilità, valore ormai ampiamente condiviso da tutte le classi, eccezion fatta per la categoria degli emarginati, bensì l’ostentazione di status symbols attestanti il prestigio e il successo.
Il codice rupofobico contemporaneo identifica nel lusso e nel consumo di beni materiali e culturali riservati a pochi dai capi d’abbigliamento alle opere d’arte l’indice di una condizione sociale prestigiosa, il cui potere di differenziazione come vedremo ulteriormente consenta anche l’affrancamento dalla morale comune; lo stare in basso è, di conseguenza, definito immediatamente dalla miseria e in maniera indiretta da un consumo costretto entro i confini di beni necessari.
La psicopatologia contemporanea restituisce compiutamente la storia del codice rupofobico, sino alle più estreme e più recenti configurazioni.
In alcune esperienze, facenti capo alla struttura ossessiva e a quella depressiva, la necessità di occultare e di mortificare gli istinti sembra fare immediatamente riferimento ad un ideale superegoico che coincide punto per punto con l’ideologia della rispettabilità borghese, che privilegia le pubbliche virtù.
In altre ancora, di matrice religiosa, la frustrazione istintuale non si esaurisce a livello di maschera sociale, ma impone al soggetto l’identificazione con un ideale superegoico la cui elevatezza morale e culturale è attestata dalla repressione di ogni vizio privato.
Confuse con la sociologia della vita quotidiana sono molte esperienze, soprattutto femminili, nelle quali l’amore per il decoro, l’ordine, la pulizia e l’igiene investe l’ambiente domestico. In tali casi, l’elevatezza dell’ideale superegoico è restituita direttamente dall’entità delle prestazioni erogate, che danno la misura della schiavitù dell’Io rispetto ad un occhio inquisitorio superegoico perennemente attento a scovare indizi sia pure minimali di disordine e di sporcizia.
Gli effetti del codice rupofobico neoliberale sono imponenti a livello giovanile. In molti casi, esso si somma al codice adultomorfo e dà luogo ad un’identificazione onnipotente dell’Io, che impone di esibire e di ostentare la prova di appartenenza ad un “razza” Super-Iore. Ciò può avvenire in maniere molteplici. Talora l’individuo è indotto ad un aristocratico distacco e isolamento rispetto al mondo: il valore che egli si attribuisce, in tali casi, si fonda su autentiche qualità di ordine intellettuale e morale. Ma tali qualità sono irretite da un ideale superegoico, che promuove un disprezzo viscerale nei confronti di un mondo vissuto come degradato, tal che il soggetto deve rifuggire da ogni contatto con esso. In altre esperienze la Super-Iorità è esibita sotto forma di qualità personali, fisiche, culturali, economiche la cui ostentazione mira a sedurre gli altri, senza che si instauri alcun rapporto intimo.
La frustrazione del contatto con il mondo che queste esperienze comportano è, naturalmente, esposta a molteplici sviluppi psicopatologici.
Non si può ignorare, infine, che il codice rupofobico, non meno di quello adultomorfo, e spesso condensato con esso, è all’origine del disagio sociologico che investe larghe fasce giovanili di matrice non abbiente. Tale disagio, caratterizzato da un sentimento di impotenza e di umiliazione sociale, promuove deliri di onnipotenza, ma anche, e in misura maggiore, fenomeni di criminalità orientati a colmare uno scarto vissuto come espressione di disvalore personale e familiare.
3. Il codice claustrofobico
Se il mito gerarchico ha segnato la storia dell’umanità, configurandola come storia di schiavitù, servaggi e sottomissioni, l’aspirazione alla libertà deve avere sempre animato, sotterraneamente, i cuori umani. Ma il tradursi di questa aspirazione in un codice claustrofobico, che identifica la libertà con l’affrancamento da ogni legame e da ogni costrizione, è di data recente. La scoperta di questo codice, sia pure inconsapevole, la si deve a Freud. Questi, esplorando gli universi soggettivi come pareti di caverne sulle quali vede riflettersi fantasmi di cui non può cogliere il nesso con le strutture sociali e mentali della realtà che in essa, con la mediazione del soggetto, si riflettono amplificandosi, coglie in quei fantasmi la prova della asocialità e amoralità della natura umana. A posteriori, tenendo conto del contesto storico ancora impregnato di conservatorismo gerarchico, è agevole vedere in essi l’espressione di un bisogno di individuazione alienato, costretto ad esprimersi nella forma del rifiuto e dell’attacco ad ogni vincolo coercitivo, sia pure esso di natura affettiva.
II fraintendimento di Freud è dovuto al fatto che questo codice si definisce in un contesto di civiltà che ormai da circa un secolo ha riconosciuto formalmente la libertà individuale come attributo e diritto proprio di ogni essere umano.
A metà del sec. XVIII, Rousseau (2) aveva preconizzato il dramma della scissione tra esigenza sociale e natura umana, sostenendo che produrre un cittadino e produrre un uomo sono processi antitetici, sì che si sarebbe dovuto incidere in un senso o nell’altro, essendo le due cose incompatibili.
Nei Manoscritti del ‘44 Marx (3) documenta il prezzo pagato alla produzione del cittadino borghese dal proletariato, che rappresenta una nuova forma di schiavitù:
«...l’uomo (l’operaio) si sente libero solo nelle sue funzioni animali, come il mangiare, il bere, il procreare, e tutt’al più l’abitare una casa e il vestirsi; e invece si sente nulla più che una bestia nelle sue funzioni umane (cioè il lavoro). Ciò che è animale diventa umano, e ciò che è umano diventa animale».
In virtù del suo osservatorio particolare, Freud scopre qualcosa di più drammatico: la trasformazione dei bisogni di libertà in pulsioni anarchiche nel cuore stesso del cittadino borghese. E non si tratta di una scoperta riducibile nell’ambito psicopatologico, o a un contesto conservatore. Ne Il disagio della civiltà, Freud infatti la estende all’intera società europea, individuando negli eccessi della civilizzazione borghese la causa di un malessere psicologico diffuso. Il prezzo di questi eccessi, che tendono, peraltro, a cooptare tutte le classi sociali, è la dissociazione tra comportamento sociale ed esperienza interiore: più il primo sembra conformarsi ad un modello di “urbanità”, più la seconda si anima di convulse fantasie anarchiche, che attestano la pressione di un desiderio di libertà avverso ad ogni convenzione sociale e ad ogni legame affettivo.
Quest’ultimo aspetto sgomenta Freud. Che l’uomo, con la sua natura pulsionale, mal si adatti alle esigenze della vita sociale è, nella sua ottica conservatrice, un fatto ovvio; ma che la natura umana si ribelli anche al dolce gioco degli affetti privati, e li attacchi in nome di una cieca distruttività, appare a Freud mostruoso. Al punto che egli è costretto a riconoscere questa distruttività solo nella forma del parricidio fantastico, nonostante la sua esperienza lo ponga di fronte al fatto che, nei contesti familiari, la rabbia distruttiva può investire tutti i rapporti, e promuovere dunque fantasie di parricidio, matricidio, uxoricidio, figlicidio, fratricidio.
Il codice claustrofobico è il codice di una libertà individuale in opposizione ad ogni forma di legame sociale: libertà dunque che postula l’attacco e la dissoluzione dei legami.
Freud non può comprendere che non sono i legami interpersonali e sociali in sé e per sé ad essere odiati, ma ciò che in essi scorre: i sistemi di valori mortificanti, mistificanti, alienanti. Ma nessun altro, a dire il vero, sembra in grado di comprendere il dramma sociologico e psicologico di un bisogno di libertà che è esploso entro forme sociali e mentali che lo riconoscono solo in astratto, giuridicamente, ma di fatto lo soffocano, distorcendolo. Consiste in questo la crisi dell’ideologia liberale, che, mossa dall’intento di affrancare le potenzialità dell’individuo e della società nel suo complesso dalle costrizioni del mito gerarchico repressivo, rappresentato dallo stato e dalla chiesa, è giunta ad atomizzare l’individuo e a configurare una società civile all’interno della quale, sia a livello pubblico che privato, ciascuno si sente oppresso dall’altro.
L’ideologia fascista muove dalla crisi della civiltà borghese, che rende l’individuo avverso ad ogni progetto di riforma sociale e, nel contempo, intimamente anarchico, e tenta di risolverla riabilitando un sistema di valori collettivi atto a porre la volontà di affermazione personale, incentivata al massimo, al servizio del corpo sociale, della nazione e dello stato. Ma questa soluzione, nonché risolverlo, sposta il problema: le nazioni che la adottano giungono a sentirsi costrette entro una camicia di forza di convenzioni formali, diplomatiche. Il codice claustrofobico, che sottende l’ideologia nazionalista, esplode nell’anarchia della politica di potenza, del razzismo e della guerra.
Il sistema liberale, nel dopoguerra, non può non tener conto della crisi che ha minacciato la sua sopravvivenza. Ma, non potendo esso rinunciare all’opposizione tra libertà individuale e uguaglianza sociale, che rappresenta l’elemento dinamizzante la gerarchia sociale, l’individualismo va rilanciato inducendo un’ulteriore accentuazione claustrofobica dei legami sociali. Nonché repressa, l’aggressività viene assunta come un aspetto proprio della natura umana e autorizzata nella misura in cui essa viene devoluta a fini competitivi. In conseguenza di ciò, la moralità borghese viene riformulata e perde ogni residua connotazione religiosa. Il ceto dominante, scaricando sui ceti subalterni i valori tradizionali dell’autocontrollo emotivo e della frustrazione pulsionale, riabilita una teoria della élite che le consente di farsi promotrice di nuovi valori. Il rispetto dell’autorità viene soppiantato da una polemica antiburocraticista, che assume talora connotazioni di antistatalismo; la rispettabilità da un anticonformismo più o meno radicale incline alla sperimentazione di nuovi costumi morali; l’etica della rinuncia al piacere dall’edonismo. Ostentata senza pudore e propagandata dai massmedia, la teoria di un’élite, che sembra affrancata da ogni costrizione e irreversibilmente felice, incide nell’immaginario collettivo, schiacciando la società civile sotto il peso di un quotidiano, pubblico e privato, che non può non essere avvertito come penoso.
Non è più, come ai tempi di Freud, la repressione pulsionale venuta apparentemente meno in conseguenza della valorizzazione dell’aggressività competitiva e della liberazione sessuale a generare disagio sociologicamente, bensì la proposizione di modelli di libertà irraggiungibili che, a livello individuale e collettivo, funzionano come miraggi atti ad alimentare una dinamica sociale orientandola verso il regno della libertà identificato con il paradiso artificiale dei V.I.P.
Trattandosi, però, di un paradiso necessariamente riservato a pochi, non c’è da sorprendersi per il fatto che la diffusione del codice claustrofobico si traduca, negli altri, in sterili fantasie di liberazione dai pesi della vita. La psicopatologia contemporanea restituisce il codice claustrofobico nelle due versioni che esso ha sinora assunto. In alcune esperienze, tipicamente ossessive, esso si manifesta con la stessa fenomenologia descritta da Freud. Ma, in questi casi, la libertà, proprio perché si presenta con fantasie tali da evocare immediatamente la paura di un’esclusione radicale sociale, rimane inespressa sotto il profilo comportamentale, quando addirittura non dà luogo ad un aumento del controllo.
In altre esperienze, che rientrano nell’ambito isterico, l’esplosione della libertà claustrofobica avviene dopo lunghi periodi di normalizzazione. A differenza del passato, quando esitavano rapidamente in disagio psichico, queste esperienze, grazie a nuove possibilità offerte dal sistema sociale, danno luogo a rivoluzioni private a vicolo cieco. Sollecitate da una incoercibile ansia di libertà, le persone attaccano tutti i legami con la realtà, separandosi dalla famiglia, abbandonando il lavoro, cambiando abitudini di vita. Si tratta di una vera muta, che, prima o poi, dà luogo a crisi psicopatologiche, di solito depressive, dovute sia ai sensi di colpa che alla delusione legata alla scoperta della difficoltà di realizzare un’autentica libertà al di là del movimento rivoluzionario di affrancamento dalle catene del quotidiano. Quando il codice claustrofobico si attiva precocemente, a livello giovanile, gli esiti possono essere diversi. Talora, esso si traduce in una rivoluzione passiva: i soggetti abbandonano la scuola, rifiutando ogni impegno costrittivo, come ad es. il lavoro, si ribellano ad ogni legame parentale e al senso del dovere, si votano ad un’inerzia spesso alimentata da sogni di onnipotenza. Talaltra, la rivoluzione imbocca direttamente il tunnel della trasgressione sistemica, sia nel contesto familiare che a livello sociale. Per qualche tempo, può sembrare che questi soggetti amino solo la “bella vita”: di fatto, via via che le esperienze progrediscono, risulta chiaro che esse sono animate da una sfida “viscerale” nei confronti dell’ordine esistente, vissuto come una universale prigione, che postula, in nome di una libertà astratta, la messa in gioco dell’identità personale e sociale, e talora della vita stessa.
4. Il codice anestetico
«Storia e sensibilità: ecco un argomento nuovo»: è l’esordio di un articolo di L. Febvre (4) del 1941. L’argomento, di fatto, è nuovo per gli storici piuttosto che per la storia. Su cos’altro fonda il suo potere il mito gerarchico se non sulla capacità di catturare la sensibilità umana, e di piegarla alla sottomissione ad un’ideologia dominante religiosa, politica, culturale che sancisce l’appartenenza dell’individuo al gruppo sociale, e risponde ad un bisogno primario di sicurezza e di identità?
La novità della proposta di Febvre consiste nell’inaugurare e nel promuovere una riflessione critica sulle configurazioni ideologiche che, istituzionalizzando la vita affettiva, la determinano, a livello collettivo non meno che individuale, ad esprimersi e a manifestarsi fenomenologicamente in certi modi piuttosto che in altri egualmente possibili. Senza alcun riferimento a Freud, ma con un esplicito riferimento a Wallon, Febvre contesta il soggettivismo psicologico, e cioè l’assunzione della vita emozionale come espressione primaria e irriducibile dell’individualità. Una lunga citazione, che promuove un nuovo approccio al problema, si impone:
«È importante notare che le emozioni... hanno un carattere particolare da cui non può fare astrazione in tal caso chi si occupi della vita sociale dei suoi simili. Esse implicano rapporti fra uomo e uomo, relazioni collettive.
Nascono senza dubbio nelle profondità organiche di un dato individuo e spesso in occasione di un evento che colpisce solo questo individuo o almeno lo tocca con una gravità, con una violenza particolare. Ma si esprimono in modo tale, o meglio la loro espressione è il risultato di una tale serie di esperienze di vita comune, di reazioni simili e simultanee all’urto di situazioni identiche e di contrasti della stessa natura, o meglio ancora è il frutto di una tale fusione; di una tale riduzione reciproca di diverse sensibilità che velocemente acquistano il potere di provocare fra tutti i presenti per una specie di contagio mimetico il complesso affettivo motore corrispondente all’avvenimento sopraggiunto e risentito da un solo. Cosi, a poco a poco, le emozioni, associano diversi partecipanti che sono a loro volta iniziatori e seguaci, arrivando a costituire un sistema di incitamenti interinidividuali che si diversifica a seconda delle situazioni e delle circostanze, diversificando insieme le reazioni e le possibilità di ognuno. Tanto più che una volta stabilitasi questa concordia, regolatasi la simultaneità delle reazioni emotive e rivelatesi di natura tale da conferire al gruppo una sicurezza maggiore o una maggior potenza, si trova ben presto l’utilità di giustificare la costituzione di un vero e proprio sistema di emozioni. Esse diventano come un’istituzione. Sono regolate alla stregua di un rituale».
Questo approccio rende conto della proposta rivolta da Febvre agli studiosi di scienze umane e sociali: «L’apertura di una vasta inchiesta collettiva sui sentimenti fondamentali degli uomini e la loro modalità». Una storia, dunque, come suggerisce Febvre, dell’Amore, della Paura, della Morte, della Pietà, della Crudeltà, della Gioia: una storia infine della Sensibilità attraverso i quadri mentali che, comuni a tutta una società in un dato momento ma non percepiti o scarsamente percepiti dai contemporanei, impongono alla vita affettiva, non meno che al pensiero e al comportamento, regole e valori che prescrivono o proscrivono le sue modalità espressive, a livello collettivo e individuale.
La proposta di Febvre è stata accolta e approfondita dagli storici della scuola “Les Annales”, ma è stata ignorata dalle scienze psicologiche e psichiatriche. Inopportunamente, perché, anzitutto, i codici mentali inerenti il rapporto tra ragione ed emozioni seguono la loro stessa storia. Pinel che libera i folli dalle catene rappresenta, non solo inconograficamente, la ragione illuministica che presume di poter funzionare come una buona medicina per ogni tipo di disordine passionale. Kraepelin, altresì, rappresenta il razionalismo borghese positivista, che, dall’alto di un supremo autocontrollo emotivo, pretende di oggettivare fatti umani carichi di intense risonanze emozionali. Freud, infine, conscio della crisi del razionalismo, ma, nondimeno, incapace di rinunciare ad un’ottica positivista, tenta la quadratura del cerchio, creando una metodologia atta a far affiorare la vita emozionale con le sue connotazioni passionali e, nel contempo, ad imbrigliarla entro un set interpersonale capace di controllarla e a squalificarla entro una cornice teorica che vede in essa solo l’infinito disordine della natura cui può porre rimedio solo una cultura illuminata.
Ancora oggi, in ambito psichiatrico, ai teorici dell’empatia, che identificano in un generico e solitamente ipocrita “calore” umano l’elemento terapeutico per eccellenza, si contrappongono, in misura crescente, i teorici dell’intervento meramente tecnico, i quali ritengono necessario, a fini terapeutici, oggettivare, manipolare esperienze umane, e, soprattutto, non lasciarsi coinvolgere nei giochi senza fine di cui i disagiati psichici sarebbero maestri. Il codice iperestesico della vibrazione empatica si contrappone, in ambito psichiatrico, al codice anestetico dell’oggettivazione tecnicistica. Il presente, anche sotto il profilo specialistico, riassume il passato, e prefigura, per la massiccia pressione del codice anestetico, un futuro inquietante.
Occorre, necessariamente, ripercorrere i quadri mentali inerenti la sensibilità per capire ciò che sta avvenendo a livello psicopatologico, oggi.
Con i suoi ideali di libertà e di giustizia, frustrati secolarmente, l’illuminismo, che non è affatto preda del mito di una fredda ragione, mette in movimento, in tutta Europa, uno sconvolgimento emozionale di massa, che rapidamente si configura come incontrollabile.
La civiltà borghese che utilizza, per affermarsi, questo sconvolgimento, orientato verso l’assolutismo conservatore e la religione, si legalizza contrapponendo all’isterismo delle masse popolari, inclini alle passioni, ai pregiudizi e alle superstizioni, il modello morale e sociale del gentiluomo dotato di un perfetto autocontrollo emotivo e capace di mantenere, in ogni circostanza, un atteggiamento equilibrato. Uno degli elementi costitutivi della forza di carattere, necessaria ad affrontare attivamente le difficoltà della vita, diventa il “sangue freddo”, che, a differenza del sangue blu, può essere acquisito solo in virtù d’un’educazione mirante a temperare e a controllare gli eccessi passionali propri della natura umana.
← Il codice dell’autocontrollo emotivo, che non è ancora un codice anestetico, implica un rapporto pragmatico con il sociale, un ritiro nel culto degli interessi privati e degli affetti familiari, un bisogno estremo di sicurezza che giunge, rapidamente, a configurare il modo d’essere borghese sul registro dell’ aurea mediocritas. La misura emotiva è in realtà, un difetto di spontaneità, che mortifica l’identificazione con l’altro e sconsiglia, al di là del sistema familiare, ogni autentico investimento emozionale. Questa ideologia, vagamente ossessiva, fondata sul calcolo, sulla previdenza e sulla prudenza, promuove una serie di reazioni irrazionalistiche il cui rappresentante principale è Nietzsche, che al modello borghese contrappone l’uomo dionisiaco, il barbaro capace di dare sfogo a tutte le passioni positive l’orgoglio, la gioia, l’amore sessuale, l’odio, la brama di potere. In realtà, l’irrazionalismo nietzschiano coglie un pericolo reale: che l’uomo rinunci a “sentire” per vivere tranquillo, e che il suo orizzonte vitale si esaurisca nella difesa della sua vulnerabilità emozionale rispetto ad un mondo che i fenomeni dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione rendono socialmente inquietante e carico di tensioni.
Il conflitto tra bisogno di sicurezza e di appartenenza sociale, e bisogno di individuazione, il quale ultimo postula il coraggio di “squilibrarsi” emotivamente in rapporto al mondo, è colto drammaticamente anche da Freud, che, però, pur stigmatizzando le costrizioni eccessive che la civiltà pone all’espressione delle emozioni, non può non giungere a ritenere la normalità una condizione difensiva, configurandosi l’Es, con le sue passioni selvagge, come una fonte pulsionale controllabile ma, in sé e per sé, indomabile.
L’urto tra razionalismo borghese e irrazionalismo vitalistico si realizza, inesorabilmente, nel corso della seconda guerra mondiale. E lascia tracce nelle popolazioni civili, che hanno sofferto l’indicibile nella memoria collettiva.
Nel corso del dopoguerra, in rapporto agli sviluppi della scienza e della tecnologia, il richiamo alla razionalità pragmatica diventa un’ideologia ufficiale. La passionalità viene stigmatizzata come promotrice di utopie pericolose, che possono disinnescare le potenzialità distruttive che incombono sull’umanità. Coinvolti in un processo storico che ormai sembra sfuggire al controllo di chicchessia, e si tiene sul filo del rasoio di equilibri precari, gli uomini non possono trovar rifugio che in ritiro emotivo dal mondo.
Ma non si tratta di una difesa che assicura la quiete: perché il ritiro emotivo dal mondo non coincida con un’autoesclusione, occorre adattarsi razionalmente e rispondere alle pretese di una società in cui i ritmi di sviluppo diventano vieppiù affannosi. Il codice anestetico si fa carico di questa duplice necessità di isolarsi emotivamente e di competere senza tregua e promuove un nuovo modello antropologico: quello dell’uomo che, alla stregua di un elaboratore elettronico, valuta razionalmente i suoi investimenti nel mondo sia a livello sociale che privato in termini di costi e di benefici.
← Anni fa, un film fantascientifico - L’invasione degli ultracorpi - aveva preconizzato l’avvento del codice anestetico: liberati dalle emozioni da una trasformazione parassitaria, che, per il resto, rispettava tutte le altre caratteristiche, fisiche e psichiche, gli individui attestavano una completa beatitudine. Il protagonista, che rifiutava visceralmente quella trasformazione, riusciva a scampare all’invasione e a dare l’allarme al mondo. In un remake più recente il lieto fine saltava: non c’era più scampo per nessuno.
La psicopatologia contemporanea, più della sociologia, che ha indotto Lasch a definire la condizione dell’ Io minimo, che, sentendosi assediato e vulnerabile, mira unicamente a sopravvivere, funziona come un’inquietante documento dell’incessante pressione del codice anestetico. Già le statistiche attestano che, negli Stati Uniti, un quarto degli utenti si rivolgono a psichiatri e psicoterapeuti per una sorta di apatico interesse nei confronti della vita, che invano si tenta di inquadrare in una fenomenologia depressiva, mancando, di fatto, ogni altro sintomo che non sia un difetto di sensibilità. Ma, al di là delle statistiche, i dati tratti dalla pratica sono ancora più inquietanti. Indubbiamente, gran parte delle depressioni larvate attuali, che non compromettono l’efficienza individuale, ma tolgono la gioia di vivere, attestano la necessità di una difesa anestetica dalle tensioni della vita.
Ma c’è di più. La struttura isterica si va trasformando ed estendendo a macchia d’olio: anziché le brusche esplosioni emozionali di un tempo, essa si esprime nell’accettazione della vita nella logica della sopraffazione. Molti giochi relazionali senza fine, tra coppie coniugali o tra genitori e figli, sono caratterizzati da dinamiche sadomasochiste il cui obiettivo è l’insensibilità, che viene perseguita da ciascuno sia esprimendo cinismo che ricevendo dall’altro rappresaglie che, facendo soffrire, dovrebbero produrre una sorta di mitridatizzazione al dolore.
Più drammatica è la condizione di adolescenti che, avendo adottato il codice anestetico, tendono a socializzare a partire da una identificazione immaginaria dell’Io come invulnerabile e immune da risonanze emotive. Essi vivono, per periodi più o meno lunghi, in una maschera che attesta l’insensibilità. Ma, prima o poi, vengono ad urtare in situazioni di coinvolgimento emotivo che comportano catastrofi di destrutturazione.
Del tutto recente, infine, è un quadro psicopatologico giovanile, tributario della struttura ossessiva, caratterizzato dall’identificazione del soggetto con il computer. Tale quadro si presenta o sotto forma di un ideale dell’ Io compiutamente razionalizzato, che esclude qualsivoglia squilibrio emozionale, o sotto forma di delirio.
In quest’ultimo caso il soggetto vive un’avvenuta trasformazione del suo essere, che è divenuto una macchina senza alcuna emozione: e la trasformazione giustifica il fatto che egli non solo non ne risente, ma giunge a gioirne.
Capitolo ottavo
Sistemi interattivi ed esperienze psicopatologiche
I due capitoli precedenti hanno posto in luce le differenze sostanziali che sussistono tra strutture ed esperienze psicopatologiche. Data una matrice che opponga irriducibilmente il Super-Io ai bisogni alienati, matrice che si può ridurre formalmente al conflitto tra volontà altrui e volontà propria, le strutture psicopatologiche possono essere descritte e analizzate senza alcun riferimento ad individui o contesti ambientali particolari. Esse rappresentano, come si è detto, modelli astratti, che permettono di oggettivare ciò che nelle esperienze psicopatologiche appare come determinato e generale: in breve, ciò che si ripete con una coerenza intrinseca elevata.
L’universalità nello spazio e nel tempo delle strutture psicopatologiche, cui già si è fatto cenno, attesta che ogni società, in nome del mito gerarchico, e cioè di un’armonia che rispetti l’ordine di cose esistente, utilizza quelli che potremmo definire i “punti deboli” della natura umana la prolungata dipendenza dell’infante e il bisogno di appartenenza sociale per promuovere l’assoggettamento delle coscienze al sistema di valori che razionalizza e naturalizza la sua organizzazione politica, sociale culturale, e per debellare, ad ogni livello, l’affiorare del bisogno di opposizione con sanzioni psicologiche, riconducibili univocamente ad un processo di colpevolizzazione soggettiva, riservando sanzioni repressive alla devianza sociale.
In altri termini, in ogni società strutturata dal mito gerarchico, il bisogno di individuazione può realizzarsi solo al prezzo di un attacco simbolico colpevole alla tradizione e all’autorità, e cioè ai valori superegoici introiettati nel corso della dipendenza infantile. Facendo veicolare tali valori da persone i genitori, gli educatori cui i bambini sono legati da vincoli affettivi significativi, il mito gerarchico oppone alla nascita e all’affermazione di una coscienza critica un ostacolo di enorme portata, l’attacco ai valori superegoici non potendo essere vissuto che come attacco alle persone che li hanno trasmessi. Ipotizzando il parricidio come momento di passaggio dallo stato di natura allo stato di cultura, destinato a ripetersi nel corso di ogni esperienza soggettiva, Freud sfiora una verità che, per motivi ideologici, capovolge. La nascita della coscienza morale critica il passaggio, dunque, da una condizione culturale eterodiretta ad una condizione autodiretta postula l’attacco alla tradizione veicolata dai “padri”; e quest’attacco, in sé e per sé evolutivo non distruttivo, prima ancora che soggettivamente, è colpevolizzato culturalmente dalla tradizione per invalidare l’opposizione al potere gerarchico. In quanto dominato dal senso di colpa, almeno nella forma elementare dell’angoscia sociale, non c’è da sorprendersi che l’universo psicopatologico sia rappresentato ovunque, nello spazio e nel tempo; il senso di colpa è, infatti, anzitutto un prodotto culturale mirante a inattivare le potenzialità oppositive e critiche della coscienza umana. Alla suggestiva proposta di Lucien Febvre, già citata, potremmo aggiungere una voce di estremo interesse: la storia del senso di colpa.
Se si ammette che la matrice conflittuale da cui originano le strutture psicopatologiche, eccezion fatta per la forma a priori superegoica, che postula la condivisione dell’esperienza del gruppo di appartenenza, non è nell’ordine della natura o, in altri termini, se si attribuisce all’uomo una vocazione piuttosto che una renitenza alla socialità, è ovvio ipotizzare che quella matrice si genera nel corso dei processi di socializzazione individuale. Dal punto di vista psicopatologico, però, tutto ciò che si può dire su questa genesi è che essa rinvia ad un’organizzazione socioculturale che postula un certo grado di alienazione dei bisogni e offre modelli normativi la cui adozione dovrebbe permettere agli individui di adattarsi ad essa.
Da ciò discende che coloro che sviluppano un disagio psicopatologico o hanno subìto, nel corso delle fasi evolutive della personalità, un’alienazione intensa dei bisogni fondamentali o, pur adottando i modelli proposti dall’organizzazione sociale, oppongono ad essi un rifiuto “viscerale” insormontabile.
La psicopatologia, in quanto scienza astratta di forme di esperienza, non consente di andare al di là di tali inferenze.
Nella realtà, non si danno strutture bensì esperienze psicopatologiche irretite in esse. Ogni esperienza psicopatologica come si è tentato di dimostrare anima l’universo strutturale di sistemi di significazione, inerenti il mondo interno, quello esterno e il rapporto tra essi, la cui complessità ideologica esclude la possibilità di considerarli come prodotti soggettivi. Se le strutture psicopatologiche sono modelli astratti universali, le esperienze rinviano immediatamente ad un mondo storico, strutturato da sistemi di valori specifici, per quanto univocamente riconducibili al mito gerarchico.
L’analisi degli ideali superegoici, svolta nel capitolo precedente, ci ha posto di fronte ad una realtà che si può ritenere specifica della nostra civiltà, anche se in un senso relativo: la coesistenza, a livello di mentalità, di ideologie molteplici che, per riprendere la lucida analisi di Duby(1), sono totalizzanti, deformanti, normalizzanti, pratiche e concorrenti, ma che, nondimeno, risultando tutte funzionali alla persistenza del mito gerarchico, non tendono ad eliminarsi reciprocamente, bensì piuttosto a stratificarsi e a condensarsi.
Ciò significa che esse agiscono, nel tessuto sociale, settorialmente, accaparrandosi quote diverse della popolazione, fluendo, ramificandosi e riproducendosi attraverso le istituzioni, i sistemi e i gruppi sociali. Se ciò è vero, parlare, per la nostra società, di una crisi di valori, è un non senso: occorre piuttosto parlare di una crisi da eccesso di valori, che postulano, nel contempo, la mortificazione dell’individuazione e l’esaltazione dell’individualismo, e producono sensi di colpa, riferiti alla percezione soggettiva di pulsioni asociali, e vergogne sociali, riferite ad un grado di integrazione vissuto come inadeguato e inferiore.
Tenendo conto di ciò il problema dei rapporti tra singole esperienze psicopatologiche e storia sociale può essere impostato in maniera autenticamente dialettica. L’affiorare statisticamente indeterminato locale: in un microsistema piuttosto che in un altro; ed événementiel: in un membro piuttosto che in un altro dello stesso gruppo delle esperienze psicopatologiche, all’interno dello stesso sistema sociale, può essere, infatti, ricondotto al problema dei fattori congiunturali che fanno sì che la normalizzazione promossa dal mito gerarchico, con un apparato ideologico senza eguali nel corso della storia umana, esiti, localmente e individualmente, in un’esperienza di disagio.
A questo problema sono state date finora due risposte, entrambe inadeguate. La prima, fornita dalla psichiatria alternativa politica, secondo la quale una società alienata non può non produrre che miseria reale e/o psicologica, per cui la sociologia del fenomeno è di gran lunga più importante dei tentativi di spiegare il carattere locale ed événementiel della sofferenza, è formalmente corretta ma scientificamente insignificante e praticamente limitativa.
Posto infatti che la miseria reale incida indubbiamente sull’epidemiologia e sull’evoluzione del disagio psichico, rimane comunque da spiegare perché lo stesso contesto di miseria determini esperienze diverse normali e psicopatologiche negli individui che ad esso appartengono. Quanto alla miseria psicologica, che investirebbe ceti sociali senza rilevanti problemi di ordine materiale, si tratta di un flatus vocis ideologico, esposto, per di più, alla medesima critica.
La seconda risposta fa capo alla nouvelle vague psichiatrica internazionale, coalizzatasi, ormai, nel sostenere che, essendo la realtà umana multidimensionale biologica, psicologica e sociale , solo un approccio empirico, mirante a valutare, di esperienza in esperienza, la somma, l’interazione e l’incidenza nel tempo di quei fattori, possa permettere di giungere ad una definizione scientifica delle condizioni di rischio, di quelle precipitanti e di quelle determinanti l’evoluzione del disagio. Con il suo carattere esplicitamente compromissorio e non dialettico , l’ipotesi multidimensionale ambisce a superare e a risolvere i determinismi e i riduzionismi che avrebbero trasformato la psichiatria in un ambito di incessanti polemiche ideologiche piuttosto che di ricerca obiettiva, con il risultato di invalidare la sua scientificità agli occhi dell’opinione pubblica.
Ponendo tra parentesi l’interesse primario gerarchico dell’ipotesi multidimensionale di passivizzare la coscienza sociale in rapporto a problemi il cui studio e la cui gestione andrebbero delegati ai “tecnici”, rimane il fatto che essa predica in maniera persuasiva ma razzola male.
Tutte le ricerche sinora effettuate nell’ottica multidimensionale, infatti, concordano su di un solo punto: nel sostenere che ogni esperienza di disagio psichico riconosce, come causa prima, un’abnorme “vulnerabilità” individuale, e cioè una predisposizione di natura genetica che verrebbe attivata nell’interazione con ambienti evolutivi sfavorevoli e, dando luogo alla strutturazione di una personalità “fragile”, produrrebbe una più o meno rilevante difficoltà di adattarsi al mondo e, soprattutto, di confrontarsi con situazioni ambientali “stressanti” o eventi di vita negativi. La pretesa multidimensionalità, sfrondata degli orpelli ideologici, si riduce, in ultima analisi, a reificare l’ordine logico dei fattori biologico, psicologico e sociale come ordine temporale e causale.
E’ evidente che sia l’impostazione sociologistica che quella multidimensionale riconoscono come limite le ideologie implicite cui fanno riferimento: nel primo caso, il marxismo volgare; nel secondo, l’empirismo positivista.
Una nuova scienza del disagio psichico, che assuma come oggetto suo proprio le concrete esperienze individuali, deve superare entrambi questi punti di vista parziali in nome della dialettica uomo/ambiente. Essa non può darsi pertanto che come scienza microstorica: scienza di esperienze soggettive ciascuna delle quali tenta di integrare, fallendo, un passato sociale, familiare e personale in un progetto mirante a preservare e corroborare l’identità individuale e sociale. Scienza microstorica, deputata a cogliere nei tempi brevi delle esperienze soggettive la congiuntura dei tempi inerziali dei bisogni, la cui incessante pressione attesta l’orientamento della natura umana verso il mondo; dei tempi lunghi della cultura, i cui modelli di normalità si stratificano e si condensano a livello di mentalità; e dei tempi medi dei sistemi sociali e familiari, che quei modelli veicolano con il carico di contraddizioni proprio delle persone che li trasmettono.
Parlare di scienza microstorica facilmente induce a pensare alla riproposizione di un metodo biografico arricchito da rimandi allo sfondo macro e microsociale. In realtà, il metodo microstorico ha poco da spartire con l’idiografia, di cui abbonda la letteratura psichiatrica. Per chiarire questa differenza, torniamo, ancora una volta, all’esperienza di Paola. La mentalità che sottende il Super-Io di questa, proiettato su un intero contesto metropolitano, per il fatto di esprimersi sotto forma di messaggi verbali allucinazioni, indubbiamente può essere ricostruita nei dettagli come un sistema di valori inerente il ruolo della donna nel mondo. Tale sistema muove dal presupposto che la moralità ricade nell’ambito della responsabilità femminile. Gli uomini sono esseri squilibrati, deboli inclini a perdere la testa per uno sguardo o amorali pronti a profittare di ogni occasione che ad essi si offre per soddisfare i loro “istinti”. L’ordine morale dipende dal comportamento, virtuoso o “vizioso” delle donne.
Il Super-Io di Paola veicola un quadro di mentalità di lunga durata le cui matrici religiose riconducibili alla contrapposizione simbolica tra Eva e Maria e arricchite di valenze “naturalistiche” tipiche della cultura contadina, che non riesce ad affrancarsi dal fantasma del disordine prodotto dalla “femmina in calore” sono state integrate dal codice morale borghese ottocentesco sotto forma di scissione tra “angelo del focolare” e “prostituta”. A Paola tale codice arriva attraverso la famiglia e il contatto assiduo con ambienti religiosi (scuole di suore, parrocchia). Inurbandosi precocemente, e sviluppando una mentalità cosciente apparentemente aperta, la madre di Paola ha tentato di ribellarsi a quel codice, la cui persistenza è attestata, però, dall’assoluta frigidità, confessata alla figlia non come problema bensì come prova della Super-Iorità morale della donna che si presta, per dovere, a soddisfare i bisogni fisiologici del marito. Dalla madre, dunque, Paola eredita il codice morale repressivo e nuovi bisogni di indipendenza, che quella non ha potuto realizzare. La vivace e precoce percezione degli atteggiamenti maschilisti del padre incrementa l’ansia di liberazione dal servaggio. Per mascherare il conflitto con la tradizione, e le fantasie di libertà che ad essa si oppongono, Paola, con l’adolescenza, si cala nel ruolo di “madonnina”. Essa intuisce che si tratta di un ruolo falso, e che, un giorno o l’altro, dovrà liberarsene. Ma come? La vita di quartiere un quartiere periferico ove la piccola borghesia si mescola con il sottoproletariato offre modelli di comportamento atti solo ad incrementare il conflitto.
Le “brave” ragazze vivono, più o meno, come Paola; le ragazze “libere” sono quelle che vanno in macchina da sole con i ragazzi, cedono alle loro richieste; talora, rimangono incinte. Paola non ha né strumenti culturali né rapporti sociali che possano permetterle di mediare il conflitto che alberga. Il delirio d’amore rappresenta una drammatica quadratura del cerchio: esso si inaugura con una caduta simbolica nel peccato che poi dà luogo al ravvedimento e all’espiazione. Ma, di fatto, in virtù del delirio, Paola si affranca e dalla tradizione e dalle tentazioni del mondo. Leggere in questa esperienza gli effetti congiunturali di una tradizione culturale (conflittualizzatasi nel corso delle generazioni) e di nuovi bisogni affiorati, in conseguenza di ciò, in Paola e che questa non può realizzare secondo modelli di comportamento ad esso offerti dal mondo in cui vive, non significa ignorare altri aspetti. E’ fuor di dubbio, in particolare, che le “voci” da cui Paola si sente perseguitata debbano corrispondere ad un qualche disordine cerebrale, funzionale e/o biochimico. Ma è evidente che, con il loro carattere chiaro e distinto, esse, nonché mere allucinazioni, sono messaggi di una tradizione orale, di un codice culturale che, pur essendo stato secolarmente attivo, non risulta scritto da nessuna parte, non è stato ufficialmente riconosciuto né, propriamente parlando, trasmesso a voce. Non solo: il delirio di Paola, con le sue ambigue ma inconfutabili valenze protettive, che lo rendono insolubile, funziona anche come stigmatizzazione e rifiuto “viscerale” di un sistema di valori nuovo, che identifica la libertà della donna con il suo essere disponibile per uomini che continuano a trattarla come un oggetto. L’utopia di Paola, di una donna libera ma padrona di sé, che decide del suo destino, è incompatibile sia con la tradizione sia con i modelli di comportamento alternativi offerti dall’ambiente sociale in cui essa si trova a vivere.
Una singola esperienza non può accreditare un metodo, né, tantomeno, esaurire il discorso sui nessi molteplici tra globale e locale, collettivo ed individuale, strutturale ed événementiel. Ma dovrebbe essere chiaro che, assumendo la soggettività come fattore di mediazione tra bisogni umani e storia sociale, e tenendo conto che essa si integra a partire dalla determinazione storica dei bisogni e dalla utilizzazione di sistemi di significazione appresi, non occorre però, per rispettare la particolarità specifica di un’esperienza individuale, psicologizzarla, né per cogliere in essa quanto vi è di generale in senso storico sociologizzarla. La soggettività è immediatamente l’universale concreto: l’ambito in cui la storia, e cioè la realtà nella totalità delle sue strutture economiche, sociali, mentali modella i bisogni umani, e, attraverso la mediazione della coscienza, viene da essi, in misura proporzionale al grado di alienazione prodotta, modellata, rifiutata e realizzata nel contempo.
← Nessun soggetto può affrancarsi totalmente dalle determinazioni che subisce nel corso delle fasi evolutive della personalità; ma queste determinazioni, dall’adolescenza in poi, agiscono sotto forma di proscrizioni, prescrizioni e proposizioni superegoiche che investono la totalità dell’esperienza individuale, sia sotto il profilo soggettivo che comportamentale, e il cui potere sull’Io non è meramente rievocativo, fondandosi esso su un grado di alienazione dei bisogni che lo rendono necessario al fine di preservare l’identità personale e sociale. L’influenza dell’ambiente esterno, enorme nelle fasi evolutive, tende a ridursi progressivamente in misura proporzionale allo strutturarsi del conflitto tra Super-Io e bisogni alienati: in ogni esperienza, c’è un momento critico al di là del quale il mondo interno, con la sua matrice conflittuale che esprime la storia interattiva del soggetto con gli ambienti evolutivi, diventa determinante, nel senso che condiziona il modo di essere e di porsi del soggetto in rapporto al mondo. Come si è visto analizzando l’esperienza di Paola, il determinismo soggettivo, per quanto possa giungere a configurare una visione del mondo e una pratica della vita apparentemente dereistiche, non è altro che l’amplificazione di una matrice conflittuale determinata, sia per quanto riguarda il grado di alienazione dei bisogni che i valori superegoici, dall’ambiente.
La determinazione ambientale non va intesa, però, in senso meccanicistico. Ogni famiglia veicola, attraverso i singoli membri ed il sistema, una quota di bisogni alienati e la corrispondente sovrastruttura superegoica, riconducibili alla storia sociale e personale dei membri genitoriali e alla integrazione ideologica del sistema familiare. Occorre, dunque capire come e perché, ad un certo livello della catena generazionale, si determina una situazione congiunturale, tale per cui quest’integrazione può produrre un’ulteriore normalizzazione o un’esperienza di disagio psichico; e, in secondo luogo, perché il conflitto strutturale latente nel sistema familiare si esprime, svelandosi o amplificandosi, in un figlio piuttosto che in altro.
Il primo problema può essere agevolmente compreso se si utilizza dialetticamente la teoria dei bisogni. Trasmettendosi di generazione in generazione, il mito gerarchico, rimanga esso vincolato ad un sistema di valori di matrice religiosa o si affranchi da esso laicizzandosi, determina un’alienazione sempre più marcata dei bisogni, che può essere mascherata da una sovrastruttura superegoica, manifesta o latente, sempre più rigida. Date le loro matrici biologiche, i bisogni, però, continuano a premere: anzi, la pressione che esercitano si può ritenere direttamente proporzionale alla loro alienazione.
E’ facile capire che, per questa via, si configura, dopo alcune generazioni, una struttura congiunturale, tale che la matrice conflittuale o si esprime psicopatologicamente o si risolve in virtù di un radicale cambiamento di sistemi di valori. Talora, sembra che in alcuni sistemi familiari si realizzi questa seconda possibilità. E ciò rende misterioso il riprodursi, nella struttura esperienziale di un figlio, di un Super-Io apparentemente estraneo alla visione del mondo cosciente genitoriale. Ma, se si ricostruisce la logica delle proscrizioni, prescrizioni e proposizioni superegoiche, affiora sempre un quadro di mentalità individuabile nella storia sociale familiare, anche se a livello di generazioni passate. In questi casi, la trasmissione dei valori superegoici avviene, il più spesso, saltando apparentemente la generazione genitoriale: ma occorre ammettere logicamente, e, se si danno le occasioni, si può anche dimostrare, che si tratta di un fenomeno di latenza. Il Super-Io filiale riproduce, in breve, amplificandolo, un Super-Io genitoriale mascherato ideologicamente da una visione del mondo incentrata, apparentemente, su valori diversi.
Anche considerando il sistema familiare più semplice, quello nucleare, non si può ignorare, peraltro, che la coppia genitoriale è costituita da persone distinte, ciascuna con il suo bagaglio di storia sociale e individuale.
Ciò determina, spesso, conflitti tra sistemi di valori superegoici di matrice diversa. Per quanto questi sistemi possano essere ricondotti al mito gerarchico, la loro coesistenza e la loro proposizione da parte dei genitori realizza un ulteriore effetto congiunturale: in tali casi, infatti, il processo di socializzazione dei figli si configura come un processo di acculturazione.
Se i sistemi familiari, anziché sotto un profilo psicodinamico o comunicativo, vengono analizzati mirando a definire il conflitto strutturale attivo nelle personalità genitoriali, i sistemi di valori superegoici effettivamente trasmessi e le coperture ideologiche del conflitto, si riesce agevolmente ad individuare una situazione congiunturale e a valutarla come espressione di una storia sociale, genealogica e personale tributaria del mito gerarchico, in una o più delle sue versioni ideologiche, giunta ad un livello critico tale che i bisogni alienati, non potendo più essere contenuti nei sistemi di valori trasmessi, postulano o un’ulteriore normalizzazione regressiva o lo strutturarsi di un’esperienza psicopatologica.
Non possiamo, per ovvie ragioni di sintesi, delineare le indefinite costellazioni familiari che configurano ciascuna una situazione congiunturale. Dobbiamo, però, almeno dire che, in epoca recente, la stratificazione e la condensazione a livello di mentalità di sistemi di valori di matrice religiosa e di matrice liberale, funzionali al mantenimento del mito gerarchico ma in opposizione, ha prodotto, a livello familiare, una situazione che si può ritenere critica in senso generale. Lo stato di cose esistente nel mondo, che postula l’accettazione di una disuguaglianza arbitraria come espressione di meriti o demeriti individuali, induce, sempre più spesso, le famiglie ad imporre ai figli il rispetto dell’autorità, delle regole sociali e dello status quo, e, nel contempo, a sollecitare in essi un’intraprendenza che, avendo come obiettivo l’ascesa sociale, postula l’accettazione della legge del più forte. In altri termini, la gerarchia, riconosciuta per un verso, va rifiutata per un altro: ché ascendere socialmente significa, né più né meno, scavalcare qualcuno o prendere il posto di un altro.
Un esempio paradossale, ma estremamente significativo di questa confusione ideologica, è fornito da famiglie di tradizione cattolica che promuovono nei figli il bisogno di primeggiare, nella scuola e nel lavoro, come espressione dei valori cristiani del senso del dovere, dell’abnegazione e della donazione agli altri.
Questo approccio al sistema familiare può essere facilmente equivocato come un approccio culturale o cognitivista. In realtà, esso ha poco a che vedere con il culturalismo. In primo luogo, infatti, ciò che si sostiene è che le famiglie trasmettono di fatto non un sistema di valori bensì un conflitto strutturale cui quei valori dovrebbero rimediare. In secondo luogo e non si rifletterà mai abbastanza su questo i sistemi di valori familiari non vengono mai proposti, originariamente, in forma intellettuale: essi, infatti, ne siano o no consapevoli i genitori, si traducono immediatamente in pratiche educative, e cioè in un sistema di proscrizioni, prescrizioni e proposizioni più o meno esplicite che investe i bambini in quanto esseri senzienti, e tende di fatto a modellare, impregnare e determinare il sentire. E’ la sensibilità la qualità primaria dell’educabilità: qualità anteriore alla ragione, alla quale si rivolgono le pratiche educative. E su di essa, strutturandola, che in virtù dell’identificazione con i grandi, si fonda il potere del Super-Io. La dipendenza e il cieco affidamento dei bambini, per alcuni anni, configura l’unica condizione sociale “naturalmente” gerarchica. Profittando di questa condizione, l’onnipotenza genitoriale si esercita paradossalmente dando luogo ad un’amplificazione del conflitto strutturale latente nel sistema familiare, si esprima esso nel progetto di realizzare con il proprio figlio un rapporto di totale armonia, esente da ogni conflitto, o, viceversa, nel tentativo di correggere precocemente tutti i disordini e gli squilibri che esso esprime.
Il tipo e il grado di conflitto strutturale veicolato dalle famiglie incide a livelli diversi della evoluzione della personalità. Talora, esso realizza un effetto rapidamente paralizzante o squilibrante, frustrando gravemente o attivando il bisogno di opposizione: i bambini inibiti, più o meno gravemente, sul piano comportamentale e, viceversa, iperattivi e difficili sono i drammatici testimoni di un’alienazione precoce dei bisogni. Più spesso, l’incidenza del conflitto strutturale familiare si incrementa progressivamente nel corso della crescita, soprattutto in rapporto alle crisi di opposizione, giungendo al massimo grado all’epoca dell’adolescenza. Al di là di questo periodo, l’influenza della famiglia non viene meno, ma indubbiamente il modo di porsi del soggetto in rapporto ad essa e in rapporto al mondo assume un significato determinante.
Le “trappole” familiari analizzate dalla teoria dei sistemi non sono che apparentemente trappole comunicative: esse, in gran parte, si fondano sulla incapacità dei soggetti coinvolti di distinguere, in se stessi, negli altri e nelle relazioni, quanto attiene ai livelli superegoici da quanto attiene i livelli egoici. Si tratta, in altri termini, di trappole sovradeterminate dalla logica superegoica del padrone e del servo, che frustrano i tentativi, pur ricorrenti, dei soggetti di interagire sul registro della comprensione e della solidarietà.
II secondo problema, definito dall’affiorare del disagio in un figlio piuttosto che in un altro richiede una risposta articolata. Occorre tenere conto di due fattori, gli uni casuali gli altri predisposizionali, concorrenti nel trasformare una situazione congiunturale familiare in esperienze psicopatologiche. I fattori casuali sono riconducibili all’identità biologica, all’ordine di genitura, all’intervallo tra le nascite, al numero dei figli, a circostanze particolari quali malattia e morte di un membro genitoriale, separazione dei coniugi, cambiamenti residenziali, vicissitudini socioeconomiche, ecc.
Tali fattori si possono ritenere casuali in quanto il ruolo che essi svolgono, talora determinante, dipende dalla incidenza che essi hanno sull’assetto, psicologico e sociale, del sistema familiare; il loro ruolo, pertanto, non essendo mai diretto, bensì mediato da un particolare sistema familiare, può essere definito di volta in volta ma non teorizzato.
I fattori predisposizionali sono, altresì, riconducibili genericamente alla ricchezza del corredo dei bisogni. Come si è detto nella prima parte, i bisogni sono complementari tra di loro, ma si manifestano, nella loro tensione reciproca che esprime il potenziale evolutivo individuale, in tempi diversi e a fasi alterne.
L’alienazione dei bisogni, che si può ricostruire all’interno di ogni esperienza di disagio psichico, induce ad ipotizzare un’originaria e vivace sensibilità “viscerale” che, in virtù dell’identificazione con gli adulti, induce una spiccata tendenza a conformarsi e a rispondere alle loro aspettative. Ciò implica una strutturazione del sentire che si modella in rapporto alle proscrizioni, alle prescrizioni e alle proposizioni superegoiche ambientali.
Non è superfluo ripetere che la matrice del Super-Io, ciò che ne rappresenta il calco, attiene la sfera emozionale, non quella cognitiva: solo in fasi successive dello sviluppo, questa matrice è destinata ad arricchirsi di contenuti culturali che la confermano e la ideologizzano.
Quanto più la sensibilità è vivace, e dà luogo alla introiezione delle aspettative superegoiche ambientali, tanto più, complementarmente, occorre ammettere che sia attivo il bisogno di opposizione. E’ evidente che lo scarto tra quelle aspettative e questo bisogno determina la struttura originaria della personalità. Tale scarto può evolvere secondo varie possibilità in rapporto alla plasticità dell’ambiente familiare, all’interazione con ambienti extrafamiliari e all’acquisizione di strumenti culturali critici che rendono possibile elaborarlo. Il fattore predisposizionale perché si definisca un’esperienza di disagio psichico non è dunque specifico, ma generico, coincidendo con un corredo ricco di bisogni. Se questo è vero, ed è tra l’altro confermato dall’intensità dei bisogni che, benché in forma alienata, sottendono in ogni esperienza psicopatologica, occorre guardarsi dall’esasperare tale affermazione in senso antipsichiatrico, giungendo ad attribuire ai disagiati psichici un significato testimoniale utopistico che essi non hanno e che non pretendono di avere. Indubbiamente non si dà un’esperienza psicopatologica se non a partire da un corredo ricco di bisogni, ma è infondato sostenere che un corredo di tal genere, dato lo stato di cose esistente, non può esitare che in un’esperienza psicopatologica.
Sono oltremodo rari i casi in cui il sistema familiare veicola una matrice conflittuale che non concede scampo al soggetto: in tali casi, tra l’altro, manifestazioni di disagio tendono ad affiorare precocemente, in età infantile. Più spesso, e fermo restando che l’alienazione dei bisogni prodotta dal sistema familiare rappresenta un momento necessario ma non sufficiente, occorre pensare ad una somma di circostanze sociali e culturali che rendono quell’alienazione irrimediabile, e nel senso di impedire una normalizzazione e nel senso di rendere impossibile un’elaborazione critica. Da questo punto di vista, almeno sino ad una certa età, la responsabilità della famiglia è indiretta, poiché consiste nell’operare scelte di ambienti extrafamiliari scuola, chiesa, ecc. a nome dei figli e nell’operare selettivamente, come filtro dei contatti con il mondo, delle informazioni.
Questa funzione indiretta, diaframmante, del sistema familiare in rapporto al mondo è massimamente evidente nei casi in cui la mentalità familiare, sia essa di matrice conservatrice o neoliberale, è di tipo elitario.
Il problema della predisposizione individuale postula un’ulteriore considerazione. Se esso, infatti, come noi sosteniamo, viene ricondotto ad un corredo ricco di bisogni, e cioè alle capacità di registrare ed interagire con i livelli contraddittori superegoici ed egoici dell’ambiente, c’è da chiedersi come mai, nei casi in cui si definisce un’esperienza psicopatologica, questa ricchezza potenziale non giunge ad organizzarsi sotto forma di presa di coscienza; come mai i soggetti che sviluppano una precoce opposizione viscerale ai sistemi di valori superegoici, finiscono con l’esserne vittime e, talora, con il diventarne implacabili funzionari. Questo problema, a nostro avviso, è di ordine eminentemente culturale, e il disagio psichico non fa altro che restituirlo amplificato, permettendo, tra l’altro, di apprezzarne la drammaticità.
Ancorata per la sua stessa struttura al registro del sentire, che permette di cogliere la doppia identità genitoriale, la coscienza infantile, nel suo ulteriore sviluppo, non riesce a dar senso a questa confusione, che può essere confermata dall’esperienza extrafamiliare, poiché la nostra cultura è, sostanzialmente, di tipo personalistico. L’astuzia del mito gerarchico, nelle sue diverse versioni, consiste proprio nel trasmettersi attraverso persone e legami interpersonali significativi, mascherando la sua disumanità sotto “volti” umani. La “rivoluzione” psicoanalitica, che ha operato il decentramento della soggettività in rapporto alla coscienza, non ha prodotto ciò che essa non intendeva produrre: la consapevolezza del carattere sovrastrutturale della coscienza in rapporto alla storia sociale e personale sedimentata, sotto forma di conflitto tra Super-Io e bisogni alienati, nella struttura profonda della personalità. Gli uomini sanno, bene o male, dell’esistenza dell’inconscio individuale; nulla o poco sanno dell’inconscio sociostorico, dell’ininterrotto dialogo con la tradizione e il potere di cui ciascuno di essi è un interlocutore costretto inesorabilmente, e in una misura diversa da soggetto a soggetto, a parlare un linguaggio mortificante. Al di là delle fasi evolutive della personalità, l’importanza dei fattori ambientali, ai fini del definirsi di un’esperienza di disagio psichico, non può essere considerata indipendentemente dall’attività del soggetto e dall’attrezzatura culturale di cui egli dispone per interpretare i fatti della vita, e, cioè, in ultima analisi, dalla matrice conflittuale che sottende la sua personalità e dalle sovrastrutture ideologiche che la mascherano.
Un determinismo soggettivo radicale è, teoricamente, improponibile, ogni uomo dovendosi muovere comunque entro un orizzonte e uno spazio storico determinato. Per fare un solo esempio, un giovane che, preda di un delirio di vulnerabilità, si ritira in casa e si isola per anni da qualunque interazione con il mondo esterno, determina la sua condizione di vita usufruendo almeno di tre possibilità offerte dall’ambiente: la convivenza familiare, la privacy domestica e una progettazione sociale che, in nome di un valore astratto di libertà, trascura la “scomparsa” di un membro, ritenendola un suo diritto, se essa non turba l’ordine pubblico. È fuor di dubbio, però, che un determinismo soggettivo relativo ha una grande importanza dal punto di vista psicopatologico. Pur muovendo da presupposti che sfuggono alla coscienza, e cercando, solitamente, di confermare, piuttosto che di mettere in crisi, un sistema di valori astratto, un soggetto, operando, a partire dall’insieme delle opportunità che gli vengono offerte, scelte di vita, di rapporto, di lavoro, di organizzazione del tempo libero particolari può costruire un “suo” mondo e un modo di essere che, frustrando i bisogni suoi, inesorabilmente promuoveranno un’espressione psicopatologica del conflitto strutturale latente.
Molte esperienze di disagio psichico che insorgono in età adulta, dopo periodi di vita più o meno lunghi apparentemente normali, o anche singolarmente produttivi da un punto di vista personale, familiare e sociale, sono da ricondurre ad una progettazione incentrata sulla percezione soggettiva di un pericolo il più spesso di impazzire ch’essa, nonché scongiurare, finisce, per alcuni aspetti, con il realizzare.
Pur valutando adeguatamente il determinismo soggettivo, non occorre mai dimenticare che, essendo la nostra società strutturata dal mito gerarchico, ogni ambiente offre, oggettivamente, la possibilità di essere utilizzato per mortificare, piuttosto che liberare i bisogni umani. Ciò non significa che si debba ritenere il nostro mondo incline o predisposto a produrre disagio psichico: di fatto, esso è predisposto a normalizzare, e cioè, con i suoi codici astratti, a fornire alimento ad un’attività soggettiva che, in rapporto ad un conflitto strutturale che la sottende, dovrebbe prescindere da essi e procedere in tutt’altra direzione per integrarsi.
Da ultimo, non si può non far cenno al problema degli eventi di vita traumatici, casuali e del tutto indipendenti dall’attività del soggetto, cui la psichiatria contemporanea rivolge una particolare attenzione tendenziosa, mirando a confermare che, a parità di condizione, coloro che crollano in crisi psicopatologiche in conseguenza di quegli eventi appartengono alla categoria degli esseri costituzionalmente vulnerabili. La tavola di tali eventi, corredato ciascuno dal suo potenziale di rischio statistico, è null’altro che l’elenco di tutte le possibili sventure che, nel corso della vita, possono capitare agli uomini. C’è un dato comune ad esse, che la psichiatria multidimensionale, orientata a quantificare la forza di carattere individuale, ignora: tutti quegli eventi, realizzando una condizione oggettiva di sofferenza, pongono alla prova, nonché la resistenza psicologica (o biologica) dell’individuo, anche le forme di partecipazione della società alle sofferenze di un suo membro, e cioè la solidarietà.
Non si può escludere che coloro che crollano sotto il peso delle disgrazie, siano vulnerabili; di certo, il loro crollo testimonia anche una variabile la solidarietà, appunto difficilmente apprezzabile entro un’ottica clinica. Il mondo reale nelle sue strutture economiche, sociali, mentali determinate storicamente è la macula cieca di una scienza presuntuosa a misura della sua impotenza.
Capitolo nono
La politica del Super-Io
L’intento di delineare una teoria psicopatologica strutturale e dialettica si può ritenere a questo punto, nei limiti imposti dall’economia di un saggio, realizzato. Nei saggi successivi, come si è anticipato nell’Introduzione, alcuni aspetti di ordine sia teorico che clinico e terapeutico, cui si è appena accennato, saranno approfonditi. Siamo consapevoli che l’orizzonte dei problemi affrontati è tale da eccedere le nostre competenze, e richiederà, per essere esplorato e corroborato, un ampio lavoro interdisciplinare. Ciononostante, riesce difficile negare che la struttura della teoria eccede l’ambito dei fenomeni di disagio psichico e evoca una serie di problemi che ineriscono i modi in cui l’organizzazione sociale, a tutti i suoi livelli, risponde alla dialettica dei bisogni, e quindi l’uso che ne fa.
La predisposizione sociale della natura umana, riconducibile ad una forma a priori superegoica che postula l’integrazione e la condivisione dell’esperienza del gruppo di appartenenza, rappresenta una potenziale ricchezza che, per difetto di circostanze ambientali e di strumenti culturali atti a promuoverne la soppressione dialettica e a favorire la nascita di una coscienza morale critica, può tradursi con facilità nella miseria dell’alienazione, che si esprime nel vivere secondo codici normalizzanti introiettati ma non assimilati o nell’opporsi sterilmente ad essi finendo in un vicolo cieco psicopatologico.
Per Politica del Super-Io intendiamo, per l’appunto, l’uso collettivo, sociale e mentale, di queste potenzialità. E’ chiaro che l’uso migliore, che per ora appartiene all’ambito dell’utopia, consisterebbe in un uso dialettico, nel fornire cioè ad ogni individuo la possibilità e l’attrezzatura atte ad integrarlo socialmente e a disalienarlo, e cioè a porlo in grado di dotarsi di una coscienza morale critica. Sinora, l’uso che ne è stato fatto nel corso della storia umana, nonostante indubbi progressi realizzati sempre al prezzo di drammatiche crisi della struttura sociale, è di tutt’altro segno. La politica del Super-Io è consistita nel mantenere il bisogno di opposizione vincolato il più possibile alle sue originarie modalità viscerali, in maniera che esso, impedito nell’assumere una configurazione critica, a livello di coscienza individuale e sociale, si ritorce contro i soggetti sotto forma di stigma colpevole di asocialità e di amoralità. Tale critica ha investito le singole individualità non meno che i gruppi sociali oppositivamente motivati, la storia dei costumi sociali non meno che la storia della scienza e della cultura.
È giusto, dunque, interrogarsi sui motivi e sul significato di questa tendenza costante dell’organizzazione sociale a criminalizzare il bisogno di opposizione, tendenza che, nelle società avanzate a regime democratico, è ancora attiva, nonostante quel bisogno sia riconosciuto formalmente come essenziale ai fini della dialettica e dell’evoluzione sociale.
La prima, e più ovvia, ipotesi verte sul bisogno di coerenza, proprio di ogni struttura sociale, funzionale al fine di assicurare ad essa un’identità culturale che consenta ai singoli individui, nonostante le loro differenze, di riconoscersi come appartenenti ad un gruppo e di condividere, partecipando ad essa, una comune esperienza economica, sociale e mentale. Tale bisogno, fondandola e specificandola storicamente, avrebbe anche l’effetto di determinare una tendenza inerziale della struttura sociale, che si opporrebbe, a tutti i livelli da quello economico a quello mentale ai cambiamenti, investendoli di significati destrutturanti piuttosto che potenzialmente evolutivi.
Tale ipotesi è inconfutabile, nel senso che mette a fuoco un bisogno costitutivo di ogni struttura sociale, ma non esauriente. C’è un dato, infatti, che investe la storia umana e che non può essere misconosciuto, e cioè che quel bisogno, che rappresenta una forma a priori superegoica che presiede l’integrazione sociale di qualunque gruppo, si realizza concretamente per mezzo di sovrastrutture ideologiche che razionalizzano e naturalizzano gli ordinamenti economici, sociali e culturali prodotti dalla storia sociale, al fine di metterli al riparo da ogni opposizione critica. Se la tendenza inerziale è un dato intrinseco di ogni struttura sociale, e posto che quella tendenza si interpreti, analogamente al principio della fisica, in termini di quiete o di moto uniforme, il modo in cui essa si realizza a livello storico appare imprescindibile dalle ideologie sociali, che sono e la lezione di Marx, a riguardo è inconfutabile prodotte dai ceti dominanti.
Ciò significa che la criminalizzazione del bisogno di opposizione, seppure esprime genericamente la paura di cambiamenti strutturali, è anche programmata ideologicamente, in ogni società, al fine di mantenere il più possibile l’ordine di cose esistente apparentemente in nome dell’armonia sociale e del bene comune, di fatto a vantaggio dei ceti dominanti.
La politica del Super-Io, in breve, utilizza la predisposizione della natura umana alla socialità per produrre consenso collettivo in rapporto ad un ordine che si fonda sulla disuguaglianza tra gli esseri umani. Per ciò, essa si può definire a ragione universalmente funzionaria del mito gerarchico, il cui ordinamento, che postula un potere diverso maggiore o minore riferito ai diversi ruoli sociali, essa avalla e naturalizza ideologicamente, al fine di mantenere, in nome del principio della condivisione dell’esperienza comune, l’armonia sociale, e di estinguere, meno con la repressione che con il consenso, le potenzialità conflittuali dovute alla disuguaglianza. La valutazione della politica del Super-Io è, dunque, subordinata, in linea generale alla necessità oggettiva della gerarchia sociale ai fini del buon funzionamento della struttura sociale e, in riferimento ai modi in cui essa si è espressa e si esprime storicamente, al rapporto tra costi e vantaggi, e cioè alla quota di bisogni umani che essa richiede di sacrificare, in nome del bene comune, sull’altare dell’integrazione sociale alienata, del rispetto di regole, norme e valori introiettati che vanno riconosciuti come sacri, e dunque posta in essere, nonostante un eventuale disaccordo soggettivo.
In ultima analisi, il problema, sia pure semplificato, consiste nello stabilire se il mito gerarchico, le cui origini coincidono con il processo dell’antropogenesi e della sociogenesi, serve a ratificare una disuguaglianza oggettiva, un diverso valore degli esseri umani, che giustifica una diversa distribuzione del potere, dei privilegi e delle risorse, nonostante una comprensibile opposizione viscerale da parte dei ceti subordinati, o adempie piuttosto la funzione di amplificare ideologicamente quella disuguaglianza per porla al riparo da conflitti miranti a ricondurla entro limiti oggettivi. Il riconoscimento, ormai comune a livello scientifico, della diversità genetica tra gli esseri umani, non risolve, in sé e per sé, questo problema, poiché ciò che manifestamente è in discussione è il grado di corrispondenza tra genotipo e fenotipo, tra potenzialità genetiche e realizzazione di tali potenzialità. La prima ipotesi ritiene probabilisticamente, e non senza eccezione dunque, elevato tale grado; la seconda, viceversa, comporta il dubbio che esso corrisponda ad un processo di alienazione in senso marxista, e cioè ad una penetranza genetica dovuta ad assetti della struttura sociale che la determinano a favore di alcuni al prezzo dell’impoverimento delle potenzialità di altri.
La varietà, nel corso della storia, delle strutture sociali e dei criteri di gerarchizzazione non facilita la soluzione di questo conflitto tra ipotesi, sia pure spogliato delle sue risonanze ideologiche e posto su di un terreno scientifico.
E’ fuor di dubbio che la gerarchia sociale corrisponde a criteri in una certa misura oggettivi laddove, come presso i primitivi, si danno contesti sociali faccia a faccia, che consentono la valutazione delle qualità personali in nome di un’interazione diretta tra i membri del gruppo. Inferire da ciò che la complessificazione quantitativa e qualitativa della vita sociale, che segue la nascita della storia, non abbia comportato rilevanti cambiamenti in un processo selettivo culturale consolidatosi in un tempo sterminato, appare arbitrario. E’ oltremodo probabile che, nel corso della storia, ci sia stato un periodo critico decisivo in cui coloro che detenevano il potere e ambivano a mantenerlo e, ancor più , a trasmettere ereditariamente i privilegi siano riusciti, con raffinati strumenti ideologici di cui essi soli disponevano, a sottrarsi al controllo sociale.
Il mito biblico del potere supremo divino attaccato, per invidia, dal demonio, rappresenta una ideologizzazione di una “mutazione” culturale realmente accaduta. Non è lecito ignorare le circostanze oggettive demografiche, economiche, sociali, ecc. che possono aver contribuito ad indurla. Rimane il fatto che, in virtù di essa, il riconoscimento sociale di qualità Super-Iori è venuto meno in nome della necessità di sottomettersi ad un potere autodivinizzatosi che, occultandole, ha amplificato a dismisura quelle qualità rendendole incommensurabili. In seguito a questa mutazione, il bisogno di opposizione, orientato a definire la pari dignità degli esseri umani al di là del diverso valore individuale, è stato identificato come ribellione colpevole nei confronti di un ordine sacro.
Sarebbe oltremodo interessante ricostruire la storia del mito gerarchico, di questo recinto mentale che, per effetto della forma superegoica a priori rende sempre troppo lenti i processi di ristrutturazione sociale in rapporto al capitale dei bisogni umani e nel contempo, periodicamente, li accelera rendendoli turbolenti ed esplosivi. Le previsioni, errate, di Marx di un definitivo superamento di quel mito in conseguenza di una ristrutturazione, inesorabilmente esplosiva, finale, che avrebbe inaugurato una nuova storia, fondata su di un ordinamento rispettato e alimentato da individui liberi, dotati cioè di una coscienza morale critica, non hanno tenuto conto della potenza ideologica, più ancora che economica e sociale, del mito gerarchico, del suo riprodursi attraverso i processi di socializzazione e, soprattutto, di una “mutazione” culturale, alla sua epoca latente, la cui importanza risulterà, nel tempo, forse pari alla divinizzazione del potere monarchico che lo ha inaugurato.
Giunto agli estremi limiti di una crisi destrutturante, il mito gerarchico corporativo, fondato ideologicamente sul riferimento ad un sistema di valori sovraindividuali, rappresentati dal potere, la cui ultima e drammatica espressione è stata il nazionalsocialismo, si è trasformato in seduttivo, rendendo il potere - economico, sociale, culturale un miraggio accessibile a tutti all’unico prezzo del rispetto delle regole del gioco sancite ideologicamente come oggettive.
Ciò è avvenuto in virtù dell’ideologia meritocratica, che, orientata in passato praticamente solo a sancire la giusta punizione per i ribelli, si è dispiegata mobilitando la struttura sociale ad assegnare un premio ai consenzienti.
E’ difficile negare che, anche sotto questo profilo, il mito gerarchico, modernizzandosi, abbia conservato integralmente le sue matrici religiose, rendendole però ideologicamente più insidiose. Nonché negare la disuguaglianza, l’ideologia meritocratica contemporanea la fa ricadere nell’ambito della responsabilità personale e identifica la collocazione gerarchica di ogni individuo con l’espressione oggettiva dei suoi meriti e demeriti.
A ciascuno è offerto di ambire all’ascesa sociale: la mobilità senza apparente sbarramento tra categorie sociali rappresenta l’aspetto rivoluzionario del nuovo mito gerarchico. Ma l’ascendere, conseguendo un prestigio e un potere vieppiù crescenti, è subordinato all’accettazione e alla pratica di un sistema di valori che si può giudicare perverso poiché esso impone l’ossequio nei confronti delle autorità, il conflitto competitivo con i pari, e un atteggiamento sprezzante nei confronti di chi è più in basso. I codici mentali, analizzati in precedenza condensano questo sistema di valori, e integrano nel complesso un quadro mentale per definire il quale non è improprio parlare di neodarwinismo sociale edulcorato. Alla luce di tale quadro mentale, tutto ciò che, nella natura umana impedisce la compiuta espressione dell’individualità, l’accettazione razionale del principio della competitività, viene ad essere identificato come debolezza infantile, inadeguatezza, demerito. Cosa ricade in questo ambito? La sensibilità, intesa come tendenza ad identificarsi con l’altro, che può compromettere la necessità di usarlo come strumento o oggetto della propria realizzazione.
In questo uso non si vede nulla di immorale, purché esso si mantenga nei limiti della legalità, poiché le regole del gioco non impediscono a chicchessia di difendersi o di perseguire un intento simmetrico. Chi non riesce a dominare, soffocare o anestetizzare la sensibilità, non è che in apparenza posto fuori del gioco: in realtà, si pone egli stesso fuori del gioco.
Un’obiezione, che vale la pena di anticipare, essendo essa ampiamente ventilata, è la seguente. Se gli uomini, nella stragrande maggioranza, accettano di concorrere ad una situazione sociale che impone la mortificazione della sensibilità, ciò non attesta forse una predisposizione naturale complementare a questa, che comporta la possibilità di trattare l’altro come un mezzo e non come un fine? Quale altra ipotesi può spiegare questo fenomeno? Un’ipotesi che lo storicizza.
L’astuzia del mito gerarchico maturato nel corso dell’ultimo secolo all’interno della civiltà occidentale consiste nell’avere indotto, collettivamente, la fobia di una condizione sociale che esso, al suo esordio, ha prodotto, sia pure ereditandone le premesse dal passato: la condizione della miseria, intesa come condizione di assoluta dipendenza e precarietà, intimamente associata alla schiavitù, alla vergogna, alla malattia, alla corruzione. E’ questo fantasma fobico, che inquieta ormai tutte le esperienze soggettive, a funzionare come terreno predisposizionale su cui attecchisce agevolmente il mito gerarchico contemporaneo, e a sollecitare la struttura sociale, minacciata costantemente dalla recessione, spettro simbolico di depressione e di morte, verso un regime che si può definire, senza remore, maniacale. Ciò che Marx non ha previsto, né poteva prevedere, è che quel fantasma, anziché attivare la ribellione dei subjecti nei confronti di una struttura sociale e mentale che si alimenta della precarietà che produce, attivasse un’ universale sottomissione al mito gerarchico animata dalla speranza di un riscatto individuale.
La trasformazione del mito gerarchico da repressivo in seduttivo, e la sovrapposizione dei due miti nell’ambito del quadro mentale contemporaneo, permette di comprendere la ristrutturazione ideologica della politica superegoica.
Essa continua a reprimere il bisogno di opposizione, ma, al contempo, mira a pervertirlo in un’aggressività competitiva, funzionale alla realizzazione di un bisogno di integrazione sociale orientato verso un ideale dell’ Io onnipotente, affrancato dal fantasma della precarietà, della schiavitù e del dolore. Nonché asociale ad amorale per natura, l’ uomo è irretito nella trappola superegoica del bisogno irrinunciabile di integrazione sociale, in nome del quale è disposto a sacrificare il bisogno di opposizione, che gli è concesso vivere sotto forma di cieca volontà di affermazione contro tutto e contro tutti. Questa perversione del bisogno di opposizione implica, come si è detto, una omologa perversione del bisogno di integrazione sociale che, scisso dalla sensibilità e animato di aggressività competitiva, promuove la sottomissione a chi ha potere, l’identificazione con essi e la tendenza a sopraffare o a trattare come oggetto i più deboli. Piegandosi alla nuova morale dell’ascesa sociale e del rifiuto della sensibilità che la ostacola, la politica superegoica oggi rivela come non mai la sua funzione meramente conservatrice dello status quo e la sua sostanziale indifferenza a valori autenticamente morali.
Non abuseremo di categorie psicopatologiche se definissimo questa politica, e ovviamente il mito gerarchico che in virtù di essa fa presa sulle esperienze soggettive, come “paranoica”: preda di un ideale d’onnipotenza dell’ Io, essa, infatti, si sente minacciata da tutto ciò che contrasta il perseguimento dell’ onnipotenza. Dalla natura umana stessa, dunque, che si oppone alla sopraffazione dell’uomo sull’uomo, e, di conseguenza, da ogni cultura, ideologia o movimento politico che, in nome dei bisogni umani, l’attacca.
Gli storici che hanno dedicato, più di tutti gli altri studiosi di scienze umane e sociali, la loro attenzione ai quadri di mentalità, sanno bene che in rapporto agli altri livelli strutturali della realtà i livelli economici e sociali - essi evolvono con una straordinaria lentezza, sovrapponendosi tra loro, condensandosi in nome di alcuni elementi comuni, investendo e appropriandosi di diverse aree sociali. Il passaggio dal mito gerarchico repressivo al mito gerarchico seduttivo conferma puntualmente ciò.
L’elemento in comune tra i due quadri mentali, che appare indispensabile ad entrambi, è la stigmatizzazione dell’opposizione come ribellione ad un ordine armonioso che essa pone in gioco, e la necessità di sanzionarla con la punizione e/o con l’autoemarginazione. i diversi sistemi di valore l’uno di matrice religiosa, l’altro di matrice laicoliberale permettono, però, di comprendere che, nonché di una crisi di valori, come si è già detto, nella nostra civiltà occorre parlare di un eccesso di valori eterogenei, accomunati solo dall’intento di promuovere l’assoggettamento dell’Io al mito gerarchico. L’universo psicopatologico, proprio per la sua capacità, rivelata da Freud, di funzionare come un cristallo frantumato, offre le prove più convincenti di quell’eccesso.
In questo universo, la repressione pulsionale, che, in realtà, è la repressione di bisogni alienati e frustrati, vissuta come necessaria al fine di mantenere un minimo di integrazione sociale, e cioè una maschera atta a celare l’animalità istintuale, appare funzionale al progetto di liberare le energie pulsionali nella direzione di un’affermazione onnipotente dell’Io, che riconosce come limite unico il rispetto formale della legge. In altri termini, la repressione dell’opposizione, apparentemente dovuta a motivi reali, mira in realtà a pervertirla in aggressività competitiva, in energia atta a giocarsi la vita secondo le regole del gioco meritocratico. Questo progetto non sempre funziona: in una quota rilevante di soggetti, la repressione determina ancora un blocco dell’opposizione e dell’aggressività, e cioè gli effetti che il vecchio mito gerarchico mirava a conseguire. Ma si tratta di effetti non più programmati e nemmeno auspicati dal nuovo mito gerarchico, per quanto anche essi possano essere utilizzati per confermare che chi non si dà da fare e non riesce ad ascendere socialmente si pone fuori gioco per suo demerito. Sono questi gli effetti che più costantemente si realizzano nelle strutture di personalità che esprimono un disagio psichico, e, nonché compensati dall’adozione dei codici mentali normativi, risultano esasperati e, in ultima analisi, patetici.
Il dramma dell’universo psicopatologico contemporaneo è lo scarto rilevante tra il modo di essere reale, determinato dal Super-Io repressivo e punitivo, e le fantasie che tendono a rimediare all’impotenza prodotta da quel modo di essere, che appaiono sempre più vincolate a valori astratti di onnipotenza, di libertà, di prestigio sociale e di durezza di cuore, determinati da un ideale dell’Io superegoico.
Che senso ha, infine, questo scarto?
L’ipotesi dominante sottolinea l’inadeguatezza, che questo scarto segnala, tra mezzi e fini, tra potenzialità personali reali e desideri. Il che significa, in altri termini, che coloro che non si mettono alla prova perché sanno già che riuscirebbero sconfitti e relegati in ruoli subordinati, preferiscono coprire questa realtà inaccettabile soggettivamente con sterili fantasie. Si tratterebbe, in fin dei conti, di esseri geneticamente e psicologicamente tarati, vulnerabili, fragili, timorosi o addirittura codardi che rifiuterebbero di riconoscere la loro appartenenza ad una categoria votata inesorabilmente all’estinzione selettiva.
A noi sembra piuttosto che coloro che soffrono di un disagio psichico sono non già gli unici ma di certo i più tragici e per giunta inconsapevoli testimoni di un’alienazione dei bisogni che viene subìta ma non accettata.
Esseri il cui corredo, il più spesso ricco, di sensibilità e di reattività oppositiva, distorto dalle interazioni con l’ambiente, li vota ad un’atroce condanna, poiché la sensibilità, non potendo essere anestetizzata, li determina ad essere schiavi delle aspettative altrui, mentre l’opposizione, non potendo essere soffocata ma neppure realizzata, si traduce in una rabbia che viene agevolmente criminalizzata dal Super-Io, che impone così la sua dittatura. L’unico rimedio contro questa dittatura che, trattando l’Io come un oggetto, gli impedisce di vivere, è sognare un riscatto totale. Che questo riscatto, poi, si alimenti dei codici mentali che il mito gerarchico contemporaneo propone a tutti, non sorprende. Ciò che sorprende, casomai, è che quei valori proposti dai suddetti codici non possono essere agiti, poiché essi ripropongono, con contenuti diversi, la logica del Padrone e del Servo, che i soggetti affetti da disagio psichico hanno di fatto subìto e introiettato sotto forma di rapporto di potere tra Super-Io e Io. Essi, di conseguenza, non possono calarsi stabilmente in nessuno dei due ruoli che quella logica comporta. Se assumono, infatti, un atteggiamento dominante nei confronti di qualcuno sentono la sofferenza che inducono e si colpevolizzano; se, viceversa, tentano di arrendersi ad un ruolo subordinato sviluppano una rabbia furibonda che giunge egualmente a colpevolizzarli.
E’ dunque la connotazione radicalmente negativa della sensibilità, intesa come debolezza, influenzabilità, iperemotività, inadeguatezza, la chiave su cui si è articolato il mito gerarchico contemporaneo. La sua rimozione viene culturalmente sollecitata in nome di un ideale dell’Io perfettamente razionale, autocontrollato, pragmatico e sanamente egoista. Un ideale dell’Io laico e illuminista che dovrebbe funzionare come una sorta di intelligenza artificiale. La politica del Super-Io consiste nel promuovere, con la strategia del bastone e della carota, l’adesione collettiva a questo ideale dell’Io e nel programmare una produzione di uomini orientata in questa direzione.
McLean (1) erede inconsapevole di Rousseau, ha già anticipato la mostruosa mutazione culturale che quel mito persegue: la trasformazione di ogni uomo in un computer programmato per agire alla luce di un calcolo tra costi e benefici riferito solo ai bisogni propri. Si danno ormai prove molteplici e drammatiche della capacità che la cultura ha di inattivare la possibilità di integrazione tra strutture emozionali e strutture cognitive, che, mantenendo e alimentando il legame di identificazione con l’altro, assoggettano la programmazione comportamentale alla soddisfazione dei bisogni propri nel rispetto e nel riconoscimento dei bisogni altrui. Il mito neoliberale che associa all’ottimizzazione delle risorse individuali un beneficio collettivo, benché non infondato, trascura il fatto che tale beneficio si fonda sull’assunzione degli altri come fini e non come mezzi, e che tale assunzione postula una cultura e un’organizzazione sociale che coltivi, e non scinda, l’integrazione tra strutture emozionali e strutture logiche. Nei camuffamenti ideologici sinora adottati, e in particolare in quelli attuali, pericolosi perché massimanente ingannevoli, il mito gerarchico appare fondato e realizzato in virtù di una scissione che mortifica ed estranea le potenzialità proprie, socialmente partecipative e dialetticamente oppositive, della natura umana.
Non è superfluo forse specificare che le riflessioni esposte in questo capitolo, benché coerenti con il progetto di una psicopatologia contestuale, orientata a vagliare criticamente gli effetti alienanti dei codici di normalizzazione propri del sistema sociale cui fa riferimento, non sono essenziali ai fini della verifica (o della falsificazione) della teoria psicopatologica proposta, che, in sé e per sé, comporta solo il riconoscimento del drammatico debito che i soggetti disagiati contraggono con la natura umana per un verso e con il gruppo d’appartenenza per un altro.
Nessuna società, per questo aspetto, si può ritenere neutra; a maggior ragione, nessuna metateoria sociale può esserlo.
Glossario
L’esigenza di un Glossario* muove dall’interno della ricerca che, nel tentativo di organizzare una rete concettuale, ha preso in prestito i termini dalle scienze biologiche, umane e sociali, dando ad essi, il più spesso, nuovi significati. L’organizzazione della ricerca sotto forma di sistema teorico ha pertanto prodotto un campo semantico eccessivamente ricco di sfumature, e potenzialmente equivoco, II presente glossario mira a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di fraintendimenti, senza alcuna pretesa di essere esauriente. Ulteriori approfondimenti delle “voci” qui trattate, e della loro estensione semantica e concettuale, saranno forniti in ulteriori lavori.
*Il Glossario segue la logica dell’esposizione interna al saggio. Le glosse, nell’ordine in cui appaiono, ricapitolano gli aspetti tecnici della trattazione interna.
Bisogni fondamentali
Forme affettive innate, riconducibili a programmazioni filogenetiche delle strutture sottocorticali (sistema limbico) che, attivate dall’interazione con l’ambiente, animano la coscienza “viscerale” di sé e dell’altro e, funzionando come attrattori psicobiologici, orientano lo sviluppo della personalità verso la definizione di un’identità personale differenziata, capace di interagire dialetticamente con l’ambiente sociale sul registro dell’integrazione che privilegia l’appartenenza dell’individuo al sistema , e dell’opposizione che privilegia la libertà personale (sia pur sempre relativa) in rapporto ad esso.
Invariante nella dotazione binaria, il corredo dei bisogni è rappresentato nei patrimoni genetici individuali secondo combinazioni le più varie riconducibili, forse, ad una curva gaussiana, ai cui estremi prevarrebbero tendenze “introversive” all’individuazione e tendenze “estroversive” all’integrazione sociale.
I bisogni fondamentali sono, dunque, predisposizioni genetiche, affettivamente connotate, all’appartenenza sociale, che implica l’acquisizione e la condivisione di un patrimonio comune di valori culturali; e all’autocoscienza, che implica l’assimilazione selettiva, e dunque in qualche misura critica, degli stessi. Non è azzardato pensare che tale assimilazione, che si realizza di fatto in virtù di strumenti cognitivi, si fondi su valori affettivi innati quali la giustizia, la libertà, la pari dignità tra esseri umani che configurano un codice psicobiologico di diritti naturali.
In quanto forme affettive, i bisogni fondamentali rappresentano gli assi di strutturazione della personalità e definiscono, in termini di equilibrio/squilibrio strutturale, i limiti funzionali di essa.
Dal punto di vista strutturale, i bisogni, irradiati dai centri sottocorticali, funzionano come attrattori che organizzano il caos dei flussi di informazione di origine intrinseca ed estrinseca in mappe cerebrali che, connettendo reciprocamente le strutture sottocorticali e le strutture corticali, consentono l’integrazione cognitiva delle forme attive. Dal punto di vista funzionale, che coincide con l’attività psichica, conscia e inconscia, tale integrazione promuove la significazione dell’esperienza soggettiva e il definirsi di sistemi di significati che categorizzano il sé, l’altro e le configurazioni relazionali ago/antagonistiche più o meno dialettiche tra sé e altro.
La dinamica fasica dei bisogni in perpetua tensione dialettica e gli spazi sociali dai livelli microsistemici interattivi agli orizzonti socioculturali entro cui essa si dispiega, fanno sì che le mappe cerebrali vadano incontro a processi di arricchimento e ristrutturazione, che esitano costantemente nella definizione di due sistemi di significati e di significazione: l’uno concerne l’appartenenza sociale e il debito di appartenenza, il dover essere dell’individuo in quanto membro sociale, parte di un tutto; l’altro, l’identità personale, l’autocoscienza della differenziazione e della relativa autonomia rispetto al contesto sociale, il dover essere dell’individuo in quanto soggetto dotato di libertà. Tali sistemi, sottesi dalla dinamica dei bisogni, che, come attrattori, continuano a funzionare al di là dell’epoca evolutiva, definiscono, con il loro grado di complementarietà e/o di conflittualità, la fenomenologia dell’esperienza soggettiva e della visione del mondo interno ed esterno su cui essa fonda la propria stabilità strutturale.
Bisogno di appartenenza/Integrazione sociale
Forma emozionale a priori che organizza i dati dell’esperienza soggettiva su di un registro sistemico, che privilegia l’insieme sulle parti, le relazioni sugli enti in relazione, e categorizza pertanto l’individuo in funzione del gruppo di appartenenza.
Originariamente, si esprime sotto forma di aggrappamento e di identificazione fusionale con l’ambiente. Tale legame sociale primario comporta un flusso di informazioni emozionali e cognitive che attivano la coscienza viscerale dell’altro e la coscienza viscerale di sé come funzione della relazione con l’altro. Lo strutturarsi di mappe cerebrali consente la discriminazione categoriale dell’altro e la definizione alienata di sé. Tale alienazione, che comporta una persistente identificazione con l’altro, favorisce, per mezzo dei legami affettivi, l’introiezione di moduli comportamentali e di codici culturali propri dell’ambiente sociale. L’integrazione di tali codici, confusi con le persone che li trasmettono nella forma a priori della socialità sistemica, dà luogo, in conseguenza del definirsi di mappe cerebrali che connettono il sistema limbico alla corteccia, alla funzione superegoica, sistema di significati che orienta l’Io verso un dover essere funzionale alle aspettative ambientali e all’economia sistemica del gruppo di appartenenza.
L’allargamento dell’orizzonte esperienziale, che comporta l’integrazione di nuovi dati emozionali, cognitivi e ideologici, può indurre successive ristrutturazioni della funzione superegoica e dei codici che essa veicola, talora anche a carattere qualitativo, ma sempre e solo entro la logica sistemica della forma a priori, che postula da parte del soggetto di rispondere sempre e comunque a “qualcuno” assunto come rappresentante della totalità sociale, del proprio comportamento.
Il limite critico del bisogno di “integrazione” sociale, se esso rimane vincolato alla funzione superegoica, è che questo “qualcuno” può rappresentare semplicemente un ambiente locale, philum di una storia sociale parziale non immune da valenze alienate. L’alienazione costitutiva della funzione superegoica si risolve se e solo se il soggetto è in grado, emotivamente e culturalmente, di oggettivare i codici culturali propri del gruppo di appartenenza, sociostoricamente determinati, che lo indebitano e di assimilarli selettivamente. Se ciò avviene, la forma a priori sistemica può promuovere il riconoscimento dell’appartenenza non già solo ad un gruppo (dalla famiglia alla comunità linguistica) bensì ad una specie differenziata in etnie e culture diverse.
Bisogno di opposizione/Individuazione
Forma emozionale a priori che veicola una coscienza viscerale di sé come parte distinta rispetto all’insieme, dotata di diritti naturali (pari dignità, giustizia, libertà) corrispondenti a valori innati, e che promuove, pertanto, attraverso l’integrazione dei dati esperienziali, lo sviluppo e la differenziazione dell’individualità, qualificando alla luce di quei valori, il sistema di relazioni cui l’individuo appartiene.
Originariamente, e complementarmente al definirsi dell’Io sul registro dell’identificazione alienata, si esprime sotto forma di opposizione, il più spesso apparentemente irrazionale, della volontà propria alla volontà altrui. Nel corso delle fasi evolutive, per integrazione di dati emozionali e cognitivi nella forma a priori, che danno luogo allo strutturarsi di mappe cerebrali che categorizzano un’immagine di sé distinta dall’ambiente sociale, il bisogno di opposizione si ripresenta fasicamente e criticamente inducendo catastrofi dell’identità sociale alienata, ciascuna delle quali promuove, attraverso una ristrutturazione delle mappe cerebrali e dei sistemi di significati che categorizzano sé, l’altro e le reciproche relazioni, una differenziazione dell’Io autocosciente e un aumento del grado di libertà e di autonomia sia morale che ideologica dell’individuo rispetto al sistema sociale di appartenenza. Nel tempo, dunque, l’opposizione diventa sempre più funzionale al’individuazione, e cioè al definirsi di una personalità dotata di un sistema di valori assimilato, di una coscienza morale critica, capace di dar conto a se stessa prima che agli altri dei propri comportamenti, e di valutarli alla luce dei codici culturali “privati” che informano i valori innati di pari dignità, giustizia, libertà.
II limite critico del bisogno di opposizione/individuazione è rappresentato dal fatto che quei codici possono risultare contraddittori rispetto ai valori innati e nondimeno essere convalidati ideologicamente dalle emozioni che li sottendono.
Al di là delle fasi evolutive, l’individuazione, nonché estinguersi, può dar luogo a ulteriori ristrutturazioni dei sistemi di significati che definiscono l’autonomia e la libertà dell’individuo in rapporto al sistema sociale. La massima espressione del bisogno di individuazione è rappresentata dall’integrazione nella forma a priori di valori culturali che estendono a tutta l’umanità i diritti di pari dignità, giustizia e libertà riconosciuti e vissuti come irrinunciabili per sé. Da ciò discende che personalità individuate da quei valori possono entrare in conflitto con il sistema sociale di appartenenza e/o con il potere dominante, e, in circostanze affatto particolari, persino sacrificare l’esistenza individuale per essi.
Dialettica dei bisogni
È la tensione ago/antagonistica che, in virtù della struttura binaria del corredo genetico umano, sottende lo sviluppo della personalità, orientandola, attraverso fasi successive di conflitto, verso l’acquisizione di una coscienza morale critica che funziona come istanza di regolazione e di mediazione del debito di appartenenza sociale e dell’individuazione. La dialettica dei bisogni è assicurata da una programmazione genetica che comporta, nel corso del periodo evolutivo, l’attivazione fasica ora dell’uno ora dell’altro, con una periodicità contrassegnata dalle crisi oppositive. Tale attivazione definisce, attraverso l’entrata in azione delle forme a priori, modalità di rapporto e di interazione con l’ambiente sociale caratterizzata rispettivamente dalla identificazione e dall’armonia relazionale, e dalla differenziazione e dal conflitto. Ogni fase, consentendo l’integrazione della forma a priori di dati emozionali e cognitivi, giunge, attraverso lo strutturarsi di mappe cerebrali, a corroborare un sistema di significati più ampio e articolato rispetto al precedente, che viene posto in tensione e, in una certa misura, disarticolato dalla fase successiva. La dialettica dei bisogni procede, dunque, per catastrofi, ciascuna delle quali si risolve in virtù di una soppressione dialettica, e cioè di un’integrazione dei sistemi di significazione l’uno deputato a definire il soggetto in funzione del sistema cui appartiene, l’altro a definirne la differenziazione e la relativa autonomia rispetto al sistema a un livello di equilibrio più elevato rispetto a quello preesistente.
La dialettica dei bisogni si risolve, alla fine del periodo evolutivo, nella definizione di un’identità personale differenziata e nel contempo capace di intrattenere con l’ambiente sociale relazioni sia agonistiche che antagonistiche. Al di là del periodo evolutivo, essa promuove un arricchimento e, se necessario, una ristrutturazione sia dell’identità personale e sociale sia dei sistemi di significazione che, sotto forma di ideologia, sottendono l’autocoscienza e l’appartenenza sociale.
La massima espressione della dialettica dei bisogni, utopica poiché essa trascende le potenzialità soggettive postulando condizioni sociostoriche orientate alla valorizzazione del patrimonio genetico distribuito nei singoli corredi individuali, è riconducibile al progetto marxiano di un libero sviluppo degli individui entro un sistema sociale arricchito da quello sviluppo e capace di investire la ricchezza sociale economica e culturale a favore del sistema stesso e dei membri che ad esso appartengono.
Alienazione dei bisogni
Processo in conseguenza del quale, in una qualunque fase critica del periodo evolutivo, i bisogni vengono significati e vissuti in maniera tale che, nonché un’integrazione dialettica, si produce una scissione e un conflitto irriducibile tra gli stessi. Un bisogno, in breve, è alienato quando esso, significato alla luce di valori culturali introiettati, e che dunque rappresentano interiormente l’Altro, viene vissuto come minaccioso per lo sviluppo della personalità. L’alienazione, in rapporto al corredo genetico individuale e alle circostanze ambientali, può riguardare sia il bisogno di integrazione sociale che quello di opposizione. Nel primo caso, il bisogno alienato è significato e vissuto sul registro della fusione, della dipendenza, della sottomissione, dell’obbedienza e dell’influenzabilità; nel secondo caso, il bisogno è significato e vissuto sul registro della chiusura alla relazione, dell’autosufficienza, della ribellione, dell’opposizionismo e dell’ininfluenzabiità. Anche se, a livello interattivo, il processo di alienazione può riguardare un solo bisogno, a livello soggettivo l’alienazione di un bisogno produce inevitabilmente una significazione alienata dell’altro, il cui potenziale di attrattore giunge a configurarsi come pulsione squilibrante e regressiva. Il bisogno alienato di integrazione sociale riverbera pertanto sul bisogno di opposizione significati amorali e asociali (dal tradimento del legame di fedeltà alla follia criminale); il bisogno alienato di opposizione/individuazione connota, viceversa, il bisogno di integrazione sociale in termini di debolezza, vulnerabilità, perdita di identità.
L’alienazione e la scissione dei bisogni, determina uno sviluppo della personalità lineare e non dialettico, incentrato sul rinforzo emozionale, cognitivo ed ideologico del bisogno vissuto coscientemente come stabilizzante la struttura della personalità. In conseguenza del definirsi di un ideale dell’Io espressivo di questo solo bisogno, la morfologia della coscienza, sia sul registro dell’autocoscienza che sul versante comportamentale, si sovrastruttura ideologicamente. Cionondimeno, i bisogni, nella loro qualità di attrattori psicobiologici continuano a funzionare gravitando verso momenti catastrofici di ristrutturazione. La fenomenologia “pulsionale” dei bisogni alienati, in opposizione irriducibile, estinguendo la possibilità di conflitti evolutivi, comporta, in difetto di sistemi di significazione dialettica, il rischio di biforcazioni, che rappresentano la matrice dei fenomeni psicopatologici.
Introiezione/assimilazione
L’introiezione è il processo in virtù del quale le interazioni con l’ambiente danno luogo all’interiorizzazione di un sistema di valori culturale che funziona come codice e metro di misura del comportamento soggettivo. L’introiezione è attivata e resa possibile dai legami affettivi di identificazione che il soggetto intrattiene con figure significative: legami che, facendo leva sul bisogno di integrazione sociale, funzionano come canali che permettono la trasmissione dei valori culturali.
Pur non essendo un processo passivo, l’introiezione dà luogo ad una identità culturale che funziona, all’interno della soggettività, come rappresentanza sociale, come Super-Io culturale che impone il primato della totalità sociale sull’individuo e subordina questo ad un debito di fedeltà. I valori introiettati animano, dunque, all’interno della soggettività, una volontà alienata che rappresenta l’altro , il cui potere, fondandosi sul debito emozionale di appartenenza, è maggiore rispetto alla volontà personale. Questa condizione eterodiretta, che rappresenta una fase evolutiva necessaria nello strutturarsi della personalità, può essere superata solo in virtù dell’attivarsi periodico del bisogno di opposizione, che, promuovendo la sospensione della volontà alienata e dei valori culturali di cui essa impone il riconoscimento, dà luogo all’assimilazione, processo selettivo in conseguenza del quale quei valori vengono adattati ai bisogni personali, e cioè in parte recusati e in parte modellati in maniera tale da poter essere vissuti come espressione della volontà propria.
Ideali dell’Io
Modelli culturali nei quali il soggetto identifica la soluzione della tensione conflittuale tra i bisogni. In ambito psicopatologico, laddove il conflitto si pone in termini irriducibili, gli ideali dell’Io si configurano sotto forma di modi di essere e di porsi che comportano, per la loro realizzazione, il sacrificio, più o meno rilevante, di una delle due polarità dei bisogni. Di conseguenza, se gli ideali dell’lo sono modellati su valori che promuovono il primato della totalità sulla parte, essi comportano il sacrificio dell’individuazione; se, viceversa, essi si modellano su valori che promuovono il primato della parte sulla totalità, essi comportano il sacrificio della sensibilità, dell’identificazione con l’altro. Entrambe queste possibilità possono realizzarsi o per sottomissione del soggetto ai valori trasmessi dal gruppo di appartenenza o per ribellione opposizionistica nei confronti di quei valori. In ogni caso, gli ideali dell’Io si conformano a modelli culturali esistenti nel contesto sociostorico in cui si trova il soggetto: contesto che riconosce il gruppo di appartenenza familiare come parte di una totalità, la società nel suo complesso.
Nel primo caso, essi realizzano una fedeltà sacrificale nei confronti del gruppo di appartenenza, che spesso disadatta il soggetto rispetto al contesto sociostorico; nel secondo, essi promuovono un tradimento, funzionale alla possibilità di individuarsi attraverso l’adesione a valori culturali estranei al gruppo di appartenenza, che costantemente, per effetto dei sensi di colpa, si pone come impossibile da portare a compimento.
Gli ideali dell’Io psicopatologici sia conformistici che opposizionistici si possono pertanto definire superegoici non nel senso che essi fanno capo comunque a valori sociali (nessun soggetto potendo costruire un codice culturale privato), bensì in quanto risultano alienati, riferiti sempre e comunque ad una volontà estranea alla quale conformarsi o ribellarsi.
Struttura psicopatologica
Per struttura psicopatologica si intende un oggetto teorico, e quindi costruito concettualmente, capace di dar conto, e cioè di rendere comprensibili ed esplicabili, alcuni aspetti dell’esperienza soggettiva vissuti, sintomi, comportamenti fenomenologicamente non correlati, e che appaiono però determinati in rapporto al modo di essere e di porsi del soggetto nel mondo. La costruzione dell’oggetto teorico si fonda sul concetto di scissione dei bisogni, che implica, per effetto di interazioni con l’ambiente, un’opposizione irriducibile degli stessi, che non possono pertanto essere più significati in maniera dialettica. La scissione dei bisogni, per quanto riconosca dei correlati neurobiologici, riconducibili genericamente ad una situazione di stress, e cioè di squilibri funzionali, non può essere colta che sul piano dei significati antitetici associati al mantenersi della relazione con l’altro e al persistere dell’identità personale. Tali significati fanno capo a codici culturali che impongono un sacrificio inutile di un bisogno come prezzo da pagare per la realizzazione dell’altro. In conseguenza di ciò, i bisogni, a livello di struttura psicopatologica appaiono fenomenologicamente e complementarmente alienati: l’uno potendo essere vissuto solo secondo la ragione degli altri; l’altro risultante, per alcuni aspetti, inservibile o minaccioso (alienato, dunque nel senso di sottratto alla soggettività). A seconda del grado di coerenza dei codici culturali che presiedono la scissione dei bisogni, si danno strutture relativamente stabili e strutture relativamente fluide. La dinamica neurobiologica e psicologica dei bisogni comporta la possibilità di trasformazioni in un senso e nell’altro, nonché di destrutturazioni/ristrutturazioni progressive o critiche secondo gradienti e cioè la necessità di adattare la rete dei significati ai vissuti o viceversa.
Funzione superegoica
Funzione che codifica i contenuti dell’esperienza soggettiva e relazionale, correlandoli ad un sistema di valori che privilegia la totalità sulla parte, la relazione sugli agenti in relazione, l’altro sull’io.
Nella sua matrice viscerale, la funzione superegoica si identifica con una predisposizione filogenetica alla socialità, che programma l’individuo a riconoscersi parte di una totalità, che rappresenta, con la sua persistenza e continuità, la vita stessa. Da questo punto di vista, il codice genetico che sottende quella predisposizione veicola informazioni dotate di risonanze emotive e potenzialmente cognitive.
Ma la funzione superegoica si struttura, nel corso di ogni esperienza individuale, attraverso relazioni interpersonali e sociali che veicolano codici culturali sociostoricamente determinati. Tali codici significano l’esperienza soggettiva, fin nelle sue dinamiche più profonde, biopsicologiche, in maniera alienata: essi cioè la significano immediatamente per il soggetto, che quindi la vive, ma attraverso la mediazione di sistemi di valore che la misurano in relazione al dover essere del soggetto in rapporto all’altro (inteso in senso proprio e in senso metonimico, come rappresentante della totalità sociale).
Come nelle sue matrici viscerali, dunque, la funzione superegoica è socializzante, così nel suo strutturarsi, che comporta l’introiezione di valori culturali determinati, è alienante. Il superamento dell’alienazione, da intendersi sempre in senso relativo, è subordinato alla possibilità da parte del soggetto di oggettivare i codici attraverso cui la sua esperienza viene significata dall’interno.
Debito di appartenenza
Vissuto le cui radici sono da ricondurre ad una forma a priori emozionale in virtù del quale ogni esperienza soggettiva, dal momento in cui l’Io si differenzia, appare sottesa dal dovere di rispondere, con il comportamento, alle aspettative del gruppo di appartenenza. Tale vissuto, che dà luogo all’interiorizzazione di quelle aspettative, concorre a strutturare la funzione superegoica, le cui valenze emozionali rimangono per sempre caratterizzate dal dovere di rispondere di sé e dei propri comportamenti a qualcuno che rappresenta la totalità sociale. Il debito di appartenenza, nel corso delle fasi evolutive, si definisce attraverso l’introiezione di codici culturali che autorizzano, proscrivono e prescrivono i comportamenti idonei a pagare il debito, e ad assicurare pertanto l’appartenenza e l’integrazione sociale.
Senso di colpa/Vergogna
Vissuti, le cui valenze emozionali non difettano mai di un qualche grado di integrazione cognitiva ed ideologica, che esprimono l’attività della funzione superegoica in rapporto all’ Io. Attività correzionale e coercitiva che mira ad indurre l’Io a riparare il tradimento perpetrato o fantasticato del debito di fedeltà nei confronti del gruppo di appartenenza e dei valori da esso rappresentati, a vivere la propria inadeguatezza rispetto ad un ideale dell’Io introiettato, che sancisce quel debito, o elaborato antiteticamente rispetto ad esso. Mentre il senso di colpa, dunque è sempre riferito ad un legame sociale, reale e/o simbolico, attaccato a rischio di compromettere l’economia del sistema che esso integra e comporta dunque il venir meno del soggetto ad un “dovere essere” funzionale a quell’economia, la vergogna definisce, sotto forma di inadeguatezza, la non appartenenza del soggetto ad un sistema rappresentato dall’ideale dell’Io di cui non è degno, rappresenti il sistema il gruppo di appartenenza o il gruppo che il Soggetto, in opposizione all’appartenenza, assume come riferimento. Di conseguenza, la vergogna si può considerare sempre, anche quando sembra da un ideale dell’io onnipotente e narcisistico, una funzione del senso di colpa, che impone, in conseguenza del tradimento, una riparazione irrealizzabile, nella quale tuttavia il soggetto deve continuare a identificare la sua sopravvivenza come membro sociale.
Ideologia
Espressione di un bisogno intrinseco alla mente umana, il bisogno di stabilità e coerenza strutturale, funzionale alla necessità della coscienza di riconoscersi e di mantenere la propria continuità, nonostante il caos dei processi neurofisiologici e psicodinamici che la sottendono e il flusso di informazioni che l’attraversano, l’ideologia si definisce come visione del mondo che, integrando dati emozionali, cognitivi e culturali, assicura il modo di essere e di porsi del soggetto in un mondo storicosociale determinato, e, attraverso i sistemi di valori che la strutturano, funziona come codice di mediazione degli scambi tra soggettività e ambiente, e codice di valutazione del soggetto in rapporto all’ambiente e viceversa. Utilizzando un linguaggio attuale, l’ideologia è null’altro che un sistema di sistemi di significati, più o meno integrato a seconda del grado di contraddizione che intercorre tra i sottosistemi. Tali sottosistemi significano, utilizzando codici culturali privatizzati, la natura umana, il mondo delle emozioni, il rapporto tra emozione e ragione, e il rapporto tra soggetto e ambiente in riferimento costante a tre assi categoriali (vero/falso, bene/male, giusto/ingiusto).
L’ideologia, intesa come integrazione di tali sottosistemi, funziona come strumento di orientamento comportamentale in un mondo definito nella molteplicità dei suoi aspetti dalle mappe sottosistemiche. Il carattere concreto o astratto con tutte le possibili formule combinatorie dell’ideologia soggettiva si rileva sia dal grado (sempre relativo) di fedeltà con cui essa significa il reale tragitto di esperienza del soggetto nel mondo sia dalla sua capacità di promuovere comportamenti orientati a soddisfare dialetticamente i bisogni fondamentali nelle loro valenze psicobiologiche, preideologiche.
Codici mentali
Sono sistemi di significazione che, prodotti collettivamente, si pongono come sistemi di valore morale, che qualificano positivamente o negativamente il comportamento. Essi definiscono modelli culturali, la cui realizzazione facilita o rinforza l’integrazione sociale e la cui trasgressione si associa a minacce molteplici, più o meno rilevanti, di esclusione sociale. La loro connotazione morale, che li specifica in rapporto ad altri codici culturali (per es. il linguaggio), concerne il loro costante riferimento alla valutazione del comportamento individuale in rapporto all’ambiente sociale di appartenenza. Tale valutazione verte costantemente su criteri organizzati secondo assi categoriali (adeguatezza/inadeguatezza, forza/debolezza, potenza/impotenza, competenza/incompetenza, normalità/anormalità, conformismo/anticonformismo, elevazione/degradazione, onestà/disonestà, libertà/costrizione, emotività/controllo, ecc.) la cui qualificazione positiva e negativa dipende dalla struttura sociale totale e dall’ideologia che la sottende. La funzione propria dei codici mentali è di vincolare il comportamento soggettivo e di subordinarlo al giudizio sociale, introiettato sotto forma superegoica o reale. I codici mentali, espressione dell’ideologia sociale, rappresentano dunque scale di valutazione del soggetto in sé e per sé e nella sua rete di relazioni con il mondo sociale (dai livelli privati a quelli pubblici).
Coscienza/inconscio
Neurobiologicamente espressione di un’attività intrinseca, rappresentata dalla vigilanza, che determina un flusso di informazioni in tutta la rete interneuronica, sotto il profilo psicologico la coscienza è una funzione formalgenetica, che organizza le informazioni su due assi di significato il mondo interno e quello esterno, il sé e l’altro. In altri termini, la coscienza è null’altro che un campo semantico, strutturato da una tendenza dei significati alla stabilità, dinamico poiché le relazioni tra interno ed esterno cui essa presiede sono relazioni di scambio, e contraddittorio poiché un adattamento dei due mondi è reso impossibile dalla tensione dialettica dei bisogni. I bisogni, le cui matrici sono biologiche e la cui fenomenologia si fonda su segni codificati, rappresentano i vettori isomorfici della coscienza. Ma i codici che significano i bisogni non sono mai del tutto presenti alla coscienza. I campi semantici che essi definiscono, e su cui si fonda il comportamento culturale, rappresentano i confini della coscienza, e riverberano al di qua e al di là. Al di qua, nella coscienza, strutturano la fenomenologia dei bisogni; al di là strutturano il mondo interno, il patrimonio esperienziale soggettivo. Al di là della coscienza, si dà dunque una dimensione biologica e psicologica strutturata da significati, che possono affiorare a livello cosciente solo in proporzione alla consapevolezza soggettiva dei campi semantici e del loro valore ideologico. In difetto di tale consapevolezza, la coscienza è preda di un autoinganno referenziale, in virtù del quale la fenomenologia dei bisogni viene colta come espressione immediata e reale del mondo interno. L’inconscio freudiano rappresenta l’ideologizzazione di questa fallacia referenziale.
NOTE
Introduzione
1 Il DSM, per i non addetti ai lavori, è un manuale di diagnosi differenziale psichiatrica pubblicato negli U.S.A. nel 1980 e periodicamente aggiornato. Impostato su diagrammi di flusso, esso mira a standardizzare le procedure diagnostiche, e cioè a ridurre l’incidenza dei criteri valutativi soggettivi, legati ai “punti di vista” degli operatori psichiatrici. L’esigenza di uniformare le procedure diagnostiche è nata dalla constatazione di discrepanze epidemiologiche, da nazione a nazione, assolutamente incomprensibili. L’assenza di una riflessione critica su queste discrepanze rappresenta, in rapporto alla scientificità della psichiatria, un aspetto più importante del rimedio proposto.
2 Rose S., Lewontin R., Kamin L., Il gene e la sua mente, Mondadori, Milano 1983.
3 Delettre P., Teoria/modello, Enciclopedia Einaudi, Torino 1981
Capitolo primo
1 tutte le citazioni sono tratte da S. Freud, Opere, Boringhieri, Firenze 1977
Capitolo secondo
1 Origene, in Storia della filosofia, vol. IV, pp. 282 e Ss., Vallardi, Firenze 1975.
Capitolo quarto
1 J.J. Rousseau, Discorso sull’origine della disuguaglianza, in Opere, Sansoni, Firenze 1972.
2 P.D. McLean, Evoluzione del cervello e comportamento umano, Einaudi, Torino 1984.
3 A. Heller, Istinto e aggressività, Feltrinelli, Milano 1978, p. 175,
4 P. Karli, I comportamenti aggressivi, in «La Recherche», 1971.
Capitolo settimo
1 C. Lasch, L’lo minimo, Feltrinelli. Milano 1985.
2 J.J. Rousseau, Emilio, in Opere, a cura di P, Rossi, Sansoni, Firenze 1972, p. 353.
3 K. Marx, Manoscritti economicofilosofici del 1844, Einaudi, Torino 1970 p. 75.
4 G. Duby, Storia sociale e ideologia della società, in Fare storia, a cura di J. Le Goffe P. Nora, Einaudi, Torino 1981.
Capitolo nono
1 P. McLean, op. cit., Einaudi, Torino 1984.
Bibliografia*
*Le tematiche affrontate nel saggio dalla neurobiologia alla storia sociale richiederebbero una bibliografia sterminata. Si è preferito optare per l’essenzialità, sia pure al prezzo della parzialità. Un referente immaginario, un lettore appassionato ma non necessariamente dotto, giustifica la citazione di sole opere disponibili in lingua italiana.
ARIES P. DUBY G., La vita privata, 5 voll. Laterza, Bari 19861988.
BACZKO B., «Immaginazione sociale», Enciclopedia Einaudi, vol. 7, Torino 1979,
BARCELLONA P., L’egoismo e la follia del capitale, BollatiBoringhieri, Torino 1988.
BASAGLIA F., Scritti, voll. 12, Einaudi, Torino 1982..
BENEDETTI G., Alienazione e personazione nella psicoterapia della malattia mentale, Einaudi, Torino 1980.
BETTELHEIM B., Il prezzo della vita. L’autonomia individuale in una società di massa, Adelphi, Milano 1965.
BLOCH M., I re taumaturghi, Einaudi, Torino 1973.
BODEI R., Strategie di individuazione, in «AUTAUT», n. 206207, 1985.
BOURGUIGNON E., Antropologia psicologica, Laterza, Bari 1983.
BOWLBY J., L’attaccamento alla madre, Boringhieri, Torino 1972.
BRAUDEL F., Scritti sulla storia, Mondadori, Milano 1980.
CAMPORESI C. (a cura di), Il concetto di alienazione da Rousseau a Sartre, Sansoni Università, Firenze 1974.
CANETTI E., Massa e potere, Adelphi, Milano 1985,
CHANGEUX J.P., L’uomo neuronale, Feltrinelli, Milano 1983.
CHILDE G., L’uomo crea se stesso, Einaudi, Torino 1952.
DAL PRA M., (a cura di), Storia della filosofia, vol. 4, Vallardi, Milano 1975.
DOBZHANSKY T., Diversità genetica ed eguaglianza umana, Einaudi, Torino 1975.
EAGLE MORRIS N., La psicoanalisi contemporanea, Laterza, Bari 1984.
FEBVRE L., Problemi di metodo storico, Binaudi, Torino 1976.
FREUD S., Opere, voll. 113, Boringhieri, Torino 19671980.
GABEL J., La falsa coscienza. Saggio sulla reificazione, Dedalo, Bari 1967.
GALLINO L., (a cura di), Sociobiologia e natura umana. Una discussione interdisciplinare, Einaudi, Torino 1980.
GERRATANA V., Unità della persona e dissoluzione del soggetto, in Oltre Gramsci, con Gramsci, «Critica Marxista», n. 23, 1987.
GODELIER M., Antropologia e marxismo, Editori Riuniti, Roma 1977.
GODELIER M., «Il marxismo e le scienze dell’uomo», in Storia del Marxismo, vol. 4, Einaudi, Torino 1982.
GOLDBERG J., La colpa. Un assioma dalla psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1988.
GOLDMANN L., Scienze umane e filosofia, Feltrinelli, Milano 1961.
GURVITCH G., Trattato di sociologia, voll. 12, Il Saggiatore, Milano 1967.
HALL C.S. LINDZEY G., Teorie della personalità, Boringhieri. Torino 1986.
HARRIS M., Materialismo culturale, Feltrinelli, Milano 1984.
HELLER A., Per una teoria marxista del valore, Editori Riuniti, Roma 1974.
HELLER A., Istinto e aggressività, Feltrinelli, Milano 1978.
HELLER A., La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano 1980.
HELLER A., «L’eredità dell’etica marxiana», in La storia del marxismo, vol. 4, Einaudi, Torino 1982.
HERMANN I., L’istinto filiale, Feltrinelli, Milano1974.
HINDE R.A., Le basi biologiche del comportamento sociale umano, Zanichelli, Bologna 1977.
HOOPER J. TERESI D., L’universo della mente, CDE, Milano 1987.
JACOB F., La logica del vivente, Einaudi, Torino 1971.
JERVIS G., Il buon rieducatore, Feltrinelli, Milano 1977.
KLEIN M., Il nostro mondo adulto ed altri saggi, Martinelli, Firenze 1972.
KOJEVE A., La dialettica e l’idea della morte in Hegel, Einaudi Reprints, Torino 1982.
LAING R.D., La politica dell’esperienza e l’uccello del Paradiso, Feltrinelli, Milano 1968.
LAPLANCHE J. – PONTALIS J.B., Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, Bari 1968.
LASCH C., L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Feltrinelli, Milano 1985.
LE GOFF J. NORA P. (a cura di), Fare storia, Einaudi, Torino 1981.
LORENZER A., Crisi del linguaggio e psicoanalisi, Laterza, Bari 1975.
MAHLER M., BERGMAN A., PINE F., La nascita psicologica del bambino, Boringhieri, Torino 1978.
MARX K., Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma 1971.
MATTE BLANCO I., L’inconscio come insiemi infiniti, Einaudi, Torino 1981.
MCLEAN P.D., Evoluzione del cervello e comportamento umano, Einaudi, Torino 1984.
MILLER A., Il bambino inascoltato. Realtà infantile e dogma psicoanalitico, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
MITSCHERLICH A., Verso una società senza padre, Feltrinelli, Milano 1970.
MOSSE G.L., La cultura dell’Europa occidentale, Mondadori, Milano 1986.
OLIVERIO A., OLIVERIO FERRARIS A., L’alba del comportamento umano, Laterza, Bari 1984.
PIAGET J., Biologia e conoscenza, Einaudi, Torino 1983.
PIRO S., Le tecniche della liberazione. Una dialettica del disagio umano, Feltrinelli, Milano 1971.
POLITZER G., Critica dei fondamenti della psicologia, in Freud e Bergson, La Nuova Italia, Firenze 1970.
RAPAPORT D., Il modello concettuale della psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1977.
ROUSSEAU J.J., Opere, Sansoni, Firenze 1972.
REYNOLDS V., La biologia dell’azione umana, Mondadori, Milano l978.
RIESMAN D., La folla solitaria, Il Mulino, Bologna 1956.
ROSE S., LEWONTIN R., KAMIN L., Il gene e la sua mente, Mondadori, Milano 1983.
ROSSI LANDI F., Ideologia, Isedi, Milano 1978.
ROVATTI P.A., TOMASSINI R., VIGORELLI A., Bisogni e teoria marxista, Mazzotta. Milano 1976.
SCHAFF A., L’alienazione come fenomeno sociale, Editori Riuniti, Roma 1979.
SCHAFF A., Il marxismo e la persona umana, Feltrinelli, Milano 1966.
SZASZ T., Disumanizzazione dell’uomo, ideologia e psichiatria, Feltrinelli, Milano 1974.
TIBONCORNILLOT M., «Uguaglianza», Enciclopedia Einaudi, vol. 14, Torino 1981.
TULLIO ALTAN C., Antropologia. Storia e problemi, Feltrinelli, Milano 1983.
VINCENT J.D., Biologia delle passioni, Einaudi, Torino 1988.
WATZLAWICK P., WEAKLAND J.M. (a cura di), La prospettiva relazionale, Astrolabio, Roma 1971.
WINNICOTT D.W., Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma 1982.
WINNICOTT D.W., Dalla pediatria alla psicoanalisi. Scritti scelti, Martinelli, Firenze 1975.
